















































































































































Sabato 9 Aprile 2022. Presentazione di AlphaBeta in Jepis Bottega.



















Caro Luca, oggi il nostro amico Michele Croccia ha pubblicato una sua foto accompagnata da un breve testo, le puoi vedere in ordine:

Amici, condivido con voi questa piccola gioia. Qualcuno già le ha viste, da qualche giorno stiamo finalmente usando le nuove tovagliette personalizzate, disegnate dentro Jepis Bottega e in collaborazione con Scritte – Manufatti Narrativi, un progetto tutto cilentano. Come sempre ci piace aggiungere un po’ di magia anche qui: questa prima stampa è numerata 001 e saranno edizioni limitate e uniche. La prossima stampa sarà la 002, con altri temi e altri messaggi che gireranno attorno al mondo della Pietra Azzurra. Ci piacerebbe anche ricevere vostri pareri e suggerimenti, sia qui che di persona. Fateci sapere.
#lieviti
Michele come accade spesso ha fatto prima di me, ma la cosa naturalmente mi ha fatto piacere a prescindere, aggiungo di più, mi ha fornito il pretesto per aggiungere una piccola cosa, riguarda i quadratini che puoi vedere a destra, i QR Code, che danno la possibilità di guardare dei piccoli documentari girati da Giuseppe che hanno accompagnato il suo cammino di pizzaiolo contadino e narratore. Quello che voglio sottolineare è che sono contenuti veri, non spot pubblicitari, possono essere visti nell’attesa non solo per curiosità e per diletto ma anche per “rubarsi”, come avrebbe detto tuo nonno, un po’ del mestiere di Michele, che dice tante cose interessanti per comprendere il suo rapporto con il lievito e la pizza.
Un’ultima cosa prima di salutarti, prima della prossima uscita proporrò a Giuseppe e Michele di fare una chiamata, una call to action come dite voi, per chiedere agli amici e ai clienti de La Pietra Azzurra di proporre un video da stampare sulla tovaglietta, ad ogni nuova uscita ne selezioniamo uno e mettiamo il QR Code, ripeto, magari è una scemità, ma magari no, e in ogni caso tocca a loro decidere. Alla prossima.
Un Dio che gli esseri umani non li ha creati, ma trovati.
Dare un nome alle cose è la grande e seria consolazione concessa agli umani.
Il risultato non è che la minima parte dell’esperienza.
APPUNTI, 1942 – 1993, ADELPHI

Caro Luca, questa mattina il mio amico Michele Kettmajer mi ha inviato una mail intitolata “Un abbraccio amico mio” con l’estratto di una intervista a Dino Zoff per i suoi 80 anni, questo estratto:
A casa la colazione e il pranzo di un piccolo-grande Dino che doveva diventare «alto e forte». Raccontaci come tua nonna andava giù di uova.
Ero un po’ delicato nel mangiare, non mi piacevano tante cose e non c’era tantissimo una volta nelle dispense di casa. Allora la nonna ha cominciato con le uova e per alcuni anni viaggiavo con due o tre uova al giorno. Energia ce n’era e si consumava tanto. La gioventù dei miei tempi, è brutto parlare dei “miei tempi”, però nei paesi, c’erano spazi e possibilità di gioco. Non esisteva mica la scuola calcio. Si giocava a pallone tra amici, anche per sei ore di fila, da fine scuola fino a cena.
E a casa che dicevano?
Mio padre, da buon friulano diceva sempre «bisogna lavorare bene. Non ha importanza che lavoro fai, l’importante è lavorare bene». Poi non si parlava molto, certe cose erano “scritte” dappertutto, anche se non erano scritte. Per dire che non c’erano scuse su niente. Quando giocavo in Serie A, presi un gol e mio padre mi disse: «Ma come mai quel gol lì?». Io risposi: non mi aspettavo che tirasse. E lui secco: «Ma perché, cosa fai, Il farmacista? Se non te lo aspetti te che fai il portiere…». Aveva ragione, lavorare bene.”
È tutto figlio mio, sono stato contento, e te lo volevo dire.

Se il figlio di un operaio e di una contadina come me ha un ritratto come questo a fianco è grazie a Lui. Ha un valore immenso per me, lo dipinse alla fine di un periodo molto complicato, che poi ce ne sono stati altri, compreso quest’ultimo, inesorabile, ma forse non complicato come quello.
È stato ingegnere, autore di manuali per le scuole superiori, pittore (tanti suoi quadri belli popolano le nostre case, le nostre vite e i nostri cuori), suonava la chitarra e il piano, faceva le mousse più buone che abbia mai mangiato a Natale, era geniale, arguto, pensatore, innovatore, gentile, innamorato, a modo suo protettivo, discreto, mai banale, ma veramente mai.
È entrato nella mia vita 45 anni fa, sono tanti, anche se naturalmente ciascuno con la vita sua. Tanti i ricordi, i momenti, la bellezza, il dolore, la gioia, in alcuni momenti i contrasti, che abbiamo condiviso, io con la mia esagerazione, Lui con la sua riservatezza.
Da stamattina Lui non c’è più, da stamattina convivo con un pugno nello stomaco che fa assai male. Cerco di darmi coraggio ripetendomi che ha finito di soffrire, che soffrire per morire è la cosa più disumana che esista, che io lo so, ci sono passato con mio fratello e con mia madre, ma serve a poco. Serve a poco perché non è questione di coraggio, è questione di dolore, che quando ti sbatte addosso non lo puoi evitare, lo puoi tenere con te e basta, ci vuole tempo, e nel frattempo puoi provare a condividerlo, proprio come sto facendo io con questo inutile post.
Ciao Lui, è stato un onore.
Una storia cominciata con mio padre che mi racconta la differenza tra il lavoro preso di faccia e il lavoro a meglio a meglio, una storia che oggi è fatta di tante cose e tante possibilità grazie al mio lavoro, quello di Luca, di Jepis, di Cinzia e di tante/i altre/i ancora.
VAI AL SITO
Partiamo dagli scenari del presente per sperimentare, per scrutare i segni del tempo, per disegnare possibiltà, per immaginare e praticare il futuro.
Il 30 Aprile 2022, per il nono anno, saremo in tante/i a condividere la voglia di raccontare il lavoro come identità, dignità, diritti, responsabilità, autonomia, futuro.
Il lavoro che non è soltanto un mezzo, una necessità, ma anche un fine, una possibilità.
GUARDA I VIDEO DELL’OTTAVA EDIZIONE
VAI AL BLOG »
Che cos’è. Come si fa. Perché farlo. Chi lo può fare. Cosa succede quando si fa.
VAI AL BLOG
Racconti dall’Italia che dà valore al lavoro. Alla bellezza. Al futuro. L’Italia delle persone normali, quelle che ogni mattina si alzano e fanno bene quello che devono fare, qualunque cosa debbano fare. L’Italia che dà più valore a quello che sa e sa fare e meno valore a quello che ha.
VAI ALL’INDICE
Al tempo di internet, dell’intelligenza artificiale e della blockchain il lavoro ben fatto e l’uso consapevole delle tecnologie sono le chiavi di accesso fondamentali alla nostra autonomia, alla nostra capacità di apprendere, di fare e di pensare, alla nostra umanità.
Da questa idea è nato il progetto, che coinvolge tante belle teste ed è basato su un approccio, una metodologia e tanti percorsi didattici che hanno avuto e hanno come protagonisti insegnanti, alunni e studenti di scuole di ogni ordine e grado, dalla prima elementare all’università.
VAI A SCUOLA DI LAVORO BEN FATTO, DI TECNOLOGIA E DI CONSAPEVOLEZZA
Obiettivi: ripensare il lavoro e l’impresa a partire dalle relazioni tra maestro e allievo, teoria e pratica, mano e tecnologia, uomo e macchina.
Contenuti: storia di bottega, interviste, approfondimenti tematici, scenari.
Ideazione e direzione scientifica: giuseppe jepis rivello e vincenzo moretti.
Produzione: Jepis Bottega e #lavorobenfatto
VAI AL PROGETTO DI RICERCA
Aggiungere valore al lavoro ben fatto delle persone, delle organizzazioni, delle comunità e dei territori connettendo fare e pensare, tecnologie e senso. Con un occhio al cammino che abbiamo alle spalle e l’altro ai lavori che sono in corso.
VAI AL SITO
In collaborazione con la pagina social Caselle in Pittari, 2000 battute per raccontare la comunità che mi sono scelto come seconda casa, o forse come prima, non lo so. A condividere i miei brevi racconti compare Rocco.
VAI ALL’INDICE
a scuola di lavoro ben fatto, di tecnologia e di consapevolezza »
da 99 a cento »
i 5 passi del lavoro ben fatto »
il lavoro ben fatto – note a margine »
la notte del lavoro narrato »
lavorobenfatto cantieri »
lavorobenfatto nòva »
lavorobenfatto.org »
le storie del lavoro narrato »
parole forgiate »
scritte.blog »
storie disordinate »
1×100 »
airpol italia »
decision making »
esperimenti di narrazione »
fablab napoli »
i fiscina »
immaginazione, potere, diritti »
informare vuol dire »
leadership, etica, promessa »
lezioni napoletane »
manifesto del lavoro ben fatto »
organizzazioni »
osservatorio lavoro ben fatto »
ripensarci su »
sensemaking »
team building »
west4 »
austro e aquilone »
citarsi addosso blog »
citarsi addosso sito »
del tradimento »
bella napoli »
come si rimette insieme una nazione »
diario giapponese »
enakapata»
piazza enakapata »
il coltello e la rete »
il leader è nudo »
la casa dei diritti »
la seconda rivoluzione napoletana »
laurea.com »
rione sanità »
testa, mani e cuore »

Ci sarà prima o poi
Ci sarà, prima o poi, un Paese governato dal Re più buono, giusto e onesto che si possa immaginare. Se sarà un Paese del pianeta Terra o si troverà sulla più lontana stella, a dire il vero, non ha molta importanza. Forse si potrebbe perfino evitare di dargli un nome, dato che i nomi assai di rado rivelano il senso delle cose alle quali vengono riferiti.
Il modo in cui verrà chiamato questo o quel personaggio, tale o tale altro posto avrà insomma la sola importanza che può dirsi meritata: nessuna. Un giorno, per fortuna non lontano, colui il cui nome è Segreto, stanco delle innumerevoli generazioni di lettori che in infiniti universi avranno colpevolmente confuso il termine ed il contenuto, lascerà che il Caos avvolga e sconvolga i nomi compresi non solo in questa ma in ogni altra storia narrata, scritta, o anche solo pensata.
Non sarà un gran giorno per sacerdoti e seguaci del culto di Emon, il dio che si vuole all’origine di ogni nome. Ma per intanto una balena potrà chiamarsi Pinocchio e un burattino di legno semplicemente Moby Dick, don Qujote sarà un tormentato principe di Danimarca e Hamlet un visionario cavaliere della Mancia.
Coloro i quali, per ragioni diverse e che ugualmente ignoro, dovessero un giorno incontrare le vicende che sto per svelare, sappiano in ogni caso che i protagonisti, i fatti e finanche la maniera in cui questi si vorranno intrecciare saranno necessariamente lontani da quelli che sono soliti popolare la vita di ogni giorno.
Prima o poi, ogni cosa qui detta o anche solo immaginata sarà infatti inesorabilmente vera.
Un’isola, uno strano congegno ed un cielo con le bollicine
Gli avvenimenti che intendo raccontare avranno luogo tra il 30° ed il 40° parallelo, ad Oriente di quella che ai giorni nostri viene chiamata Fossa di Kermadec, su un’isola grande abbastanza per essere popolata da alcune decine di milioni di abitanti. Niente di più, insomma, di una delle tante macchie di terra immerse in quell’Oceano esteso per 180 milioni di chilometri quadrati che, attraversato nel 1520 da Magellano, è stato successivamente denominato, senza alcuna conseguenza sulle illimitate possibilità di ogni sua particella di acqua e di sale, Pacifico.
Per le sue caratteristiche la Cyrlandia (è questo il nome o, se si preferisce, il nome del nome, dell’isola in questione) può essere considerata a metà strada tra i Paesi in via di sviluppo e quelli cosiddetti avanzati.
La pesca, con le attività di trasformazione ad essa collegate, ed il turismo sono ovviamente le sue fonti principali di lavoro e di ricchezza.
Le speranze per il futuro sono però legate alla commercializzazione ed alla vendita sui mercati mondiali di Mikemito, il materializzatore ovulare ad alta risoluzione che consentirà di riprodurre in tempo reale, direttamente a casa propria, qualunque personaggio della televisione. La scoperta di Mikemito darà alla Cyrlandia e al professor Oid, direttore della scuola elementare nel quale è nato ed è stato sviluppato il progetto, la fama ambita e vana che dà l’avere un nome che sopravvive a sé stessi.
Le condizioni climatiche dell’isola dipendono fortemente, come del resto avviene da ogni altra parte, dallo stato d’animo della gente. Marinai e vecchi pescatori raccontano che, negli ultimi tempi, accade assai di frequente di incontrarvi, la sera, un cielo così denso di stelle da sembrare un mare con le bollicine.
Una città, un palazzo ed un architetto venuto da terre lontane
La città di Urala è la capitale del regno di Cyrlandia da quando una guerra, stupida come tutte le guerre e ancora di più, ha avuto tra le sue conseguenze, neppure tra le peggiori, la totale distruzione dell’antica Arula. La scelta di Urala è stata considerata, a quel punto, assolutamente naturale. E’ infatti qui che la famiglia reale è solita trascorrere gran parte dell’anno, in un antico palazzo dalla struttura simmetrica ma assai particolare progettato da un architetto venuto da terre lontane. Che vi si acceda da levante o da ponente, con lo sguardo rivolto ad austro o ad aquilone, ci si trova di fronte allo stesso, identico scenario: una sala d’ingresso tetragonale che, ad uno dei lati, defluisce in uno stretto andito dal quale si accede in una seconda sala, di ampiezza doppia rispetto alla precedente e così ancora andando avanti si giunge infine in un immenso salone dal quale è possibile accedere al piano superiore, riprovevole e inutile specchio della vanità di un uomo.
Matto Curiel e l’importanza delle piccole cose
Matto Curiel è un re assai rigoroso, riservato, assai poco incline al lusso e agli sfarzi. L’esatto contrario di Re Acici, il sovrano dell’isola vicina, famoso per le feste alle quali accorrono nobili di ogni tipo e da ogni parte del globo, famigerato per i forzieri perennemente vuoti e le tasse con cui è solito perseguitare i malcapitati sudditi.
Perfino nella magica terra di Bula Matari, dove vivono curiosi esseri condannati a possedere la memoria delle vite precedenti ed il presagio di quelle future, si parla di Matto come di un sovrano dalle doti molto particolari. Sembra che non perda occasione per dimostrare il suo rispetto per le leggi e per le regole e che possieda la grandezza di chi conosce l’importanza delle piccole cose, quelle che anche tra le persone comuni fanno la differenza. Nonostante i tanti cortigiani disposti, pur di compiacerlo e di giustificare i propri privilegi, a chiudere un occhio o a fare uno strappo alla regola, non c’è in tutta l’isola chi possa affermare in buona fede che egli approfitti della propria condizione di Re.
La cosa è considerata da tutti assai poco ordinaria. In fatto di cultura ed osservanza delle leggi in Cyrlandia c’è infatti ancora tanta strada da fare e perfino i governi insediati dal padre e prima ancora dal nonno di re Matto hanno lasciato molto a desiderare in quanto ad onestà e competenza.
Ruberie si sono succedute a ruberie, gli uomini migliori sono stati sovente emarginati ed i soli ad aver incrementato le proprie fortune sono stati gli amici dei potenti o, al massimo, gli amici degli amici dei potenti. Si racconta che perfino tra i membri della famiglia reale ci sia stato chi non sempre ha saputo mantenere un comportamento esemplare e quel che è certo è che agli stessi re Darol e Rodal, nonno e padre di Matto, non sono state risparmiate osservazioni e critiche. Naturalmente, non c’è stato bisogno e tanto meno occasione che esse fossero riferite direttamente alle azioni delle loro regali persone. Per l’arbitrario giudizio del popolo è stato più che sufficiente l’aver tollerato che il Paese diventasse terra di conquista per impostori di ogni tipo.
Nasce una stella
Con l’ascesa al trono di Matto Curiel inizia il tempo delle novità e dei cambiamenti. Rinnovando una tradizione di cui si era persa memoria egli annuncia la volontà di assumere personalmente la guida del governo e non trascorre molto tempo prima che le sue doti, unite alla capacità di stimolare ed attrarre le intelligenze e le competenze migliori dell’isola, diventino proverbiali.
Studiosi e scienziati della politica, che anche in Cyrlandia sorgono più numerosi dei funghi, fanno a gara per annunciare, ossequiosi e festanti, la consacrazione del nuovo leader mentre i direttori di quotidiani e reti televisive, interpellati telefonicamente dai cittadini nel corso di periodici sondaggi, sono per una volta rispettosi della verità ed affermano che non si vedrà Re migliore di lui per molti secoli a venire.
Per quanto possa sembrare paradossale, i soli che sembrano avere ragionevoli motivi di malcontento sono la moglie e i figli del re che, come si può immaginare, hanno ben poco tempo per godersi quello che per loro è pur sempre prima di tutto un marito ed un padre.
La questione non è di poco conto. La mancanza di tempo sufficiente da dedicare ai propri familiari è per re Matto un cruccio costante. Giorno dopo giorno egli sente i suoi giorni farsi più brevi e spesso neanche la notte riesce ad arrestare il dominio del dovere.
Certo! Ci sono occasioni nelle quali, ad un re, non è data altra scelta che impegnare se stessi senza riserve. Ma nonostante re Matto non intenda di certo venir meno al proprio destino, c’è chi giura che in taluni momenti appare vinto da una malinconia inesorabile come l’acqua che scorre tra le rughe dei sassi.
Urala, la Cyrlandia e la voglia di riscattare i propri errori
Le probabilità che l’isola riprenda la marcia verso un futuro migliore sembrano dunque inevitabilmente destinate ad aumentare ed i più ottimisti non esitano a sostenere che in un giorno non lontano Urala diventerà talmente grande da eguagliare un ricordo, quello dell’antica Arula.
Progressi evidenti vengono conseguiti in molti campi ed attività mentre le strade, i musei, le chiese delle più importanti città dell’isola ridiventano meta di visitatori e turisti provenienti da ogni parte. In men che non si dica, la Cyrlandia diviene agli occhi di tutti un Paese capace di riscattare i propri errori. E, forse, ancor più del fascino e della magia dell’isola, è proprio questo ciò che desta maggiore ammirazione e stupore.
Il tanto lavoro sembra dunque produrre risultati positivi e più d’una buona ragione consiglia di essere soddisfatti.
Trascorrono così, in fretta e tutto sommato felici, i primi nove anni del regno di Matto Curiel.
Un giorno come gli altri
“Non serve che sia diverso dagli altri il giorno in cui nulla sarà più come prima”.
I bambini della Cyrlandia amano molto ripetere questa frase quando la sera raccontano le favole ai propri nonni. La ritengono infatti molto più sincera del tradizionale “vissero tutti felici e contenti” e pensano che possa essere di aiuto nella preparazione ai grandi cambiamenti che attendono i loro bianchi compagni di gioco.
Ma la saggezza che ci è compagna sempre da bambini e qualche rara volta da vecchi, è solita svanire nella cosiddetta età della ragione e Matto non sa che è solo un giorno uguale a tanti altri quello nel quale decide che, per una volta, a Palazzo dei Serpenti, sede del governo, dovranno fare a meno di lui. Si sente stranamente assorto, avvolto in quei pensieri densi che gli affollano la mente ogni qualvolta viene lasciata, incessante e inquieta, libera di andare. La periodica, impercettibile, inconfondibile contrazione delle labbra lo avverte che molto presto il turbamento si farà smarrimento e infine angoscia, dolorosa e ineluttabile compagna di ogni cambiamento.
E’ già da un po’ che vaga assorto tra porte e stanze del palazzo quando si ritrova nello studio ceruleo del piano superiore, dove custodisce gelosamente libri, oggetti e ricordi.
Tra i vetri spessi della finestra una casa rossa, il mare, tante e colorate vele. Più in fondo, una nave ancora opaca, silenziosa, pare staccarsi di malavoglia da lì dove cielo e mare si confondono. Ma ora, per lui, non esiste altro che il vorticoso scorrere dei propri pensieri. E quasi non si accorge dell’arrivo di Alvirea.
La regina Alvirea
La regina nutre per lui quell’amore raro che né il tempo né le difficoltà riescono ad affievolire. Sarà perché il re riesce ad essere in ogni momento tanti uomini diversi o per la contingente fatalità che spinge ciascuno a dare un nome e un volto al suo bisogno di amare l’intero universo, sta di fatto che ella riesce a comprenderne fino in fondo lo stato d’animo, i sentimenti, le ragioni.
Questo non le impedisce ovviamente di sostenere, quando occorre persino con veemenza, le proprie opinioni. E anche per quanto riguarda intuito ed esperienza le resta ancora poco da imparare. Sa bene, ad esempio, che in certi momenti non può far altro che attendere. Attendere che il suo Matto emerga anche solo un po’ dalle onde del proprio pensare e si decida finalmente a parlare. E, con gli anni, ha imparato ad attendere senza impazienza, a rispettare tempi e silenzi a lei poco cari.
Cose degne di un re
“Basta avere occhi per vedere e voglia di capire per rendersi conto che i cambiamenti che, a prezzo di tanta fatica, siamo riusciti a realizzare, incidono a malapena sugli aspetti più superficiali della cultura e dei modi di vita del nostro popolo.
E’ come se i guerrieri che più di mille secoli fa combatterono Sam-Sa, il drago della grande palude, si fossero accorti ad un tratto che né i valorosi colpi, né l’aspro ferro delle loro spade, sarebbero mai valsi a conquistarne il cuore.
Proprio così. So che la trasformazione delle coscienze è la sola cosa concreta veramente degna di un re eppure ogni giorno che passa la speranza di rendere migliore la nostra gente mi appare più vana”.
Come ogni volta, non è facile, per la regina, trovare gli argomenti e le parole giuste. Per un attimo pensa, forse sa, di poter dare un senso all’inquietudine che dal re sembra spandersi nell’aria. Poi quel senso svanisce, si confonde dissolvendosi tra mille altre possibilità. Lei non vinta ancora lo insegue, quasi lo riafferra, lo riperde.
Intanto, al di là dei vetri, nient’altro che la casa rossa, tre colpi di sirena e il mare.
Il valore delle ragioni pubbliche
“Credo che dovresti mostrare maggiore rispetto per te stesso e per le cose che stai cercando di fare. Le aspettative che hai generato diventano ogni giorno che passa, grazie innanzitutto al tuo impegno, cose concrete. E per le strade, tra la gente, si respira finalmente aria nuova.
Attento a non dimostrarti meno saggio del tuo stesso popolo, marito mio: nove anni sono un tempo breve e ad inseguire risultati straordinari si può finire preda della presunzione. Da te i cyrlandiani si aspettano quel buon ordine che permette nel tempo di ottenere libertà, diritti, equità, benessere e non certo lo stravolgimento delle loro coscienze”.
Di nuovo il silenzio. E il volto di Alvirea che tradisce la soddisfazione di non aver rinunciato al proprio modo di pensare, di sentire, di essere. Se, nonostante un destino segnato, aveva deciso di laurearsi con una tesi sul valore delle ragioni pubbliche secondo un filosofo di antenati celti, era stato anche perché alla sua naturale attitudine a fidare nel diritto e nella giustizia aveva voluto dare radici, profondità.
Ora, nel silenzio, i suoi occhi si muovono veloci in cerca di indizi che le rivelino l’effetto delle parole appena pronunciate.
Bambole, ritratti e racconti
Come già scritta, magari in quella commedia di Ranbaldo de La Cerca che il re, per estremo amore, ha imparato a memoria, giunge, inequivocabile, la risposta.
“Cara Alvirea, se pensi che le mie parole o il mio tormento nascano dalla voglia di inseguire un potere ancora più grande di quello che ho, mi fai un inutile torto. La gloria che con troppa generosità mi è già stata concessa mi è ormai di tale peso da rendermi completamente insensibile al fascino seducente e corruttore che essa emana. Avrei da tempo rinunciato agli onori che spettano al capo del governo nonché, come è naturale, ad ogni altro incarico pubblico, se non fosse che non mi riesce di lasciare le cose a metà o, peggio ancora, appena avviate”.
“Non nego certo l’impegno, né i risultati che esso ha contribuito a determinare, ma so che ogni cambiamento, per essere duraturo, deve rappresentare per ciascuno un bisogno, e non un dono. Di tutto questo, per quanto mi sforzi, non vedo traccia. Da qui il mio tormento. So che il destino che io stesso mi sono dato e che ancora sento indissolubile attende di essere compiuto. E so che non è più il mio”.
Così dicendo, Matto si dirige verso la credenza nella quale custodisce le 21 opere che ritiene destinate a durare oltre ogni tempo.
Per la verità, non c’è cosa in questa stanza alla quale egli non si senta legato profondamente. Le preziose bambole di un artigiano saggio quasi fino alla follia; i ritratti di un pittore sud europeo vissuto in due diversi millenni; il leggio sul quale è solito poggiare il volume che per ultimo sta leggendo.
Tra tutte le cose, quelle che più ama sono proprio i libri. E tra tutti i libri, quelli riposti in questa credenza che alcuni artigiani cinesi avevano voluto donargli nel corso di un suo viaggio.
La mano afferra sicura i racconti scritti da un uomo dagli occhi spenti nato in quella parte d’America che centinaia di milioni di anni prima formava, con l’Oceania, l’Antartide, l’Africa e l’India, il supercontinente chiamato Gondwana. Vi si narra di tigri, labirinti e sogni. Forse è perfino naturale che adesso egli pensi a se stesso come a un uomo perso in un labirinto. E la maniera in cui stringe tra le mani quei racconti svela l’inutile speranza di trovare lì il filo in grado di condurlo fuori dal buco nero in cui si sente cacciato.
Poi, ancora una volta, è quel mare mai fermo a catturare la sua attenzione: quando finalmente si volta verso la propria sposa negli occhi non ha che confusione, sgomento, tempesta.
Il Libro dei Mutamenti
I minuti scorrono lenti e neppure Alvirea appare in grado di rompere quel vano, immobile tergiversare. E’ quando la voglia di non farsi sfuggire una così importante occasione prende finalmente il sopravvento che la regina sente di non avere che una sola, illimitata, possibilità.
Lo scaffale è ancora quello precedente, il punto preciso appena due tomi più in là. Una copertina verde chiaro sulla quale è inciso in oro un disegno che, senza essere ascrivibile ad alcuna lingua comunemente parlata, riproduce una divinità: è l’I Ching, il Libro dei Mutamenti, il più antico testo di saggezza cinese. Alvirea sa che nel corso degli anni esso è diventato per Matto una essenziale, meravigliosa fonte di conoscenza e lei stessa ne ha più volte verificato le straordinarie qualità filosofiche oltre che divinatorie.
Preso il libro dal casellario, lo svolge dal drappo di seta rossa nel quale è scrupolosamente custodito e mentre con mano sicura ne scorre le pagine e i segni, inizia a parlare.
L’importanza di conoscere se stessi
“Ricordi? Quando per la prima volta mi hai parlato di questo libro infinito mi hai detto dell’insistenza con la quale in esso viene sostenuta l’importanza di conoscere se stessi. Credo che tale insegnamento dovrebbe esserti in questo momento di grande aiuto. Se è vero, come tu stesso hai riconosciuto, che la tua mancanza di serenità è figlia del conflitto tuttora aperto in te, l’impazienza non può che arrecarti ulteriore danno. Lascia che il tempo ti aiuti a diradare le foschie ed ogni scelta si farà semplice perché in armonia con il senso di tutte le cose. Solo chi trova se stesso può sperare davvero di scoprire ogni cosa al di qua e al di là del cielo e delle stelle”.
Un provvisorio silenzio accompagna gli occhi della regina mentre si posano sul libro aperto laddove la combinazione di linee intere e spezzate forma l’esagramma Hsu, che nella lingua dei Cyrlandiani può essere tradotto come l’Attesa, il Nutrimento.
“Come Ch’ien (il Creativo, il Cielo) di fronte a K’an, (l’Abissale, l’Acqua) devi dimostrarti capace di non agire precipitosamente e di saper attendere il momento per te più propizio. L’affanno di chi pensa di piegare il futuro alla propria volontà è del tutto inutile e ciò che infine dovrà essere sarà soltanto per chi, nel tempo dell’attesa, saprà fare più forte il proprio corpo e l’animo”.
Coincidenze, varchi ed un vecchio chiamato Ch’eng Tzù
Matto appare sinceramente colpito da quella che avverte come una testimonianza di saggezza e d’amore assai rari. Egli ha imparato da tempo che quelle che chiamiamo coincidenze sono varchi aperti verso nuove possibilità e la sua mano è sicura quando cerca il piccolo scrigno nel quale conserva le monete di bronzo che qualcuno lasciò tra le sue coperte di bambino la notte in cui sognò di un vecchio chiamato Ch’eng Tzù.
Ken e Chin
Sei volte le monete incontrano l’aria e il legno prima che la fatale coincidenza di linee tenere e solide, chiare e scure, riveli l’inconfutabile sentenza.
Due linee tenere e fisse al primo e secondo posto ed una solida e mobile al terzo; ancora due linee tenere, l’una mobile al quarto e l’altra fissa, al quinto posto, ed una linea solida e fissa al sesto: è Ken, il segno della Quiete, dell’Arresto, che l’azione delle due linee mobili trasformerà in Chin, il Progresso.
Presto o tardi, uomini di ogni tempo e luogo potranno leggere, nella sezione diari di una qualche polverosa biblioteca, le parole con le quali Matto Curiel riassume i saggi consigli del Libro dei Mutamenti.
“Nel tempo della quiete e dell’arresto la fine di ogni cosa si collega con un nuovo inizio. Le cose non possono muoversi continuamente, occorre ad un certo punto saperle fermare. Muoversi e fermarsi al momento giusto: così quiete e moto sono in armonia con il senso della vita e con l’intero universo, così la luce potrà illuminare la vita dell’uomo saggio”.
“L’esagramma Chin rappresenta invece il sole che si leva sopra la terra ed è quindi l’immagine del progresso rapido e facile: l’uomo che sa essere libero da ogni gelosia e sa controllare la sua capacità di influire sugli altri è destinato a raggiungere grandi mete”.
L’Aula della Diffusa Conoscenza
Sono trascorse poche settimane ed il Re è decisamente di buonumore. Per le dieci e trenta, il protocollo prevede la visita alla scuola elementare diretta dal professor Oid e l’insolita facilità con la quale riesce a liberarsi di guardie del corpo e auto al seguito sembra voglia preannunciargli la giornata molto particolare.
La vecchia seicento multipla impiega poco più di un’ora per condurlo a destinazione e nell’Aula della Diffusa Conoscenza già da qualche minuto gli echi rincorrono, confondendole, voci e grida, quando un rispettoso battimani sottolinea il suo arrivo.
L’efficienza del professor Oid e dei suoi collaboratori appaiono subito evidenti. Persone e cose sono infatti come naturalmente al proprio posto. Bambini inseguono bambini, e treni, palloni, pupazzi, automobili e soldatini di ogni tipo; genitori cercano risposte nelle domande di altri genitori; maestri confrontano esperienze condivise.
Bastano pochi banali colpi di tosse del professor Oid perché un nuovo ordine sostituisca quello precedente; al Mc Person 027 portatile ed alla solerzia di un alunno della ottava zeta si deve invece il resoconto puntuale dell’incontro. Nulla di ciò che si dirà, che già è stato detto, andrà dunque perduto.
Il professor Oid
Come sempre, Oid si limita all’essenziale. Poche parole di benvenuto all’illustre ospite, una sintetica esposizione delle ragioni che hanno ispirato l’incontro e degli obiettivi che si intendono raggiungere, l’illustrazione, appena un po’ più argomentata, delle regole secondo le quali esso si svolgerà.
Ciascun alunno ha tre minuti a propria disposizione per fare domande, formulare richieste, suggerire proposte. Al re vengono invece assegnati, in quanto adulto e per questo meno dotato, sette minuti per ogni intervento o risposta. Ad Oid il compito di coordinare la discussione mentre genitori e insegnanti si preparano a seguire la lezione con l’attenzione necessaria: occasioni così non capitano tutti i giorni ed essi sono intenzionati a trarne il massimo profitto.
Per molte ed interessanti ore il confronto percorre i sentieri più disparati, a volte approfondendo questioni note, altre affrontando argomenti inesplorati. Oid riesce a districarsi con notevole maestria anche nel ruolo per lui non certo abituale di moderatore e Matto riscuote significativi apprezzamenti per la sincera attenzione con la quale ascolta tutti gli interventi e per il diligente impegno con cui evita le banalità e le affermazioni troppo perentorie.
Sono già passate le ore più calde del pomeriggio e gli ultimi due nomi evidenziati sulla lavagna luminosa testimoniano l’ormai vicina conclusione della giornata quando gli eventi decidono di prendere tutt’altra direzione.
Pensieri, cose vere e un Mc Person 027
“La parola all’alunna Nicola Pontenegro, della sezione telecomunicazioni”. La voce del professore, che la stanchezza non sembra scalfire, rimbalza ancora una volta squillante tra le pareti dell’aula.
Né alta, né piccola, di età compresa tra i dieci e dodici anni, con quel nome un po’ buffo, un corpo rotondo e due occhi luminosi ed allegri, Nicola emerge d’un tratto dalla quarta fila. A vederla, non sembra patire alcuna emozione: lo sguardo alto, il passo sicuro, il timbro tranquillo durante i saluti di rito. Ma sono proprio le sue parole a segnare quello che gli avvenimenti susseguenti renderanno un giorno fatidico. Colui che prima o poi, presto o tardi, ritroverà da qualche parte il Mc Person 027 potrà leggere le seguenti testuali parole:
“Come ogni giorno anche stamani, venendo a scuola, mi sono fermata per qualche minuto in via degli Illuministi per ammirare la vetrina del negozio di giocattoli dei signori Boll e Strike, quando mi sono sentita chiedere: Nicola, perché? Al mio fianco, un uomo di circa cinquant’anni che, dedita com’ero ad osservare maschere e giochi, non avevo sentito arrivare. Ero sicura di non averlo mai visto prima: me lo confermavano lo strano accento da forestiero e un’eleganza d’altri tempi”.
“Probabilmente, avrei dovuto salutarlo e venir via ed invece, superando il forte imbarazzo, gli ho chiesto a mia volta: perché, cosa?”
“Con gli occhi stanchi e una tensione che il vibrare della voce rendeva evidente ha iniziato a parlare di un sogno di nove mesi prima, di un fiume dai colori luccicanti, di me e di lui a caccia di pesci e di pace. Ad un tratto, come per gioco, mi aveva chiesto quand’è che una cosa può dirsi vera e con non poco stupore mi aveva sentito rispondere . E allora, stavolta per davvero, mi aveva chiesto perché gli uomini non riescono a pensare la felicità. Ma, intanto, di me già non c’era più traccia”.
“Da allora, per nove mesi lunghi come nove vite, non aveva fatto altro che cercarmi in ogni parte del mondo e adesso che mi aveva ritrovata reclamava la sua risposta”.
“L’angoscia si era già impadronita di me quando improvvisamente il sole è scomparso tra i tetti e, con lui, il mio misterioso compagno di sogni”.
“E’ tutto il giorno che ripenso a quanto mi è accaduto e più passano le ore, più la paura svanisce e sento la sua inquietudine farsi mia. Perché dunque gli uomini non pensano la felicità?
Spero che tu che sei un re possa aiutarmi a trovare una risposta”.
Nicola Pontenegro, la felicità e il Sognatore Sconosciuto
Come è noto, tutto ebbe inizio quando gli dei presero a giocare con quelle enormi palle piene di energia e sentimenti: ad ogni scontro un’esplosione, ad ogni esplosione una nuova creazione. Fu la più straordinaria, divertente sassaiola di ogni tempo e non ci fu dio o dea che non ne rimase soddisfatto.
Solo per puro caso, un bel po’ di tempo dopo, qualcuno si accorse che, per quanto la si cercasse, non c’era traccia di civiltà.
Cominciare a domandarsi mille per come e altrettanti perché non era certo da dei. Essi si limitarono perciò a cercarla incessantemente ed in ogni luogo fino a quando, tanti e tanti anni, tante e tante ricerche dopo, non la trovarono negli occhi di un bambino. E da quel giorno i bambini godettero in ogni paese di grande considerazione.
Non c’è dunque da meravigliarsi se l’eco suscitata dalle vicende di Nicola è davvero enorme.
Con l’aiuto del potente Orange 7978 in dotazione alla questura viene tracciato un perfetto identikit del nostro uomo ed avviata una meticolosa ricerca in ogni parte dell’isola, mentre la curiosità e l’interesse della popolazione diventa, come del resto era inevitabile, ogni giorno più grande.
Scienziati e filosofi che, come è noto, non hanno mai smesso di domandarsi se la felicità esiste, perché non siamo felici e come fare per esserlo per sempre, non sembrano stare nella pelle per questa nuova ondata di celebrità. Per qualche tempo, infatti, non ci sarà cosa che possa esistere se non in funzione della conquista e della negazione della felicità.
Difatti, per le strade della capitale non si fa altro che parlare di Nicola Pontenegro, del suo strano racconto, di colui che i media hanno prontamente denominato il Sognatore Sconosciuto.
Ad essi sono dedicate le prime pagine di tutti i quotidiani e dalla più importante rete televisiva nazionale vengono trasmessi ogni giorno telefonate ed appelli. Si dice siano stati prodotti film e serial tv, editi libri e riviste. Di certo sono stati realizzati sondaggi.
Da dove giunge il Sognatore sconosciuto? Ritroverà la piccola Nicola? E perchè gli uomini non pensano la felicità?
Computer, ragazzi e storie a metà
Come ogni sera, Rien 11285E, il computer cantastorie, si interruppe di colpo. Se si dimostrò una sera assai singolare non fu dunque colpa degli eventi. In quell’intreccio di spazio e di tempo chiamato Net non c’era infatti ragione di pretendere, e neanche solo di sperare, che i destini di Matto Curiel, di Nicola Pontenegro, del Sognatore Misterioso o del professor Oid fossero in qualche modo svelati.
Ben altre conseguenze ebbero i sentimenti. Diversamente da ogni altra sera, gran parte dei buchinelcielodaiqualifiltralalucedell’infinito addensati nella piazza della Memoria non riuscì infatti a nascondere la delusione e men che meno il malcontento.
Di una situazione tanto ingarbugliata i più vecchi ricordavano un solo precedente: fu la volta che le sorti di un glorioso impero furono sul punto di dipendere dalla sfida senza senso tra due uomini che la magia di un re scrittore consentì di chiamare Napoleone e Kutuzov.
Agli occhi dei più giovani il tutto appariva invece per davvero incomprensibile. In particolare Rik Cardo, il più piccolo del gruppo, non la smetteva di domandarsi come fosse possibile che in quel posto dove tutto funzionava a meraviglia, dove fin dal principio non veniva tollerata la minima imperfezione, il cantastorie potesse continuare a sfornare storie a metà senza essere inviato alle officine riciclaggio o, meglio ancora, ai reparti di produzione energetica.
“Le domande che non si rispondono da sé nel nascere non avranno mai risposta” gli fece Carlo S. Akfak, estroverso e riccioluto amico del cuore. “Ho visto uomini spendere una vita intera a cercare la felicità. C’è chi l’ha inseguita in una balena bianca, chi nella scoperta di un mondo nuovo. Chissà che a noi non tocchi trovarla in una favola narrata per intero”.
Di altri discorsi non si ebbero notizia. Né di ulteriori proteste. Ma da allora gli specchi di Net restituiscono ombre piuttosto che immagini.
Cose di un altro mondo
Come ogni sera si tolse i chip ad uno ad uno e li ripose con cura, ciascuno al proprio posto. Erano i rari momenti nei quali quasi rimpiangeva il suo mondo, dove quelli come lui potevano tutto solo a volerlo. Era un ben strano mondo, nel quale non aveva esitato ad inventare personaggi ed intrecci di ogni tipo. E in ogni tempo.
Re e Faraoni, Cesari e Imperatori, Generali e Condottieri di quella parte non proprio piccola di universo erano per gran parte opera sua. A volte intrepidi, altre sanguinari, avevano tutti il difetto di non imparare mai niente. E le loro storie finivano inevitabilmente col finire tutte allo stesso modo.
Per questo, nonostante la fatica e gli anni, in fondo non gli dispiaceva essere approdato su quel pianeta fatto di quelle strane cose chiamate bit e chip.
Sembra fossero il segno di una nuova era anche se a dire il vero per lui erano poco più che parole tronche. Proprio come le storie che gli piaceva raccontare.
Metti una sera Parole Forgiate a Skenai Impresa Sociale.
Le foto sono di Giuseppe Di Stefano.
Se vuoi leggere l’articolo clicca qui.













di SALVATORE VECA
* Intervento conclusivo di Salvatore Veca alla presentazione del libro Dell’Incertezza, edito da Feltrinelli, tenuta all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nel 1997
Che dire giunti a questo punto? Forse due o tre cose di cui sono certo.
La prima è la gratitudine nei confronti di chi ha promosso questa iniziativa, nei confronti di chi l’ha ideata, e l’amicizia e il riconoscimento dell’impegno che c’è stato nel prendere sul serio questo mio libro e nell’interagire.
La seconda cosa di cui sono certo, ne ha parlato Sebastiano prima, è che io presentai qui, nelle “Cinque meditazioni filosofiche”, era l’ottobre del ’91, alcune delle idee da cui è nato questo libro. Esse in realtà sono rimaste tali, forse un po’ complicate dal lavoro di questi sei anni, e sono quindi molto felice, in senso non formale, di essere qui. Al di là del mio amore proustiano per Napoli e del mio legame biografico e personale con questa città, l’Istituto per gli Studi Filosofici e altri grandi istituti di Napoli costituiscono quella cerchia stabile di riconoscimento di cui parlava Maffettone.
Il terzo tipo di cose di cui sono certo è che voi siete persone molto gentili e pazienti, che avete ascoltato interventi molto impegnativi.
Proprio per questo ho il terrore adesso di essere sadico. Non svilupperò quindi repliche in modo analitico rispetto a quello che è stato detto. Cercherò di prendere spunto da alcune delle cose dette per fare un commento, e nel fare questo cercherò di dire che cosa è sembrato a me di fare facendo ciò che poi sta nelle letture che altri danno e che altri ancora daranno di questo tentativo filosofico.
Comincio con l’esplorare l’incertezza. Moretti ha colto alcuni punti che per me sono fondamentali. Uno dei punti fondamentali è esattamente quello della connessione. Questo libro qui, Ocone ha in un certo senso ragione, è “un libro di una vita”. Spero per la verità di farne altri due o tre, ma c’è un punto, una pagina del libro in cui presento le dieci proposizioni connesse, che sono quelle che chiamo i miei punti di riferimento sicuro nell’ambito del vagabondaggio e delle meditazioni.
Questa è un po’ l’idea che ho sempre avuto per un luogo letterario che mi ha sempre affascinato da ragazzino, che è la scena dell’evocazione delle madri nel secondo Faust, in cui Mefistofele, parlando a Faust del luogo delle Madri, il luogo dove queste tessono fili, dice: “Questo è il luogo della Gestalt und ungestaltung”. E con questo spero di non essere più accusato di fare solo cose inglesi o americane !
Io vengo come educazione filosofica dalla filosofia tedesca, dalla fenomenologia di Husserl. In questo senso dico che le mie meditazioni sono antihusserliane, perché sono convinto che il grande divorzio avviene sugli stessi tipi di questioni, non su questioni diverse, quando abbiamo da un lato la risposta di Frege e poi la risposta di Wittgenstein, e dall’altro l’eroico tentativo di Husserl.
In questo senso le mie si chiamano meditazioni in omaggio, per gratitudine filosofica, verso le Cartesianische Meditazionen di Husserl, o le Meditationes Parisiennes di Husserl, e in questo senso sono anticartesiane, così come sono anche antiplatoniche, anche se naturalmente uno che fa filosofia non può che essere grato a Platone se fa filosofia dalle parti che noi chiamiamo occidentali. Se invece è confuciano sarà deferente verso Confucio.
Quando ho pensato questo libro, in realtà ero perseguitato da un’idea che ho da molti anni. Volevo scrivere un libro che ho inseguito per molto tempo, che si chiamasse “Nodi”. E’ un’idea nella quale c’è molta autobiografia, ci sono vari registri di lettura, e, come mi diverte ricordare, molti miei amori: per la filosofia, per le persone, per le donne. Avevo allora una fidanzata che mi portò da Londra “Knots” di Lange, un libro molto divertente. Era buffo che fossi innamorato assieme di lei e dell’idea di scrivere un libro che si chiamasse “Nodi”, un libro che fosse basato sull’idea di trovare dei punti di intersezione, delle matrici sostanzialmente comuni. Si tratta dunque di una mia vecchia mania, in questo senso kantiano trascendentale, come diceva Sebastiano. Quando questa ragazza, una ragazza molto affascinante, mi portò “Nodi” mi dissi: “Fantastico!”. Ero convinto di scrivere subito quel libro e invece, finito quell’amore, finì anche il tentativo di scrivere “Nodi”. Ma è rimasta questa idea delle connessioni.
Moretti ha perfettamente ragione sulla questione. In un certo senso (provo a dirlo così) almeno uno dei punti intorno a cui ruota continuamente la ricerca, i cui esiti sono presentati qui, è una idea molto semplice. Alla quale sono arrivato da più parti. L’intero libro l’ho costruito a partire da più parti. Alcune cose sono artefatte, lo riconosco, ma rientrano nella educazione alla comunicazione. Altre sono profondamente sincere.
Le cose si sono svolte più o meno così. Partivo da un tipo di problema e finivo per trovare una certa fisionomia dell’argomento, una certa forma, nel senso in cui Dalisi parlava di forme. (Gli argomenti hanno delle forme, hanno delle gestalten, hanno certe strutture). Il mio problema originale, era quello che io chiamo “della conversione continua di un mondo non nostro in una realtà condivisa”. Questo vale nella scienza, nell’etica, nella politica, nei linguaggi dell’arte, e vale quindi per quanto attiene ai nostri modi di fare teorie su “ciò che vi è”, sui nostri modi di fare teorie su “ciò che vale”, sui nostri modi di fare e rifare teorie su “chi noi siamo”.
Sono partito da qui per ritrovarmi con domande molto semplici. Uno dei registri fondamentali del libro è quello su “che cosa è importante”, cioè sulle gerarchie di importanza. La mia idea è che l’importanza è connessa, come tutti sanno, basta pensarci su, semplicemente all’esperienza di perdita, reale o virtuale che sia.
Perdi una persona a cui sei stato molto legato, e dopo dici: “Quella persona contava molto per me!”. Se uno fa l’esame della propria vita e dice: “Chi ha contato nella mia vita?”, cos’è che fa? Sottopone a una variazione rispetto alla stabilità, in cui non ci poniamo grossi problemi se una persona è più o meno importante per noi, la torce e a un certo punto, vedendo chi supera la prova, scopre chi è più importante di chi.
Naturalmente nelle nostre vite possiamo variare la metrica. Può darsi che per me a quindici anni, o che per me a cinquant’anni o che per me a settant’anni, ci saranno riattribuzioni di peso e di importanza, così come ci sono persone particolarmente coerenti, non sempre è una virtù, che continuano ad avere la stessa metrica per lunghi tratti di vita.
Ma perché siamo tipi che fanno teorie? La risposta è semplicissima. Facciamo teorie quando qualcosa non funziona, quando abbiamo qualche grattacapo. Il mio argomento non è affatto originale. Basta leggere Platone e Aristotele in proposito. Che cosa vuol dire che qualcosa non funziona? Non banalmente che vi è incertezza (quella c’è sempre), ma che si altera la partizione tra l’ammontare di certezze di cui disponiamo in diverse arene, in diversi ambiti. Prendi certezza, vai a partizione 1, poi fai incertezza partizione 0. Spostandoti tra 0 e 1, vai nei casi medi. Perché sui casi estremi avrai da un lato la perdita e dall’altra il tedio.
Questo libro è strutturato su questa idea elementare.
Spesso facciamo teorie rozze su di noi, quando accade che qualcosa non funzioni o che qualcosa in qualche modo altera la partizione tra quanto è certo per noi su noi e quanto è incerto.
Facendo teorie su che cosa mi sta succedendo, per esempio, è evidente che se è garantita la circostanza della stabilità quanto all’identità, l’identità non è un gran problema. Quando allora è importante saperci chiamare in certi modi e contare su una riserva di riconoscimenti etero e auto stabili in certi modi? Quando c’è minaccia su ciò.
È evidente che la minaccia sull’incertezza nei riconoscimenti non è necessariamente un disvalore. Lo è a certe condizioni. E’ questo il tipo di problema, il punto cui io sono arrivato partendo dalla questione della condivisione.
Sentivo questo problema e, d’altra parte, mi muovevo nell’ambito del tipo di ricerca che è stata la mia più familiare negli ultimi quindici anni. Lavoravo su teorie concernenti ciò che vale, dove ciò che vale non è esclusivamente ciò che eticamente vale, ma è lo spazio in cui la questione non è “che cosa avviene”, ma “che cosa per noi vale”, lo spazio quindi che noi tracciamo quando non siamo più interessati o non siamo solo interessati a descrivere stati del mondo, ma a commentare stati del mondo. I valori entrano nel mondo quando noi siamo impegnati a commentarlo. Parlando dell’auto scassata all’ingresso del museo di Stoccolma, Dalisi ha affermato di avere avuto un’emozione. Ha detto più o meno precisamente “Ho visto un’auto su di una colonna e ciò mi ha dato un’emozione “. Beh, quando dice questo, Dalisi non sta dicendo: “Lì c’è una macchina lunga x, con cilindri y, di colore z, e così via “. Sta commentando l’esservi quell’oggetto nel mondo. Questa è l’esperienza artistica. Un poème dit le monde diceva Baudelaire. Così fa un quadro in forme differenti, e così fa l’oggetto.
Per tornare al mio “problema”, non ero soddisfatto delle soluzioni che da un lato l’utilitarismo, e dall’altro la teoria della giustizia come equità, o il contrattualismo, davano dei criteri di giustificazione degli assetti delle istituzioni fondamentali o della politica, o delle polis. Avevo cercato quindi di lavorare su quell’idea che viene riformulata nel secondo capitolo della seconda meditazione, l’idea dell’utilitarismo negativo, cioè l’idea della minimizzazione della sofferenza socialmente evitabile, e poi di definire di nuovo quella sorta di continuum per il quale a noi può accadere di spostarci dalla condizione in cui siamo pazienti (una società ingiusta è una società che non riduce la sofferenza, per quanto è socialmente possibile, di pazienti morali. È il caso del “deficit del bisogno” per intenderci), ad un altro estremo in cui il deficit non è un deficit che riguarda il nostro essere pazienti, ma il nostro essere agenti, cioè il nostro essere o aspirare ad essere costruttori di noi con altri, con tutto quel che ne consegue.
E allora, tra utilità e diritti, cercavo di uscire dall’impasse.
Lavorando in quell’ambito, a un certo punto mi sono trovato alle prese con la questione di quelle forme di vita in comune entro le quali noi ci trattiamo e ci riconosciamo in cerchie di mutua fiducia.
Ocone ha ragione a dire che nel libro c’è una massima di eticità. C’è infatti, ma non è esplicitata. Perché quando io parlo del fatto che vi siano comunità di condivisione, non intendo necessariamente che siano delle comunità che loderei. Una comunità di condivisione può anche essere la mafia. Ci sono buone e cattive compagnie, ma in quel caso conta il fatto che siano compagnie, non il fatto che siano buone o cattive.
A un certo punto mi sono chiesto così che cosa volesse dire il fatto che il linguaggio per noi non è un optional, il fatto che non essendo degli ego cartesiani disincarnati, nascendo siamo immersi in un sacco di cose che non abbiamo contribuito a fare, tra le quali innanzitutto il linguaggio. La faccenda è tutta qui.
Noi non scegliamo di nascere, e una volta nati ci troviamo (questo è il tema importantissimo della contingenza) in un mondo che può piacerci o meno, ma non abbiamo contribuito a fare. A questo punto mi sono detto che dovevo lavorare al linguaggio.
Sono grato a Sebastiano e a Vincenzo che hanno sottolineato la questione della centralità del linguaggio, perché l’argomento che presento sul linguaggio, è basato sull’idea che la sua importanza dipenda dalla questione dei limiti del linguaggio (e questo di nuovo diventa un argomento a matrice). L’originalità del mio argomento non sta naturalmente in questo, ma nel fatto che connetto tutto questo all’idea di importanza. Questa è la sola cosa originale che c’è nella mia tesi nella prima meditazione.
Mi sono trovato ad affrontare così le questioni attinenti alle nostre transazioni linguistiche, negli intorni non linguistici. Di nuovo i problemi della verità e del significato sono diventati per me un dilemma relativo alle condizioni – o come si dice – ai beni sociali primari senza i quali la comunicazione riuscita è esposta ai rischi del fallimento e dell’insuccesso.
Mi sono allora chiesto: “Ma perché pensare che l’idea di una comunicazione fallita sia un male?”. Non potremmo semplicemente pensare che la cosa non va?
Mi sono chiesto a lungo che cosa volesse dire il fatto che falliscano atti linguistici tra persone (perché atti linguistici tra persone richiedono atti non linguistici, in affari, in politica, in amore, con i figli, con gli scugnizzi, con i nostri studenti, con i colleghi, in bicamerale..), e in che cosa fosse un male il fatto che noi non riusciamo nel perseguire il fine della buona comunicazione (o del “bene comunicare” come io la chiamo).
È un male perché il fallimento annuncia scomuniche, esclusioni, e quindi solitudini involontarie.
Il tema della solitudine involontaria, che è uno dei leit motiv, una delle proposizioni centrali, è venuto per questa via, e mi è sembrato qualcosa che mi permetteva di connettere campi molto diversi.
Immaginate una storia di solitudine cognitiva per quanto attiene alla verità! La verità non avrebbe alcuna importanza per noi se per esempio fossimo tutti parte di un singolo enorme superindividuo. E questo è il grande problema che abbiamo in teodicea. Immaginate le secessioni rispetto alle comunità di condivisione di ciò che vale! Ne abbiamo esempi qui e là nel mondo, in posti anche molto vicini. Immaginate il conflitto delle interpretazioni per quanto attiene agli stili o ai linguaggi dell’arte! E allora immaginate quando Kandinskij fa “Le sacre du printemps” e questi schiodano le poltrone, o quando Schonberg altera la forma canonica! Pensiamo a quella battuta leggendaria di Picasso, quando a chi gli rimproverava la scarsa somiglianza di un ritratto all’originale, risponde: “Che importanza ha? Gli assomiglierà!”. C’è tutto in questa affermazione! C’è l’idea della responsabilità di Picasso nel costruire mondi per uditori di riconoscimento illimitati nella durata, che non coincidono con le preferenze reali e non critiche dei consumatori di quadri di quel momento lì. Questa cosa mi ha permesso di catturare un altro pezzo di teoria. Ma attenzione!. Questa non è una teoria dell’incertezza, come ho sentito dire spesso (non in questa sede fortunatamente!). Se c’è un elemento di sfondo, di nuovo questo è il tentativo di suggerire modi di guardare a noi stessi in un mondo di incessante deformazione. La mia quindi è una tesi sul cambiamento, anche se piuttosto bizzarra (bizzarra perlomeno rispetto alle cose che si usano dire).
L’idea è che noi siamo dei tipi maledettamente conservatori, e che per noi l’incertezza e l’instabilità sono un male, per cui tendiamo a ridurre l’incertezza e a preferire più stabilità piuttosto che meno (tutte cose insomma che generano e corroborano l’identità). Immaginate che fosse soddisfatta la richiesta che i prospetti fossero meno incerti! Nessuno di noi si riconoscerebbe in un mondo che avrebbe il tedio della certezza! Questo è un argomento a cui sono arrivato lavorando per quattro anni su venticinque pagine di Bernard Williams sul tedio dell’immortalità, un testo maledettamente difficile, filosoficamente straordinario, che è il caso Elina Makropulos, l’opera di Janacek.
Noi siamo dei tipi che mirano a ridurre l’incertezza, sotto la condizione naturalmente che l’annuncio di incertezza sia disvalore (questo è evidente!). Ed è razionale e ragionevole per ciascuno di noi ridurre l’incertezza quando essa è minacciosa. Assumiamo di riuscire a farlo e cadiamo sotto il tedio della certezza! Per fortuna, il destino è in qualche modo quello di Sisifo. Cioè la nostra riduzione di gradi di incertezza altera l’ambiente entro cui si è generata incertezza.
Mentre discutevo questa cosa l’anno scorso (avevo quasi finito il libro), mi fu fatta questa domanda: “Ma allora come puoi credere che noi possiamo pensare mondi alternativi. Dove va a finire un pensiero dell’utopia, in senso non negativo del termine?”.
Io parlo di utopia ragionevole proprio nelle ultime battute del libro, prima dell’elogio della filosofia, la cui formulazione è veramente un omaggio a Merleau Ponty, venendo io da Husserl. Che cosa sono allora le utopie? Come noi pensiamo mondi migliori, politicamente migliori o eticamente migliori? Noi costruiamo offerte di mondi vivibili, entro mondi vitali che sono un casino! Nel mondo vitale ci sono leggende metropolitane, teologia, metafisica, un po’ di televisione. C’è tutto. Noi facciamo allora offerte di mondi vivibili in quanto cerchiamo di sottrarre, immunizzare, rispetto all’incertezza, cose che valgano per vite migliori. Quindi offriamo comunità di condivisione. Ma offrendo comunità di condivisione, noi lavoriamo con quello che abbiamo, cioè con i pezzi di realtà che sono l’eredità, le impronte (come la macchina lassù sulla colonna) di ciò che ha corrisposto ad altri equilibri che si sono rotti. In questo senso è un problema di equilibrio e disequilibrio.
Pensate alla formazione delle agenzie di tutela o di definizione di interessi collettivi, come quelli sindacali o unioniste, e alla storia dei movimenti di associazione non politica degli interessi dei salariati in Europa! Quali sono i grandi testi con cui nasce il cartismo, le credenze con cui si organizzava l’azione collettiva? Erano i grandi testi della tradizione religiosa seicentesca. Pensate al mix tra il positivismo e il Gesù dei poveri che caratterizzava la tradizione italiana, con cui si organizzavano le prime forme di azione collettiva a tutela di chi era pesantemente svantaggiato ! C’è un libro straordinario di Valenton Boar che fa un analisi comparata dello sviluppo della socialdemocrazia tedesca, in cui voi vedete qual è la cultura, quali sono le cose per cui la gente crede, che motivano le persone a fare certe cose e non altre. Tutti i processi di modernizzazione allora sono processi che spaccano gli orizzonti stabili. Tutto il problema della sociologia moderna è il problema di come fa una società a stare insieme una volta che vengano meno le legature tradizionali, una volta che vengano meno le assegnazioni di identità stabili per via ascrittiva.
Gino Germani, grande sociologo che ha insegnato all’università di Napoli, ha basato tutta la sua teoria della modernizzazione sullo spostamento del confine tra quanto è ascrittivo e quanto è elettivo. Posso dire allora che anche la mia offerta filosofica è un bricolage con i pezzi di passato con cui cerco di ridurre l’incertezza rispetto alle ragioni per sostenere gli argomenti. Questo è il punto che volevo sottolineare.
Devo due risposte a Sebastiano. Una è sul problema del pragmatismo neotrascendentale. Per dirla con una battuta, la mia prospettiva è una prospettiva fondamentalmente tributaria nei confronti di Quine (in particolare il Quine di Relatività ontologica), con un punto però. La domanda su “come è possibile che”, quella che credo in questo senso sia una domanda trascendentale, io la mantengo. In questo senso tutto il libro è percorso da questa continua domanda: “Come è possibile che?”. I modi con cui rispondiamo sono però (qui me la cavo con una citazione) più simili agli strani muri maestri di Wittgenstein, di cui si può dire che sono sorretti dall’intera casa ( e questo secondo me è il pezzo olistico quiniano), piuttosto che a condizioni immunizzate rispetto a qualsiasi incertezza di tipo kantiano. E ciò dipende da come lavoriamo sulla risposta allo scetticismo.
Personalmente sono dell’idea che il trascendentale che accetto è il trascendentale che risponde scetticamente alla manovra scettica. Questa è la cosa che direi. Queste sono cose poi che solitamente discutiamo nei seminari per filosofi ma sono cose importanti perché sono legate all’idea del mutamento e dell’evoluzione, e quindi anche del mutamento e dell’evoluzione dei criteri che sottraiamo all’incertezza.
Sul problema del liberalismo politico, che ha ripreso anche Corrado Ocone in conclusione, sono invece d’accordo con Maffettone. Perché in fondo egli dice: “Quello che è filosoficamente importante, quell’insieme di cose che valgono, di valori che ciascuno di noi riesce ragionevolmente a sostenere e altri ragionevolmente accettano, deve essere indisponibile rispetto alle scelte di maggioranza”. Se è questa la sua tesi, io sono perfettamente d’accordo. Forse è diversa l’enfasi che le do. Avrete forse già letto il saggio di Sebastiano Maffettone e Ronald Dworkin sui fondamenti del liberalismo edito da Laterza. È un contributo importante che spiega perché Sebastiano dica in sostanza che se c’è qualcosa di filosoficamente rilevante da pensare, non è la procedura, non è l’applicazione ma il nucleo di valori che, se sono sostenuti da ragioni, per ciò stesso ciascuno di noi non accetterebbe o non dovrebbe accettare o si doglierebbe che fossero scippati dalla scelta collettiva.
Sono convinto (è qui il mio punto) che il pezzo certezza – incertezza è di nuovo legato in questo caso a quella che vedo come una tensione tra liberalismo, che intendo come costituzionalismo, e procedura di scelta aggregativa e democratica.
Questo non è un problema solo della Bicamerale. Lo stanno affrontando tutte le società a democrazia pluralistica. Stanno scrivendo la costituzione inglese che, come sapete, non c’è. La Costituzione tedesca è stata sottoposta a forti pressioni. Lo è stata naturalmente per la questione congiunturale degli asylanten, ma ancora adesso è aperta la discussione. In Francia pure ci sono forti pressioni. E naturalmente in tutta quella parte di mondo che il sisma geopolitico dell’89 ha messo in fibrillazione.
Dove si tentano arrangiamenti costituzionali, lì è il costituzionalismo. Mi sembra naturale. Ma attenzione! La mia idea è che la tensione tra liberalismo come costituzionalismo e democrazia come procedura per l’aggregazione delle preferenze individuali in scelte collettive si può nuovamente sintetizzare in questo modo: quanto più immunizzo, rispetto all’incertezza, la cornice costituzionale e istituzionale, tanto più virtuosa sarà l’incertezza democratica; quanto più esposta a incertezze è la cornice, tanto più viziosa sarà l’incertezza democratica. E questo si spiega con la tesi della scarsità politica che abbiamo discusso l’anno scorso in un seminario di filosofia politica. Quando uno percepisce come tirannico lo scippo da parte di maggioranze democratiche, sta facendo l’esperienza che nel secolo scorso, agli albori di regimi così instabili e imperfetti, e tuttavia migliori di tutti gli altri (per riprendere una battuta di Churchill), facevano quelli che esaminavano con occhi attenti le tendenze alle forme della tirannide democratica, alle tirannie politiche e alla tirannie sociali di maggioranza. Tutte cose curiosamente di vecchio sapore liberale che oggi in fondo ci troviamo tra i piedi, non perché come la massima parte degli imbecilli dice: “Siam tutti liberali” (questa è una delle cretinate standard), ma perché il grande ciclo che ha modellato la maggior parte delle società democratiche, pluralistiche, di democrazia costituzionale, ha in qualche modo finito, come in fondo è abbastanza inevitabile, per risolvere, attraverso l’inclusione democratica (cioè attraverso i diritti di cittadinanza, l’estensione del suffragio e l’inclusione ai diversi livelli), il grande problema con cui questi arrangiamenti e questi conflitti si sono stabilizzati in organizzazioni politiche e istituzionali.
Ma quando si risolvono dei problemi se ne aprono di nuovi. E i nuovi dilemmi sono tutti dilemmi che hanno il sapore liberale. Anche la discussione sulla riforma del Welfare, “Quale, perché, sulla base di quali criteri? Sulla base di quali principi?”, è una discussione tipica non solo in Italia (andate a vedere l’Olanda e la Svezia! Ogni paese ha il suo Zonderveg). Qual è il tasso di protezione ritenuto accettabile nei confronti dell’incertezza su classi di rischio significative della vita di un cittadino medio? Questo è il problema del Welfare, se uno vuole ridisegnare lo stato sociale sulla base di principi discutibili, controvertibili, eccetera. Non lo è se uno deve costruire lo stato sociale sulla base del precetto di giustizia distributiva “A ciascuno secondo le sue capacità di minaccia”. Questo riguarda tra l’altro il rapporto tra la forza e la comunicazione di cui parlavano Vincenzo Moretti e Sebastiano Maffettone.
Un’ultima osservazione. Sono stato molto colpito da quello che Ocone ha detto sulle impressioni che il libro gli ha generato. Farò una piccola confessione. Io ho scritto molti libri nella mia vita, e forse, in particolare tra gli anni ’80 e ’90, ne ho scritti troppi. Mia moglie ne è convinta. Ma mia moglie è grandiosa perché non prende molto sul serio la mia attività filosofica, e questa è una cosa straordinaria per me. Del resto, voi potreste prendere sul serio un compagno o un marito che lavora otto ore al giorno scrivendo, e al tempo stesso vivere felici? Non credo.
Ci sono vari modi per reagire. Il divorzio (ma ne ho già fatto uno), oppure non prendere sul serio quello che l’altro fa. Questo dà un buon senso dei limiti e dell’umiltà filosofica a chi ha delle idee di onnipotenza, come a tutti noi accade. Ma senza delirio di onnipotenza perché uno dovrebbe scrivere 420 pagine, cercando di menarsela con Platone, Aristotele, e Quine, che è il più difficile di tutti, almeno per me?
È proprio vero che in questo libro ho cercato, diversamente che in quelli precedenti, di comunicare a un uditorio non già determinato.
Quando ho scritto la “Società giusta”, nell’82, avevo di mira un uditorio determinato. E’ un po’ il discorso che facevamo prima su intellettuali e politica. Avevo davanti delle facce mentre scrivevo il libro. Avevo alcuni dirigenti delle élite dei partiti della sinistra, in particolare del Partito Comunista al quale sono rimasto sempre affezionato. Avevo alcuni (come si usa dire in Italia) intellettuali che erano in qualche modo dei professionisti del maneggio del discorso pubblico, quindi generanti beni di identificazione collettiva e di appartenenza. E dall’altra avevo altri intellettuali con cui interloquivo, ma non primariamente perché come me facevano filosofia o filosofia politica, ma perché avevano un certo ruolo e io avevo una certa aspettativa sul loro ruolo quanto alle vicende della discussione pubblica e della vita politica del paese.
Quando ho scritto “Questioni di giustizia” li avevo ancora in mente. Quando ho scritto “Etica e politica” era chiaro chi avevo in mente. Quando ho scritto “Cittadinanza”, ho scritto quel libro perché finalmente, secondo me, il partito comunista aveva affrontato la sfida dell’innovazione.
Nessuno di noi quando scrive sa poi quanto pesa il fatto che i libri, da coloro per i quali sono stati scritti, siano letti in certi modi. E soprattutto non prevediamo gli effetti non attesi. Semplicemente continuiamo a mettere messaggi nella bottiglia.
Questo libro ho sentito invece di doverlo scrivere non avendo di mira un uditorio determinato, ma pensando che chiunque in qualche modo potesse aver impressioni, percorrendo questa ricerca, fosse benvenuto nella cerchia dell’ospitalità.
È vero, questo è un libro difficile. Infatti a un certo punto non mi ricordavo più niente di come lo avevo fatto, perché era troppo complicato. Ed è anche un libro che io stesso rileggendo, rileggo a vari livelli. Ma il fatto che sia chi in qualche modo fa parte della cerchia della ricerca filosofica, sia chi fa parte di altre cerchie, o anche semplicemente il fatto che persone che trovano una buona cosa esaminare riflessivamente le proprie vite, vi trovino impressioni e connessioni, per me è il massimo che potevo ottenere. Di questo sono felice e vi ringrazio di cuore.
Questo storia inizia con un articolo di Pasquale Raicaldo pubblicato su Repubblica Napoli il 22 Gennaio 2021 e intitolato “Altro che social, in Cilento le storie viaggiano sulle scarpe, lo potete leggere qui e continua con un articolo redazionale pubblicato su Repubblica Napoli il 23 Aprile 2021 e intitolato “I monumenti di Napoli sulle mitiche Superga”, lo potete leggere qui.
Questa è la foto della #scarpascritta “Coraggio” editata da Scritte e realizzata dall’azienda Confort Shoes a Caselle in Pittari con il marchio Patrizio Dolci a fine Gennaio 2021.

Questa è la foto della scarpa Superga #throwback pubblicata su Repubblica Napoli nell’articolo citato.

A scanso di equivoci, vi dico subito che se adesso state pensando che tutto questo mira non dico a dimostrare ma anche solo a sostenere che Superga ha copiato Scritte siete completamente fuori strada. Non solo perché il vecchio sociologo come me in questi casi qui non può fare a meno di andere con il pensiero al grande Robert K. Merton e alla sua accezione di Scoperte Multiple Indipendenti nelle sue meravigliose riflessioni sulla Serendipity, ma anche perché pure io ho amato le Superga per lunga parte della mia vita, alla fine le ho lasciate solo per Scritte, e non mi sembra poco.
Il “perché” di questo post si può riassumere in tre punti.
Il primo racconta di soddisfazione e anche di qualche conferma, perché se la “scoperta” che hai fatto tu, tu nel senso di Scritte e in primis del suo fondatore, Giuseppe Jepis Rivello, l’ha fatta anche la “mitica” Superga, c’è sicuramente da essere contenti e soddisfatti, almeno io la penso così.
Il secondo racconta di sfida, che per fortuna non è come ai tempi di Davide e Golia, oggi le sfide si possono giocare sul terreno della qualità, della bellezza, dell’innovazione, e anche senza esagerare con storie tipo siamo tutti uguali, è fuori discussione che al tempo dei bit i Davide sono un poco meno Davide e i Golia sono un poco meno Golia.
Il terzo racconta di mercati e di possibilità, perché il progetto ideato da Jepis, è difficilmente scalabile, perché certo Superga può fare Napoli, Milano, Parigi, Londra, New York, Tokyo e compagnia bella, ma noi possiamo fare anche Pienza, Padula, Pavia, Gerace, e lo possiamo fare a partire dalla storia di chi sceglie di indossare le nostre #scarpescritte. Noi cerchiamo autori prima che clienti, sono loro che vengono da noi, non viceversa.
Per ora non ho altro da aggiungere, magari ci ritorno su nei prossimi giorni e magari no, alla fine questi piccoli pensieri sono solo dei segnaposto per successive esplorazioni, riflessioni ulteriori da fare non solo nell’ambito del team Scritte, ma anche insieme a voi, perciò se lasciate qualche riga di commento sappiate che sarò felice di leggervi e pensarci su.

Ci sarà prima o poi
Ci sarà, prima o poi, un Paese governato dal Re più buono, giusto e onesto che si possa immaginare. Se sarà un Paese del pianeta Terra o si troverà sulla più lontana stella, a dire il vero, non ha molta importanza. Forse si potrebbe perfino evitare di dargli un nome, dato che i nomi assai di rado rivelano il senso delle cose alle quali vengono riferiti.
Il modo in cui verrà chiamato questo o quel personaggio, tale o tale altro posto avrà insomma la sola importanza che può dirsi meritata: nessuna. Un giorno, per fortuna non lontano, colui il cui nome è Segreto, stanco delle innumerevoli generazioni di lettori che in infiniti universi avranno colpevolmente confuso il termine ed il contenuto, lascerà che il Caos avvolga e sconvolga i nomi compresi non solo in questa ma in ogni altra storia narrata, scritta, o anche solo pensata.
Non sarà un gran giorno per sacerdoti e seguaci del culto di Emon, il dio che si vuole all’origine di ogni nome. Ma per intanto una balena potrà chiamarsi Pinocchio e un burattino di legno semplicemente Moby Dick, don Qujote sarà un tormentato principe di Danimarca e Hamlet un visionario cavaliere della Mancia.
Coloro i quali, per ragioni diverse e che ugualmente ignoro, dovessero un giorno incontrare le vicende che sto per svelare, sappiano in ogni caso che i protagonisti, i fatti e finanche la maniera in cui questi si vorranno intrecciare saranno necessariamente lontani da quelli che sono soliti popolare la vita di ogni giorno.
Prima o poi, ogni cosa qui detta o anche solo immaginata sarà infatti inesorabilmente vera.
Un’isola, uno strano congegno ed un cielo con le bollicine
Gli avvenimenti che intendo raccontare avranno luogo tra il 30° ed il 40° parallelo, ad Oriente di quella che ai giorni nostri viene chiamata Fossa di Kermadec, su un’isola grande abbastanza per essere popolata da alcune decine di milioni di abitanti. Niente di più, insomma, di una delle tante macchie di terra immerse in quell’Oceano esteso per 180 milioni di chilometri quadrati che, attraversato nel 1520 da Magellano, è stato successivamente denominato, senza alcuna conseguenza sulle illimitate possibilità di ogni sua particella di acqua e di sale, Pacifico.
Per le sue caratteristiche la Cyrlandia (è questo il nome o, se si preferisce, il nome del nome, dell’isola in questione) può essere considerata a metà strada tra i Paesi in via di sviluppo e quelli cosiddetti avanzati.
La pesca, con le attività di trasformazione ad essa collegate, ed il turismo sono ovviamente le sue fonti principali di lavoro e di ricchezza.
Le speranze per il futuro sono però legate alla commercializzazione ed alla vendita sui mercati mondiali di Mikemito, il materializzatore ovulare ad alta risoluzione che consentirà di riprodurre in tempo reale, direttamente a casa propria, qualunque personaggio della televisione. La scoperta di Mikemito darà alla Cyrlandia e al professor Oid, direttore della scuola elementare nel quale è nato ed è stato sviluppato il progetto, la fama ambita e vana che dà l’avere un nome che sopravvive a sé stessi.
Le condizioni climatiche dell’isola dipendono fortemente, come del resto avviene da ogni altra parte, dallo stato d’animo della gente. Marinai e vecchi pescatori raccontano che, negli ultimi tempi, accade assai di frequente di incontrarvi, la sera, un cielo così denso di stelle da sembrare un mare con le bollicine.
Una città, un palazzo ed un architetto venuto da terre lontane
La città di Urala è la capitale del regno di Cyrlandia da quando una guerra, stupida come tutte le guerre e ancora di più, ha avuto tra le sue conseguenze, neppure tra le peggiori, la totale distruzione dell’antica Arula. La scelta di Urala è stata considerata, a quel punto, assolutamente naturale. E’ infatti qui che la famiglia reale è solita trascorrere gran parte dell’anno, in un antico palazzo dalla struttura simmetrica ma assai particolare progettato da un architetto venuto da terre lontane. Che vi si acceda da levante o da ponente, con lo sguardo rivolto ad austro o ad aquilone, ci si trova di fronte allo stesso, identico scenario: una sala d’ingresso tetragonale che, ad uno dei lati, defluisce in uno stretto andito dal quale si accede in una seconda sala, di ampiezza doppia rispetto alla precedente e così ancora andando avanti si giunge infine in un immenso salone dal quale è possibile accedere al piano superiore, riprovevole e inutile specchio della vanità di un uomo.
Matto Curiel e l’importanza delle piccole cose
Matto Curiel è un re assai rigoroso, riservato, assai poco incline al lusso e agli sfarzi. L’esatto contrario di Re Acici, il sovrano dell’isola vicina, famoso per le feste alle quali accorrono nobili di ogni tipo e da ogni parte del globo, famigerato per i forzieri perennemente vuoti e le tasse con cui è solito perseguitare i malcapitati sudditi.
Perfino nella magica terra di Bula Matari, dove vivono curiosi esseri condannati a possedere la memoria delle vite precedenti ed il presagio di quelle future, si parla di Matto come di un sovrano dalle doti molto particolari. Sembra che non perda occasione per dimostrare il suo rispetto per le leggi e per le regole e che possieda la grandezza di chi conosce l’importanza delle piccole cose, quelle che anche tra le persone comuni fanno la differenza. Nonostante i tanti cortigiani disposti, pur di compiacerlo e di giustificare i propri privilegi, a chiudere un occhio o a fare uno strappo alla regola, non c’è in tutta l’isola chi possa affermare in buona fede che egli approfitti della propria condizione di Re.
La cosa è considerata da tutti assai poco ordinaria. In fatto di cultura ed osservanza delle leggi in Cyrlandia c’è infatti ancora tanta strada da fare e perfino i governi insediati dal padre e prima ancora dal nonno di re Matto hanno lasciato molto a desiderare in quanto ad onestà e competenza.
Ruberie si sono succedute a ruberie, gli uomini migliori sono stati sovente emarginati ed i soli ad aver incrementato le proprie fortune sono stati gli amici dei potenti o, al massimo, gli amici degli amici dei potenti. Si racconta che perfino tra i membri della famiglia reale ci sia stato chi non sempre ha saputo mantenere un comportamento esemplare e quel che è certo è che agli stessi re Darol e Rodal, nonno e padre di Matto, non sono state risparmiate osservazioni e critiche. Naturalmente, non c’è stato bisogno e tanto meno occasione che esse fossero riferite direttamente alle azioni delle loro regali persone. Per l’arbitrario giudizio del popolo è stato più che sufficiente l’aver tollerato che il Paese diventasse terra di conquista per impostori di ogni tipo.
Nasce una stella
Con l’ascesa al trono di Matto Curiel inizia il tempo delle novità e dei cambiamenti. Rinnovando una tradizione di cui si era persa memoria egli annuncia la volontà di assumere personalmente la guida del governo e non trascorre molto tempo prima che le sue doti, unite alla capacità di stimolare ed attrarre le intelligenze e le competenze migliori dell’isola, diventino proverbiali.
Studiosi e scienziati della politica, che anche in Cyrlandia sorgono più numerosi dei funghi, fanno a gara per annunciare, ossequiosi e festanti, la consacrazione del nuovo leader mentre i direttori di quotidiani e reti televisive, interpellati telefonicamente dai cittadini nel corso di periodici sondaggi, sono per una volta rispettosi della verità ed affermano che non si vedrà Re migliore di lui per molti secoli a venire.
Per quanto possa sembrare paradossale, i soli che sembrano avere ragionevoli motivi di malcontento sono la moglie e i figli del re che, come si può immaginare, hanno ben poco tempo per godersi quello che per loro è pur sempre prima di tutto un marito ed un padre.
La questione non è di poco conto. La mancanza di tempo sufficiente da dedicare ai propri familiari è per re Matto un cruccio costante. Giorno dopo giorno egli sente i suoi giorni farsi più brevi e spesso neanche la notte riesce ad arrestare il dominio del dovere.
Certo! Ci sono occasioni nelle quali, ad un re, non è data altra scelta che impegnare se stessi senza riserve. Ma nonostante re Matto non intenda di certo venir meno al proprio destino, c’è chi giura che in taluni momenti appare vinto da una malinconia inesorabile come l’acqua che scorre tra le rughe dei sassi.
Urala, la Cyrlandia e la voglia di riscattare i propri errori
Le probabilità che l’isola riprenda la marcia verso un futuro migliore sembrano dunque inevitabilmente destinate ad aumentare ed i più ottimisti non esitano a sostenere che in un giorno non lontano Urala diventerà talmente grande da eguagliare un ricordo, quello dell’antica Arula.
Progressi evidenti vengono conseguiti in molti campi ed attività mentre le strade, i musei, le chiese delle più importanti città dell’isola ridiventano meta di visitatori e turisti provenienti da ogni parte. In men che non si dica, la Cyrlandia diviene agli occhi di tutti un Paese capace di riscattare i propri errori. E, forse, ancor più del fascino e della magia dell’isola, è proprio questo ciò che desta maggiore ammirazione e stupore.
Il tanto lavoro sembra dunque produrre risultati positivi e più d’una buona ragione consiglia di essere soddisfatti.
Trascorrono così, in fretta e tutto sommato felici, i primi nove anni del regno di Matto Curiel.
Un giorno come gli altri
“Non serve che sia diverso dagli altri il giorno in cui nulla sarà più come prima”.
I bambini della Cyrlandia amano molto ripetere questa frase quando la sera raccontano le favole ai propri nonni. La ritengono infatti molto più sincera del tradizionale “vissero tutti felici e contenti” e pensano che possa essere di aiuto nella preparazione ai grandi cambiamenti che attendono i loro bianchi compagni di gioco.
Ma la saggezza che ci è compagna sempre da bambini e qualche rara volta da vecchi, è solita svanire nella cosiddetta età della ragione e Matto non sa che è solo un giorno uguale a tanti altri quello nel quale decide che, per una volta, a Palazzo dei Serpenti, sede del governo, dovranno fare a meno di lui. Si sente stranamente assorto, avvolto in quei pensieri densi che gli affollano la mente ogni qualvolta viene lasciata, incessante e inquieta, libera di andare. La periodica, impercettibile, inconfondibile contrazione delle labbra lo avverte che molto presto il turbamento si farà smarrimento e infine angoscia, dolorosa e ineluttabile compagna di ogni cambiamento.
E’ già da un po’ che vaga assorto tra porte e stanze del palazzo quando si ritrova nello studio ceruleo del piano superiore, dove custodisce gelosamente libri, oggetti e ricordi.
Tra i vetri spessi della finestra una casa rossa, il mare, tante e colorate vele. Più in fondo, una nave ancora opaca, silenziosa, pare staccarsi di malavoglia da lì dove cielo e mare si confondono. Ma ora, per lui, non esiste altro che il vorticoso scorrere dei propri pensieri. E quasi non si accorge dell’arrivo di Alvirea.
La regina Alvirea
La regina nutre per lui quell’amore raro che né il tempo né le difficoltà riescono ad affievolire. Sarà perché il re riesce ad essere in ogni momento tanti uomini diversi o per la contingente fatalità che spinge ciascuno a dare un nome e un volto al suo bisogno di amare l’intero universo, sta di fatto che ella riesce a comprenderne fino in fondo lo stato d’animo, i sentimenti, le ragioni.
Questo non le impedisce ovviamente di sostenere, quando occorre persino con veemenza, le proprie opinioni. E anche per quanto riguarda intuito ed esperienza le resta ancora poco da imparare. Sa bene, ad esempio, che in certi momenti non può far altro che attendere. Attendere che il suo Matto emerga anche solo un po’ dalle onde del proprio pensare e si decida finalmente a parlare. E, con gli anni, ha imparato ad attendere senza impazienza, a rispettare tempi e silenzi a lei poco cari.
Cose degne di un re
“Basta avere occhi per vedere e voglia di capire per rendersi conto che i cambiamenti che, a prezzo di tanta fatica, siamo riusciti a realizzare, incidono a malapena sugli aspetti più superficiali della cultura e dei modi di vita del nostro popolo.
E’ come se i guerrieri che più di mille secoli fa combatterono Sam-Sa, il drago della grande palude, si fossero accorti ad un tratto che né i valorosi colpi, né l’aspro ferro delle loro spade, sarebbero mai valsi a conquistarne il cuore.
Proprio così. So che la trasformazione delle coscienze è la sola cosa concreta veramente degna di un re eppure ogni giorno che passa la speranza di rendere migliore la nostra gente mi appare più vana”.
Come ogni volta, non è facile, per la regina, trovare gli argomenti e le parole giuste. Per un attimo pensa, forse sa, di poter dare un senso all’inquietudine che dal re sembra spandersi nell’aria. Poi quel senso svanisce, si confonde dissolvendosi tra mille altre possibilità. Lei non vinta ancora lo insegue, quasi lo riafferra, lo riperde.
Intanto, al di là dei vetri, nient’altro che la casa rossa, tre colpi di sirena e il mare.
Il valore delle ragioni pubbliche
“Credo che dovresti mostrare maggiore rispetto per te stesso e per le cose che stai cercando di fare. Le aspettative che hai generato diventano ogni giorno che passa, grazie innanzitutto al tuo impegno, cose concrete. E per le strade, tra la gente, si respira finalmente aria nuova.
Attento a non dimostrarti meno saggio del tuo stesso popolo, marito mio: nove anni sono un tempo breve e ad inseguire risultati straordinari si può finire preda della presunzione. Da te i cyrlandiani si aspettano quel buon ordine che permette nel tempo di ottenere libertà, diritti, equità, benessere e non certo lo stravolgimento delle loro coscienze”.
Di nuovo il silenzio. E il volto di Alvirea che tradisce la soddisfazione di non aver rinunciato al proprio modo di pensare, di sentire, di essere. Se, nonostante un destino segnato, aveva deciso di laurearsi con una tesi sul valore delle ragioni pubbliche secondo un filosofo di antenati celti, era stato anche perché alla sua naturale attitudine a fidare nel diritto e nella giustizia aveva voluto dare radici, profondità.
Ora, nel silenzio, i suoi occhi si muovono veloci in cerca di indizi che le rivelino l’effetto delle parole appena pronunciate.
Bambole, ritratti e racconti
Come già scritta, magari in quella commedia di Ranbaldo de La Cerca che il re, per estremo amore, ha imparato a memoria, giunge, inequivocabile, la risposta.
“Cara Alvirea, se pensi che le mie parole o il mio tormento nascano dalla voglia di inseguire un potere ancora più grande di quello che ho, mi fai un inutile torto. La gloria che con troppa generosità mi è già stata concessa mi è ormai di tale peso da rendermi completamente insensibile al fascino seducente e corruttore che essa emana. Avrei da tempo rinunciato agli onori che spettano al capo del governo nonché, come è naturale, ad ogni altro incarico pubblico, se non fosse che non mi riesce di lasciare le cose a metà o, peggio ancora, appena avviate”.
“Non nego certo l’impegno, né i risultati che esso ha contribuito a determinare, ma so che ogni cambiamento, per essere duraturo, deve rappresentare per ciascuno un bisogno, e non un dono. Di tutto questo, per quanto mi sforzi, non vedo traccia. Da qui il mio tormento. So che il destino che io stesso mi sono dato e che ancora sento indissolubile attende di essere compiuto. E so che non è più il mio”.
Così dicendo, Matto si dirige verso la credenza nella quale custodisce le 21 opere che ritiene destinate a durare oltre ogni tempo.
Per la verità, non c’è cosa in questa stanza alla quale egli non si senta legato profondamente. Le preziose bambole di un artigiano saggio quasi fino alla follia; i ritratti di un pittore sud europeo vissuto in due diversi millenni; il leggio sul quale è solito poggiare il volume che per ultimo sta leggendo.
Tra tutte le cose, quelle che più ama sono proprio i libri. E tra tutti i libri, quelli riposti in questa credenza che alcuni artigiani cinesi avevano voluto donargli nel corso di un suo viaggio.
La mano afferra sicura i racconti scritti da un uomo dagli occhi spenti nato in quella parte d’America che centinaia di milioni di anni prima formava, con l’Oceania, l’Antartide, l’Africa e l’India, il supercontinente chiamato Gondwana. Vi si narra di tigri, labirinti e sogni. Forse è perfino naturale che adesso egli pensi a se stesso come a un uomo perso in un labirinto. E la maniera in cui stringe tra le mani quei racconti svela l’inutile speranza di trovare lì il filo in grado di condurlo fuori dal buco nero in cui si sente cacciato.
Poi, ancora una volta, è quel mare mai fermo a catturare la sua attenzione: quando finalmente si volta verso la propria sposa negli occhi non ha che confusione, sgomento, tempesta.
Il Libro dei Mutamenti
I minuti scorrono lenti e neppure Alvirea appare in grado di rompere quel vano, immobile tergiversare. E’ quando la voglia di non farsi sfuggire una così importante occasione prende finalmente il sopravvento che la regina sente di non avere che una sola, illimitata, possibilità.
Lo scaffale è ancora quello precedente, il punto preciso appena due tomi più in là. Una copertina verde chiaro sulla quale è inciso in oro un disegno che, senza essere ascrivibile ad alcuna lingua comunemente parlata, riproduce una divinità: è l’I Ching, il Libro dei Mutamenti, il più antico testo di saggezza cinese. Alvirea sa che nel corso degli anni esso è diventato per Matto una essenziale, meravigliosa fonte di conoscenza e lei stessa ne ha più volte verificato le straordinarie qualità filosofiche oltre che divinatorie.
Preso il libro dal casellario, lo svolge dal drappo di seta rossa nel quale è scrupolosamente custodito e mentre con mano sicura ne scorre le pagine e i segni, inizia a parlare.
L’importanza di conoscere se stessi
“Ricordi? Quando per la prima volta mi hai parlato di questo libro infinito mi hai detto dell’insistenza con la quale in esso viene sostenuta l’importanza di conoscere se stessi. Credo che tale insegnamento dovrebbe esserti in questo momento di grande aiuto. Se è vero, come tu stesso hai riconosciuto, che la tua mancanza di serenità è figlia del conflitto tuttora aperto in te, l’impazienza non può che arrecarti ulteriore danno. Lascia che il tempo ti aiuti a diradare le foschie ed ogni scelta si farà semplice perché in armonia con il senso di tutte le cose. Solo chi trova se stesso può sperare davvero di scoprire ogni cosa al di qua e al di là del cielo e delle stelle”.
Un provvisorio silenzio accompagna gli occhi della regina mentre si posano sul libro aperto laddove la combinazione di linee intere e spezzate forma l’esagramma Hsu, che nella lingua dei Cyrlandiani può essere tradotto come l’Attesa, il Nutrimento.
“Come Ch’ien (il Creativo, il Cielo) di fronte a K’an, (l’Abissale, l’Acqua) devi dimostrarti capace di non agire precipitosamente e di saper attendere il momento per te più propizio. L’affanno di chi pensa di piegare il futuro alla propria volontà è del tutto inutile e ciò che infine dovrà essere sarà soltanto per chi, nel tempo dell’attesa, saprà fare più forte il proprio corpo e l’animo”.
Coincidenze, varchi ed un vecchio chiamato Ch’eng Tzù
Matto appare sinceramente colpito da quella che avverte come una testimonianza di saggezza e d’amore assai rari. Egli ha imparato da tempo che quelle che chiamiamo coincidenze sono varchi aperti verso nuove possibilità e la sua mano è sicura quando cerca il piccolo scrigno nel quale conserva le monete di bronzo che qualcuno lasciò tra le sue coperte di bambino la notte in cui sognò di un vecchio chiamato Ch’eng Tzù.
Ken e Chin
Sei volte le monete incontrano l’aria e il legno prima che la fatale coincidenza di linee tenere e solide, chiare e scure, riveli l’inconfutabile sentenza.
Due linee tenere e fisse al primo e secondo posto ed una solida e mobile al terzo; ancora due linee tenere, l’una mobile al quarto e l’altra fissa, al quinto posto, ed una linea solida e fissa al sesto: è Ken, il segno della Quiete, dell’Arresto, che l’azione delle due linee mobili trasformerà in Chin, il Progresso.
Presto o tardi, uomini di ogni tempo e luogo potranno leggere, nella sezione diari di una qualche polverosa biblioteca, le parole con le quali Matto Curiel riassume i saggi consigli del Libro dei Mutamenti.
“Nel tempo della quiete e dell’arresto la fine di ogni cosa si collega con un nuovo inizio. Le cose non possono muoversi continuamente, occorre ad un certo punto saperle fermare. Muoversi e fermarsi al momento giusto: così quiete e moto sono in armonia con il senso della vita e con l’intero universo, così la luce potrà illuminare la vita dell’uomo saggio”.
“L’esagramma Chin rappresenta invece il sole che si leva sopra la terra ed è quindi l’immagine del progresso rapido e facile: l’uomo che sa essere libero da ogni gelosia e sa controllare la sua capacità di influire sugli altri è destinato a raggiungere grandi mete”.
L’Aula della Diffusa Conoscenza
Sono trascorse poche settimane ed il Re è decisamente di buonumore. Per le dieci e trenta, il protocollo prevede la visita alla scuola elementare diretta dal professor Oid e l’insolita facilità con la quale riesce a liberarsi di guardie del corpo e auto al seguito sembra voglia preannunciargli la giornata molto particolare.
La vecchia seicento multipla impiega poco più di un’ora per condurlo a destinazione e nell’Aula della Diffusa Conoscenza già da qualche minuto gli echi rincorrono, confondendole, voci e grida, quando un rispettoso battimani sottolinea il suo arrivo.
L’efficienza del professor Oid e dei suoi collaboratori appaiono subito evidenti. Persone e cose sono infatti come naturalmente al proprio posto. Bambini inseguono bambini, e treni, palloni, pupazzi, automobili e soldatini di ogni tipo; genitori cercano risposte nelle domande di altri genitori; maestri confrontano esperienze condivise.
Bastano pochi banali colpi di tosse del professor Oid perché un nuovo ordine sostituisca quello precedente; al Mc Person 027 portatile ed alla solerzia di un alunno della ottava zeta si deve invece il resoconto puntuale dell’incontro. Nulla di ciò che si dirà, che già è stato detto, andrà dunque perduto.
Il professor Oid
Come sempre, Oid si limita all’essenziale. Poche parole di benvenuto all’illustre ospite, una sintetica esposizione delle ragioni che hanno ispirato l’incontro e degli obiettivi che si intendono raggiungere, l’illustrazione, appena un po’ più argomentata, delle regole secondo le quali esso si svolgerà.
Ciascun alunno ha tre minuti a propria disposizione per fare domande, formulare richieste, suggerire proposte. Al re vengono invece assegnati, in quanto adulto e per questo meno dotato, sette minuti per ogni intervento o risposta. Ad Oid il compito di coordinare la discussione mentre genitori e insegnanti si preparano a seguire la lezione con l’attenzione necessaria: occasioni così non capitano tutti i giorni ed essi sono intenzionati a trarne il massimo profitto.
Per molte ed interessanti ore il confronto percorre i sentieri più disparati, a volte approfondendo questioni note, altre affrontando argomenti inesplorati. Oid riesce a districarsi con notevole maestria anche nel ruolo per lui non certo abituale di moderatore e Matto riscuote significativi apprezzamenti per la sincera attenzione con la quale ascolta tutti gli interventi e per il diligente impegno con cui evita le banalità e le affermazioni troppo perentorie.
Sono già passate le ore più calde del pomeriggio e gli ultimi due nomi evidenziati sulla lavagna luminosa testimoniano l’ormai vicina conclusione della giornata quando gli eventi decidono di prendere tutt’altra direzione.
Pensieri, cose vere e un Mc Person 027
“La parola all’alunna Nicola Pontenegro, della sezione telecomunicazioni”. La voce del professore, che la stanchezza non sembra scalfire, rimbalza ancora una volta squillante tra le pareti dell’aula.
Né alta, né piccola, di età compresa tra i dieci e dodici anni, con quel nome un po’ buffo, un corpo rotondo e due occhi luminosi ed allegri, Nicola emerge d’un tratto dalla quarta fila. A vederla, non sembra patire alcuna emozione: lo sguardo alto, il passo sicuro, il timbro tranquillo durante i saluti di rito. Ma sono proprio le sue parole a segnare quello che gli avvenimenti susseguenti renderanno un giorno fatidico. Colui che prima o poi, presto o tardi, ritroverà da qualche parte il Mc Person 027 potrà leggere le seguenti testuali parole:
“Come ogni giorno anche stamani, venendo a scuola, mi sono fermata per qualche minuto in via degli Illuministi per ammirare la vetrina del negozio di giocattoli dei signori Boll e Strike, quando mi sono sentita chiedere: Nicola, perché? Al mio fianco, un uomo di circa cinquant’anni che, dedita com’ero ad osservare maschere e giochi, non avevo sentito arrivare. Ero sicura di non averlo mai visto prima: me lo confermavano lo strano accento da forestiero e un’eleganza d’altri tempi”.
“Probabilmente, avrei dovuto salutarlo e venir via ed invece, superando il forte imbarazzo, gli ho chiesto a mia volta: perché, cosa?”
“Con gli occhi stanchi e una tensione che il vibrare della voce rendeva evidente ha iniziato a parlare di un sogno di nove mesi prima, di un fiume dai colori luccicanti, di me e di lui a caccia di pesci e di pace. Ad un tratto, come per gioco, mi aveva chiesto quand’è che una cosa può dirsi vera e con non poco stupore mi aveva sentito rispondere . E allora, stavolta per davvero, mi aveva chiesto perché gli uomini non riescono a pensare la felicità. Ma, intanto, di me già non c’era più traccia”.
“Da allora, per nove mesi lunghi come nove vite, non aveva fatto altro che cercarmi in ogni parte del mondo e adesso che mi aveva ritrovata reclamava la sua risposta”.
“L’angoscia si era già impadronita di me quando improvvisamente il sole è scomparso tra i tetti e, con lui, il mio misterioso compagno di sogni”.
“E’ tutto il giorno che ripenso a quanto mi è accaduto e più passano le ore, più la paura svanisce e sento la sua inquietudine farsi mia. Perché dunque gli uomini non pensano la felicità?
Spero che tu che sei un re possa aiutarmi a trovare una risposta”.
Nicola Pontenegro, la felicità e il Sognatore Sconosciuto
Come è noto, tutto ebbe inizio quando gli dei presero a giocare con quelle enormi palle piene di energia e sentimenti: ad ogni scontro un’esplosione, ad ogni esplosione una nuova creazione. Fu la più straordinaria, divertente sassaiola di ogni tempo e non ci fu dio o dea che non ne rimase soddisfatto.
Solo per puro caso, un bel po’ di tempo dopo, qualcuno si accorse che, per quanto la si cercasse, non c’era traccia di civiltà.
Cominciare a domandarsi mille per come e altrettanti perché non era certo da dei. Essi si limitarono perciò a cercarla incessantemente ed in ogni luogo fino a quando, tanti e tanti anni, tante e tante ricerche dopo, non la trovarono negli occhi di un bambino. E da quel giorno i bambini godettero in ogni paese di grande considerazione.
Non c’è dunque da meravigliarsi se l’eco suscitata dalle vicende di Nicola è davvero enorme.
Con l’aiuto del potente Orange 7978 in dotazione alla questura viene tracciato un perfetto identikit del nostro uomo ed avviata una meticolosa ricerca in ogni parte dell’isola, mentre la curiosità e l’interesse della popolazione diventa, come del resto era inevitabile, ogni giorno più grande.
Scienziati e filosofi che, come è noto, non hanno mai smesso di domandarsi se la felicità esiste, perché non siamo felici e come fare per esserlo per sempre, non sembrano stare nella pelle per questa nuova ondata di celebrità. Per qualche tempo, infatti, non ci sarà cosa che possa esistere se non in funzione della conquista e della negazione della felicità.
Difatti, per le strade della capitale non si fa altro che parlare di Nicola Pontenegro, del suo strano racconto, di colui che i media hanno prontamente denominato il Sognatore Sconosciuto.
Ad essi sono dedicate le prime pagine di tutti i quotidiani e dalla più importante rete televisiva nazionale vengono trasmessi ogni giorno telefonate ed appelli. Si dice siano stati prodotti film e serial tv, editi libri e riviste. Di certo sono stati realizzati sondaggi.
Da dove giunge il Sognatore sconosciuto? Ritroverà la piccola Nicola? E perchè gli uomini non pensano la felicità?
Computer, ragazzi e storie a metà
Come ogni sera, Rien 11285E, il computer cantastorie, si interruppe di colpo. Se si dimostrò una sera assai singolare non fu dunque colpa degli eventi. In quell’intreccio di spazio e di tempo chiamato Net non c’era infatti ragione di pretendere, e neanche solo di sperare, che i destini di Matto Curiel, di Nicola Pontenegro, del Sognatore Misterioso o del professor Oid fossero in qualche modo svelati.
Ben altre conseguenze ebbero i sentimenti. Diversamente da ogni altra sera, gran parte dei buchinelcielodaiqualifiltralalucedell’infinito addensati nella piazza della Memoria non riuscì infatti a nascondere la delusione e men che meno il malcontento.
Di una situazione tanto ingarbugliata i più vecchi ricordavano un solo precedente: fu la volta che le sorti di un glorioso impero furono sul punto di dipendere dalla sfida senza senso tra due uomini che la magia di un re scrittore consentì di chiamare Napoleone e Kutuzov.
Agli occhi dei più giovani il tutto appariva invece per davvero incomprensibile. In particolare Rik Cardo, il più piccolo del gruppo, non la smetteva di domandarsi come fosse possibile che in quel posto dove tutto funzionava a meraviglia, dove fin dal principio non veniva tollerata la minima imperfezione, il cantastorie potesse continuare a sfornare storie a metà senza essere inviato alle officine riciclaggio o, meglio ancora, ai reparti di produzione energetica.
“Le domande che non si rispondono da sé nel nascere non avranno mai risposta” gli fece Carlo S. Akfak, estroverso e riccioluto amico del cuore. “Ho visto uomini spendere una vita intera a cercare la felicità. C’è chi l’ha inseguita in una balena bianca, chi nella scoperta di un mondo nuovo. Chissà che a noi non tocchi trovarla in una favola narrata per intero”.
Di altri discorsi non si ebbero notizia. Né di ulteriori proteste. Ma da allora gli specchi di Net restituiscono ombre piuttosto che immagini.
Cose di un altro mondo
Come ogni sera si tolse i chip ad uno ad uno e li ripose con cura, ciascuno al proprio posto. Erano i rari momenti nei quali quasi rimpiangeva il suo mondo, dove quelli come lui potevano tutto solo a volerlo. Era un ben strano mondo, nel quale non aveva esitato ad inventare personaggi ed intrecci di ogni tipo. E in ogni tempo.
Re e Faraoni, Cesari e Imperatori, Generali e Condottieri di quella parte non proprio piccola di universo erano per gran parte opera sua. A volte intrepidi, altre sanguinari, avevano tutti il difetto di non imparare mai niente. E le loro storie finivano inevitabilmente col finire tutte allo stesso modo.
Per questo, nonostante la fatica e gli anni, in fondo non gli dispiaceva essere approdato su quel pianeta fatto di quelle strane cose chiamate bit e chip.
Sembra fossero il segno di una nuova era anche se a dire il vero per lui erano poco più che parole tronche. Proprio come le storie che gli piaceva raccontare.
Informare Vuol Dire è ciclo di conferenze promosso dalla Fondazione Feltrinelli, dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e da AustroeAquilone.


La luce inconfondibile di questa lampada, e questa sala, mi riportano all’ottobre del novantuno, quando sono stato qui in occasione di un ciclo di seminari. Già in quella occasione abbozzai alcune delle idee che oggi vi vorrei proporre. Sono quindi delle idee un pò “vecchiotte”, che spero abbiano però il fascino delle cose che durano.
Mi soffermerò in sostanza su due questioni e, se avrò tempo, su una terza.
La prima ha a che vedere col tentativo di capire quale è la natura del disagio che possiamo provare quando ci troviamo di fronte a un mondo in cui molte cose cambiano assai velocemente. E’ un tipo di circostanze che riguarda il rapporto tra incertezza e risposte all’incertezza come risposte etiche. Proporrò quindi questioni relative a cambiamenti nell’ambito delle tecnologie o nell’ambito dell’impresa scientifica e tecnologica, che riguardino i modi di comunicare e il rapporto tra questioni di etica della comunicazione e questioni di bioetica sullo sfondo di cambiamenti, di alterazioni, di quanto per noi è abituale.
La seconda si può sintetizzare come il tentativo di comprendere la natura di quella che io chiamo la sofferenza socialmente evitabile, generata dal fatto che i nostri modi di vivere assieme, le istituzioni entro cui viviamo assieme, le pratiche sociali entro cui siamo inseriti sullo sfondo di quei cambiamenti, sono per noi un disvalore e quindi un antivalore, piuttosto che qualcosa che possiamo dire che per noi vale.
In sostanza credo che sarebbe per noi interessante, se ci poniamo il problema di un’etica sullo sfondo dei cambiamenti, piuttosto che inseguire una definizione di bene, partire da ciò che per noi sicuramente è male, e cercare di scostarci da esso. E’ questa misteriosa faccenda che io chiamo il principio della minimizzazione della sofferenza socialmente evitabile come principio guida di un’etica sullo sfondo dei cambiamenti. Ed è un principio che implica necessariamente un chiarimento della natura della sofferenza socialmente evitabile.
La terza questione, che spero di avere il tempo di discutere, si può definire come un tentativo di applicare l’analisi sviluppata nel secondo punto ad un termine che personalmente continuo a ritenere importante: progresso. Credo infatti che si debba poter pensare che cosa mai possa voler dire, a pochi anni dalla fine del secolo breve, che qualcosa sia progressista e qualcosa non lo sia.
Veniamo dunque al primo punto: la natura del disagio. Credo si possa dire che viviamo ordinariamente in un paesaggio che è caratterizzato da una partizione provvisoria fra quanto è certo, un ammontare di credenze certe, e un campo in cui possiamo mettere le incertezze. Questo è quanto caratterizza la vita ordinaria di ciascuno di noi nei rapporti coi propri colleghi, i propri figli, i propri progetti, le proprie aspirazioni. Ed in una siffatta situazione è evidente che il confine fra il capitale di certezze di cui disponiamo per orientarci nel mondo e metterci alla prova con gli altri, e l’incertezza che increspa, che può svalutare questo determinato capitale è esso stesso provvisorio.
Pensate ad esempio ad una persona che si ritrova d’improvviso con le proprie conoscenze tecnologiche completamente fuori mercato e che vede dunque totalmente svalutato il proprio patrimonio di certezze; o pensate a colui che scopre che sta vivendo l’esperienza dell’amore proustiano, con tutto il bagaglio di incertezza che questo comporta.
Sono convinto che si debba guardare sempre con attenzione alla partizione provvisoria tra certezza e incertezza, al non sapere più precisamente che cosa sia bene e male, che cosa sia giusto e ingiusto, o almeno non saperlo allo stesso modo di quando le partizioni di certezze ed incertezza erano stabili, per rendere conto del disagio etico. Del resto, perché si parla tanto di etica? Perché ce ne è poca. Ogni due giorni sui giornali c’è chi sottolinea che manca l’etica, oppure che “qui è un problema di etica” e questi sono gli indicatori del fatto che siamo molto incerti, che le teorie e le pratiche che ci accompagnano nella nostra vita quotidiana sono incerte . Questa è la mia tesi di base.
Cosa fanno, tenendo conto di questa partizione tra certezza e incertezza instabile e provvisoria, quelle che noi convenzionalmente chiamiamo innovazioni tecnologiche? Si può dire che le innovazioni tecnologiche riarredano in maniera inaspettata, quelle che io chiamo, come fossero degli appartamenti, le residenze a cui siamo abituati. E quando ciò ha luogo ciascuno tende a ridurre queste incertezze apprestando teorie che mirano alla condivisione con gli altri. Non mi riferisco a cose solenni, ma a quanto normalmente facciamo nelle esperienze ordinarie della vita quotidiana. E’ in questo modo che rispondiamo alla minaccia della sorte e della solitudine involontaria. Se si svaluta il capitale di certezze vuol dire che io non so più bene qual è la compagnia dei miei. Se rispondo all’incertezza mirando a costruire una teoria che generi condivisione, vuol dire che io cerco di ricostituire una compagnia dei miei o dei nostri, non importa se con un confine molto ampio o più ristretto, e che questo è un bene per me, in quanto l’alternativa sarebbe la condanna alla solitudine, quando naturalmente la solitudine sia involontaria.
Tutte quelle circostanze in cui noi proviamo l’esperienza di ciò che io chiamo “l’inaspettato”, o se volete, con un po’ di civetteria, del “perturbante”, di queste residenze riarredate da altri, le chiamo circostanze del disagio di un etica o, con una battuta, le circostanze delle stanze di albergo di Proust.
Proust andava spesso in albergo, per scopi sublimi e loschi, e quando entrava in una stanza di albergo a volte la sentiva nemica. Egli sentiva che le stanze gli parlavano e se gli parlavano male provava una sofferenza terribile. La mia residenza è una residenza in cui io sono in equilibrio con me stesso e sono in equilibrio cogli altri; se c’è squilibrio la residenza è come straniera. Credo che questa storiella sulla stanza d’albergo di Proust possa gettare luce sugli effetti della trasformazione dei modi in cui siamo abituati a comunicare con altri, a vivere con altri e sul disagio dell’etica alla fine del secolo breve in cui tante cose stanno cambiando. E che questo sia alla fine più interessante che consolarsi, come fanno molti filosofi, con le vecchie storielle sul destino della scienza e della tecnica.
Una delle risposte tipiche a questi sfondi di alterazione, di increspatura della distribuzione certezza – incertezza è una risposta canonica, elaborata da filosofi anche eminenti, ed è la storia che la scienza è cattiva, che la tecnica è il destino dell’Occidente, che bisogna andare oltre l’Occidente, dietro l’Occidente, nel nulla. Personalmente credo che questa sia una risposta un po’ caricaturale. Noi sappiamo, come si usa dire, che l’impresa scientifica avanza e forza i limiti giorno dopo giorno; sappiamo che anche la faccenda del confine tra scienza e tecnologia, tra teoria e applicazione è nella maggior parte dei casi intricata, e comunque sempre più intricata di quanto non sostenga la tesi in fondo consolante che un conto è la teoria ed un altro è come la si applica.
La gamma di quanto noi possiamo casualmente fare si ampia e si dilata con ritmo inesorabile soprattutto per quanti sono esclusi dalla cerchia di coloro che monopolizzano la verità su ciò che avviene al mondo. Quando ci poniamo dilemmi etici sullo sfondo di cambiamenti e innovazioni tecnologiche è perché ciò di cui possiamo essere casualmente responsabili aumenta, quindi l’ambito di scelta aumenta e ad esso ovviamente corrisponde l’aumento dell’ambito della responsabilità. Quante più cose possiamo fare, tanto più ci poniamo il problema se è giusto fare quello che possiamo fare.
Mi piace ricordare l’esempio delle discussioni in bioetica, perché mi sembra quello intuitivamente più forte. Se possiamo fare sì che nascere possa voler dire nascere da fecondazione eterologa o da fecondazione omologa, se possiamo controllare i processi del morire, allora le questioni di entrata nella vita e di uscita dalla vita sono questioni su cui le nostre possibilità causali, cioè ciò di cui possiamo essere causalmente responsabili sono più numerose di quanto non fossero trenta anni fa o venti anni fa.
Cambia il che cosa voglia dire nascere o far nascere e il che cosa voglia dire morire. Sono piuttosto bizzarri i modi in cui uno può dire che è figlio di qualcuno, e il modo in cui si può dire che un pezzo di sé o il pezzo di un altro è espiantato. Sono cose un po’ strane, cose cui semplicemente noi non siamo abituati. Se mia nonna, donna straordinaria illuminata, aperta, avesse sentito le diavolerie dei siti internet, chissà cosa avrebbe pensato! Contemporaneamente non si scrivono più lettere d’amore e mia nonna era abituata alle lettere d’amore.
Questo mondo di fax, per non parlare dell’email, è un mondo in cui i pronipoti dei grandi competenti monopolisti della competenza archivistica saranno disoccupati, (faranno altre cose naturalmente), ma il problema vero è che siamo di fronte ad un aumento delle capacità di generare effetti su cose, su stati del mondo e su vite di persone e quanto sembrava sottratto all’ambito della scelta entra nell’ambito di ciò che noi possiamo scegliere di fare o non fare. E questo genera un problema di responsabilità.
Nessuno si mette in testa di giustificare eticamente la legge di gravità : solo dei fisici pazzi, che poi sono le persone più straordinarie, quelle più vicine ai poeti e ai musicisti, potrebbero farlo. Perché? Banalmente perché noi non scegliamo, non è in genere di nostra competenza che la legge di gravità sia la legge di gravità o che la costante di Plank sia la costante di Plank. Tutto ciò che è fuori del dominio di scelta non implica l’onere della giustificazione. Ma ciò che è nel dominio di scelta implica l’onere della giustificazione. Far nascere in un modo piuttosto che in un altro, e comunicare in un modo piuttosto che in un altro e lavorare in un modo piuttosto che in un altro sono tre tipi di variazione e di trasformazione che fanno parte di ciò che non viene dal cielo ma dipende da scelte nostre o di altri e quindi genera l’onere della giustificazione.
Questo è il punto che mi interessa sottolineare. Se lasciamo stare i luoghi comuni sul destino dell’occidente, sulla scienza e la tecnica cattive, oppure della scienza buona e della tecnica cattiva, e prendiamo sul serio la responsabilità che abbiamo, troveremo, di fronte ai cambiamenti, all’aumentare degli ambiti di scelta, delle cose che possiamo fare, degli effetti che questi possono avere su vite presenti e su vite future, lo sfondo dell’incertezza cui dobbiamo rispondere per ridurla condividendo con altri le risposte giuste su ciò che dobbiamo fare e su come dobbiamo vivere. Questo è il mio punto di vista per quanto riguarda la questione della natura e del disagio in un mondo che cambia.
Vorrei ora tentare di gettare luce sull’idea di quale sia la natura del male, quando c’è, la natura di ciò che correliamo all’ingiustizia. Qualsiasi teoria della giustizia parte dal senso d’ingiustizia. Le teorie della giustizia sono le risposte al senso dell’oltraggio morale, o sono le risposte all’incertezza su ciò che collettivamente è giusto, e, quindi, cercano di costruire comunità di condivisione cogli altri, di criteri che ci orientino nel valutare, nel modellare i nostri modi politicamente, istituzionalmente o socialmente.
Qual è la natura della sofferenza socialmente generata? La maggior parte delle sofferenze sono sofferenze solo in parte socialmente generate, ma a volte ci sono delle sofferenze di questo tipo che, in quanto tali, sono socialmente evitabili, perché rientrano nell’ambito della scelta. Se vi è sofferenza e se l’esservi sofferenza deriva dall’essere le istituzioni o le pratiche sociali in un certo modo piuttosto che in un altro, dovremmo porci la questione di quali istituzioni, di quali pratiche sociali siano giustificate, in quanto riducono, per quanto è possibile, l’ammontare di sofferenza socialmente evitabile. Pratiche pubbliche che non generano mali pubblici ma cercano di minimizzare i costi (se uno non ha una visione così euforica da dire di massimizzare i benefici).
Ancora a proposito della sofferenza sono personalmente convinto che, come dice un filosofo brillante e ironico, spesso incoerente ma certo suggestivo come Richard Rorty, noi non condividiamo con gli altri esseri umani la capacità di provare dolore, dato che questa la condividiamo con tutti gli esseri senzienti. Ad esempio il mio cane Scott può provare dolore (sappiamo tutti che, così come noi, i nostri compagni animali provano dolore). Quello che è tipico di tipi come noi, cioè di animali umani, ciò che fa la differenza, è il fatto che siamo animali linguistici.
Come sapete abbiamo sempre cercato di rispondere alla domanda “chi siamo?” Animali razionali, res cogitantes, spettri nella macchina, ghiandole pineali. La mia proposta è quella di prendere sul serio il fatto che siamo animali linguistici, e che la natura del linguaggio è una nozione importante per rendere conto della natura della sofferenza socialmente evitabile. Vediamo perché, e perché è legato ad alcuni accenni che ho fatto prima, cercando di gettare luce sulla natura del disagio etico in un mondo che cambia.
Il linguaggio per noi non è un optional. E’ difficile immaginarci come animali non linguistici, cioè gli stessi senza aver comprato (che poi costa moltissimo nei listini d’acquisto) il linguaggio: non potremmo pensarci come esseri pensanti, se tirassimo via il linguaggio. “Cogito ergo sum” è una versione troppo breve, meglio si dovrebbe dire “loquor et ago et patior, ergo sum”. Ma qual è la caratteristica saliente del linguaggio? Che il linguaggio è un arte sociale, un’istituzione sociale. Non c’è bisogno di Wittgenstein, di Quine o di Vico: é noto che il linguaggio è un arte sociale, e il linguaggio implica l’idea di una comunità di parlanti. A questo proposito c’è un argomento standard molto affascinante in filosofia sulla possibilità del solipsismo linguistico. Voi non potete immaginare un linguaggio e pensare che ci sia un solo parlante quel linguaggio, perché lui non saprebbe che linguaggio parla e neanche gli altri potrebbero saperlo (c’è dunque un interessante argomento sul linguaggio privato).
Il linguaggio è pubblico. Pubblico nel senso che implica la condivisione. E la comunità dei parlanti suggerisce l’idea che vi debba essere una qualche reciprocità o mutualità di riconoscimento tra i partners, in questo caso tra i parlanti che condividono lo stesso linguaggio, o la stessa teoria dell’interpretazione del linguaggio. E tutto questo ha a che vedere con una prima elementare idea di dignità dei partners cooperanti nell’impresa collettiva del linguaggio. E la dignità ha a sua volta a che vedere con l’inclusione nella comunità linguistica e in questo senso con la rete stabile dei riconoscimenti mutui, perché esclusione e mancato riconoscimento, o deficit di riconoscimento, generano quella particolare specie di sofferenza, che a me sembra essere la sofferenza sociale, politica o civile par excellence (nel senso che è propria di chi è agente con altri in comunità, a confini variabili, nel tempo e nello spazio) che potremmo definire come esperienza della umiliazione o della degradazione. Io credo che l’umiliazione, per animali linguistici, sia l’erosione dell’autonomia delle persone, e che quest’ultima induca il collasso del rispetto di sé e la sconnessione da valori condivisi da comunità quali che siano.
Se considerata nella sua forma simbolica, l’umiliazione è scomunica, nel senso di ex comunitate, fuori dalla comunità. Essa diventa invisibilità nella comunità o esclusione dalla comunità, e si potrebbe anche sostenere che quanto non viene riconosciuto, in questo caso, è esattamente la pari dignità di te o di me, come partner reale o virtuale di una conversazione o più precisamente di una catena connessa di transazione linguistica e non linguistica. E’ come dire che “il club ci esclude ” o ” il ghetto ci esclude”. Sapendo che ci sono vari ghetti e vari club. Un disoccupato ad esempio ha una prospettiva strutturale permanente di esiliato in patria. Questa è umiliazione. Ma ci sono casi meno solenni e meno tragici, come ad esempio, a proposito degli amori proustiani, le lettere d’amore, le conversazione d’amore con una donna o un uomo che amate in una lingua che non padroneggiate. O ancora pensate al disagio linguistico quando non controllate molto bene una lingua e siete in una comunità o siete a cena e avete finito di fare la relazione al convegno in cui tutti parlano più o meno il falso inglese.
Mi ricordo che questa idea dell’esclusione dalla comunità linguistica mi venne in realtà da un’immagine primitiva, come si diceva un tempo nella psicoanalisi, quando nell’università c’erano forme di deferenza molto più istituzionalizzate di quelle di oggi. C’era un bravissimo professore di storia della filosofia dell’università di Milano, dove io lavoravo allora, che parlava con un altro ordinario mentre io ero assistente. A quei tempi tra ordinario ed assistente c’era visibilmente un problema di caste, cosicchè loro riuscivano a parlarsi mentre io, nonostante fossi in mezzo, ero come invisibile. E lo ero di certo rispetto a chi era nella comunità dei pari. Allora cosa facevo? Parlavo con l’altro assistente, con un mio pari, perché questa era la mia risorsa per non essere esiliato, per non essere solo. La mia tesi è che tutti i meccanismi che generano questa sorta di condanna alla solitudine involontaria sono meccanismi e pratiche variegate che umiliano gli esseri umani.
Faccio solo un accenno al terzo punto. Mi domando se abbia senso demarcare una prospettiva, un criterio, un modo per orientarsi nelle scelte individuali e collettive che implichi il ricorso ad una nozione di cosa è progresso. In altri termini: ha senso dire che una cosa è meglio di un’altra?
Dal punto di vista storico l’idea di progresso, la fiducia, la credenza nell’idea del progresso come un processo di perfezionamento che va da un terminus a quo ad un terminus ad quem, è una parte molto breve della vicenda europea: esso è in realtà l’eccezione di circa un secolo di élite intellettuali britanniche e francesi, in parte tedesche, in parte italiane.
In verità le difficoltà che si possono avere nel maneggiare questo termine, che è in discredito, dipendono da un fatto buffissimo, da una specie di paradosso: quanto più una società ha generato opportunità e, per quanto è possibile, tutela diritti, e quindi, in un certo senso, quanto più è progredita, tanto più si aprirà l’inchiesta sulla complicazione della nozione di progresso. Insomma il fatto che ci sia incertezza su ciò che voglia dire progressivo, progresso, è indice di progresso.
Ma qual è la natura dell’incertezza a proposito del progresso, se non hanno ragione coloro, che io credo non abbiano ragione, che dicono che il progresso è da buttare via? A mio avviso essa deriva dal fatto che noi sappiamo che la nozione di progresso, un’idea di progresso, si deve pensare su una varietà di dimensioni e non su una sola. Faccio un esempio: è naturale che l’ultimo modello di ennesima generazione possa essere definito come un progresso rispetto al precedente. Anche un filosofo che pensa che il destino dell’occidente sia nullo se ha il figlio con la febbre sarà contento che il medico gli dica: abbiamo fatto progressi. Capiamo cosa vuole dire progresso nella capacità di rendere per esempio meno maledettamente inquinate le residenze in cui viviamo. E se le politiche per il trattamento dei rifiuti implicano che tecnicamente possiamo fare cose che prima non si potevano fare, diremo che bisognerebbe fare quella roba lì, perché quella roba lì è meglio di quella precedente, dà più benefici e meno costi. Così come diremo che un teorema che mostri che il teorema di Godel si può integrare sarebbe straordinario, sarebbe un vero progresso per la scienza. Chi potrebbe metterlo in questione? E comunque anche se lo mette in questione addotta sempre un criterio per cui qualcosa è meglio di qualcos’altro, e in questo costituisce un progresso rispetto allo stadio precedente. Qual’è allora il problema? Semplicemente questo: se le dimensioni a cui attribuire punteggi in termine di progresso sono più d’una, può darsi che vi sia conflitto tra dimensioni e che per questo non sappiamo che punteggio dare a ciascuna dimensione.
Un’idea progredita di progresso è un’idea in cui si sa che con quel termine si deve disporre di un’informazione plurale su più dimensioni e quindi si prende sul serio l’inevitabile conflitto che può sorgere fra i punteggi su una dimensione, i costi e benefici su una dimensione, i punteggi, i costi e i benefici su altre.
Qualcuno ha sostenuto che l’idea di progresso in fondo possa essere concettualizzata alla fine di questo secolo nei termini di una qualche idea di crescita, di ascrizione, di tutela, e soprattutto di diritti per uomini e donne qua e là per il mondo. La mia domanda è: perché i diritti sono importanti? E perché è così terribilmente importante, quando siano giustificati e quando siano meritevoli di tutela, l’interesse che le persone tutelate siano protette? E’ importante perché i diritti sono le risorse per minimizzare la sofferenza sociale, sono le briscole con cui stoppiamo le manovre di esclusione, di umiliazione, di degradazione.
Allora io credo che, in coerenza con queste poche battute sul terzo punto, potremmo accettare l’idea che dovremmo essere intransigenti con ciò che è male, non dovremmo praticare la tolleranza verso ciò che è male, nel senso che ho detto, e dovremmo nello stesso modo essere libertari verso ciò che variamente può essere per noi bene.

Per un giornalista parlare di media nella società dell’informazione è un po’ come muoversi in un labirinto di specchi.
Nella società dell’informazione le dinamiche della società e quelle dell’informazione tendono infatti a convergere e a confondersi così come quelle dei media con quelle dell’informazione. A ciò si aggiunge il “mestiere” di giornalista, un ruolo dentro i media, che a me fa pensare che ogni cosa che tocco rimanda a mille altre. E’ come essere di fronte ad una serie di pagine web, piene di link, ed essere consapevoli che il discorso può prendere mille strade diverse.
Ma poichè una bisogna pure imboccarla io lo faccio dicendo che i media presentano aspetti di forte continuità ed altri di forte discontinuità.
La grandissima continuità sta nelle funzioni. Se pensiamo all’evoluzione dei media nel contesto della società agricola, nel contesto della società industriale ed in quello in cui viviamo ci rendiamo conto che in fondo esse possono essere richiamate dai tre media fondamentali della società agricola: il campanile, la fontana e il portalettere.
Il campanile è il broadcasting, una centrale che possiede l’informazione e l’invia a tutti in maniera estremamente fruibile, molto facile da riconoscere, e dando le notizie utili in tempo reale: sta per cominciare la messa, stanno per arrivare i saraceni e altre cose di questo tipo. La fontana è il medium dei piccoli gruppi: le ragazze si trovano alla fontana a prendere l’acqua e cominciano a darsi le notizie sul loro gruppo. Esempi di luoghi e di piccoli gruppi così se ne possono fare tanti, la fontana è solo uno di essi. Il portalettere invece fa più o meno, nella società agricola, quello che fa adesso, magari un po’ più efficientemente.
Le tre funzioni sono dunque queste. Broadcasting: da una centrale a tutti, in modo semplice. Fontana: luogo di comunicazione all’interno di gruppi chiusi. Portalettere: comunicazione efficiente a due o a più persone, ma essenzialmente legata alla comunicazione tra poche persone.
Il campanile, che poi diventa la radio, e poi ancora la televisione, presenta una fortissima barriera all’entrata. Sono molto pochi coloro che possono organizzare un campanile così come fondamentalmente sono pochissimi coloro che riescono a organizzare proprie reti televisive effettivamente competitive sul mercato. La fontana invece non è dotata di particolari barriere all’entrata. La barriera è piuttosto rappresentata dalla dinamica culturale che definisce il gruppo che si ritrova alla fontana, alla macchinetta del caffè, sul posto di lavoro, in piazza. Il portalettere ha una funzione estremamente semplice, leggibile, posto che si sappia scrivere e leggere. Qui la barriera, la difficoltà, il fatto organizzativo che determina qualche cosa di importante è l’organizzazione dei portalettere, che poi diventa l’organizzazione del telefono, del fax, e via dicendo.
L’organizzazione che costruisce l’infrastruttura è importante dal punto di vista dei media. Quando ad esempio essa sceglie di fare una strada che conduce da un paese a un altro, lasciandone fuori un terzo, dà automaticamente importanza ai messaggi che passano tra i paesi collegati, mentre riduce l’importanza di quelli che possono nascere ed essere ricevuti nel terzo paese non collegato. Le funzioni sono dunque ancora quelle. Ciò che effettivamente cambia molto sono le tecnologie e i contesti sociali.
Si è soliti ricordare che Silvio Berlusconi, all’inizio degli anni Ottanta, disse una frase del tipo: “oggi non è tanto importante ricercare la ricchezza o il potere, ma la popolarità, perché da essa discendono la ricchezza e il potere”. Non so se lo abbia detto o no, o se semplicemente gli è stata attribuita, però è sicuramente una frase che fa pensare.
Proviamo adesso a domandarci cos’è per noi questa società dell’informazione. Ci sono due elementi definitori molto importanti: la materia prima fondamentale nell’economia della società dell’informazione è l’informazione e quindi tutte le strutture che la trattano, la producono e la trasportano; nella società dell’informazione c’è una certa coincidenza tra le strutture del potere e le strutture del potere dell’informazione. Posto che adesso stiamo vivendo nella società dell’informazione e che si possa immaginare che entro cinque anni saremo nella società dell’informazione digitale, ci potremmo chiedere se questo passaggio può determinare dei cambiamenti nella struttura di potere, e quindi nelle scelte, e magari nelle responsabilità.
Come dice Salvatore Veca, potremmo chiederci se per la nostra società tale passaggio possa considerarsi un progresso. Per dire cosa può significare il passaggio dalla società della comunicazione alla società della comunicazione digitale, dobbiamo vedere in che cosa cambiano i media passando dalla forma analogica a quella digitale. Forse è utile a questo punto sottolineare che ci sono sempre tre dimensioni nei media. C’è la dimensione del trasporto dell’informazione, la dimensione degli strumenti tecnici di produzione e di ricezione e la dimensione della creazione dei contenuti e dalla capacità di comprensione dei contenuti.
Cosa sta avvenendo? Nell’ambito degli strumenti tecnici, c’è stata negli anni ottanta una evoluzione dirompente. I computers hanno preso il possesso fondamentale della produzione e del trattamento dell’informazione. Tutta l’informazione, dai giornali che abbiamo in mano alla televisione e a tutti gli altri media tradizionali, è comunque prodotta dai computers, i quali fanno in modo che sia fondamentalmente lo stesso genere di oggetto una fotografia, una parola, un immagine in movimento, un suono. Sono sempre bit, trattati da programmi diversi, che fanno in modo che si esprimano, siano visibili e recepibili sotto le diverse forme a cui siamo abituati.
Gli strumenti tecnici, e in particolare i computers, evolvono a una velocità molto grande. La capacità di elaborazione dei computers aumenta infatti da decenni del doppio ogni diciotto mesi, e tutto questo non accenna a rallentare. Nelle lunghe interviste che ho fatto al presidente dell’Intel, la società che produce l’ottanta per cento dei microprocessori dei computers, e ad altri esperti, emerge che nella peggiore delle ipotesi questo rallentamento arriverà tra sei anni. Dati i meccanismi di produzione attuale, avremo per sei anni questo genere di evoluzione e quindi il computer che sta dentro il meccanismo di produzione dell’informazione, di trattamento, di elaborazione crescerà a questa velocità ancora per almeno sei anni.
Già oggi un settimanale come Panorama è prodotto tutto su computers, dei piccoli Macintosh. Tutto il materiale che abbiamo, foto o parole che siano, è dentro i nostri computers in rete, e solo all’ultimo momento diventa atomi, come dice Negroponte, carta. Se lo volesse la Mondadori, Panorama sarebbe ovviamente totalmente fruibile anche attraverso i computer.
Uno stesso processo è in atto nella televisione. Naturalmente tutti utilizzano la telecamera, che di solito è ancora analogica, però le riprese vengono successivamente scaricate su computers. Alla Fininvest hanno appena comprato tre PC da 120 milioni l’uno, ci mettono dentro tutte le immagini e i suoni e il mixaggio avviene esattamente come avviene la costruzione di un testo su un calcolatore, con taglia e incolla di tutti i pezzi di informazione. Da tutto questo possiamo trarre una prima conclusione: nella produzione l’era digitale è già una realtà.
La novità che ha favorito l’esplodere dell’attenzione attorno ai nuovi media digitali sta nel fatto che anche nel trasporto si è diffusa questa forte dinamica innovativa. Per dirla in breve nelle telecomunicazioni si è affermato il modo di produrre e di trattare le informazioni tipico dell’elettronica, con una dinamica dell’innovazione anche lì molto veloce. In questo momento la capacità di trasmissione delle telecomunicazioni è addirittura più veloce di quella dei computers. Cioè cresce e raddoppia in un tempo inferiore ai diciotto mesi. Questo di fatto ha creato una piattaforma nuova per l’informazione. (La piattaforma è l’insieme di quei meccanismi per la produzione, il trasporto e la ricezione dell’informazione tipo l’Internet o il satellite digitale).
Di internet parlo fra un attimo. Del satellite digitale parlo subito perché è ancora più facilmente definibile nel ragionamento che sto cercando di proporvi. Il satellite è stato lanciato il 19 novembre e si chiama Hot Bird II. Contiene una serie di aggeggi che si chiamano transponder e che rimanderanno sulla terra i segnali mandati da terra. Ogni pezzo del satellite viene affittato da organizzazioni che una volta erano editori, broadcaster di televisione e che adesso sono effettivamente un misto di telecomunicatori ed editori di broadcaster. In particolare Telepiù ha preso una grossa fetta di questi transponder, perché si propone di vendere questo nuovo genere di televisione che si chiamerà paper view.
Sono le nuove forme di fruizione della televisione per cui con un unico abbonamento si possono avere cinquanta e nell’arco di un anno e mezzo cento canali. Questa quantità di canali verrà ricevuta da una macchina che dovremo comprare, collegata a una antenna satellitare che ci metterà in condizione di ricevere e scegliere all’interno di cento canali. È interessante il fatto che siano cento e che siano cento perché sono digitali, perché se fossero analogici non sarebbe possibile tutta questa quantità di informazione. È interessante perché nella quantità di canali l’editore delle emissioni ha una occasione, quella di proporre contenuti per pubblici molto specialistici. Dato che ci sono tantissimi canali, la produzione che le tv satellitari digitali si propongono di fare è una produzione che, assieme ad un po’ di informazioni generali, si segmenta in piccole nicchie di interessi.
Internet ha più o meno le stesse caratteristiche. In particolare dal punto di vista dell’utente moltiplica la possibilità di scelta non per cento ma per milioni. Ci sono due milioni e mezzo di computer che contengono una quantità notevole di programmi, ai quali si può accedere attraverso Internet, che hanno una volontà commerciale, che vogliono cioè proporsi come aziende di produzione di contenuti mediatici; assieme a questi ci sono moltissimi altri computer collegati che hanno altre funzioni.
Quello che è interessante dell’Internet è che sulla stessa piattaforma sono presenti tutte e tre le funzioni di cui parlavamo prima: il campanile, la fontana e il porta lettere. Il broadcasting viene fatto attraverso dei programmi che inviano lo stesso genere di informazioni a tutti gli abbonati. La fontana è rappresentata da questi luoghi che si chiamano news group dove uno accede perché ha un interesse particolare, è interessato a un argomento, appartiene a un gruppo etnico, a un gruppo linguistico in particolare. Il portalettere è proprio la posta elettronica, la cosa più importante di Internet, quella che viene usata più regolarmente dalla maggior parte dei suoi trenta milioni di abbonati.
In effetti sappiamo che in questo momento il numero di messaggi in posta elettronica negli Stati Uniti ha superato il numero dei messaggi di carta ed anche se non vuol dire niente dal punto di vista pratico rappresenta dal punto di vista simbolico una pietra miliare. Abbiamo dunque un’unica piattaforma digitale, quindi trasporto e trattamento delle informazioni, che fa tutte e tre le funzioni dei media di cui abbiamo parlato prima.
La tecnologia in questo caso che cosa determina? Determina la fusione di tutta la parte organizzativo produttiva dei media in un unico meccanismo e possiamo a questo punto scegliere che genere di funzione del medium vogliamo utilizzare in un determinato momento. Nella fase precedente invece la televisione era solo broadcasting, il portalettere solo un portalettere e il telefono fondamentalmente uno strumento per parlare fra due persone. La fontana o la macchinetta del caffè non è che avessero degli eredi particolarmente interessanti ed anzi si può dire che nella società dell’informazione predigitale quella più penalizzata era proprio la funzione del luogo di aggregazione, dei gruppi di interesse più piccoli.
Sul piano degli sviluppi sociali la cosa più rilevante da dire è che sia nel caso della televisione digitale, con i suoi cento canali, le nicchie, i pubblici specializzati, sia, ancor più evidentemente, con Internet, abbiamo dei mezzi che tecnologicamente consentono il ritorno in auge di una delle funzioni dei media che venivano molto penalizzate nel precedente sistema e cioè quello del luogo d’incontro dei piccoli gruppi, delle nicchie di interesse, dei gruppi etnici, dei gruppi linguistici, dei gruppi di condivisione di qualche cosa che poi sono anche i luoghi dove si costruisce l’identità, dove ci si riconosce.
La seconda conclusione può essere quindi la seguente: sono aumentate le possibilità di scelta di chi vuole, attraverso i media, ritrovare una identità, intentendo in questo caso l’identità come il bisogno di avere un linguaggio comune con le persone che hanno interessi in comune.
Ovviamente tutto questo non produce solo effetti positivi. La tecnologia di fatto non determina niente da sola. La terza dimensione dei media, che poi è in fondo quella più importante, quella dei contenuti, non dipende dalla tecnologia. La tecnologia è solo una opportunità, e qui direi che c’è il punto chiave della vicenda. Possiamo stendere le fibre ottiche in parte d’Italia, se non c’è niente di interessante dentro la gente non le userà. Il punto è allora: come vengono prodotti i contenuti?
Nella “vecchia” società dell’informazione c’era una forte concentrazione della produzione dei contenuti per cui solo grandissimi editori, grandissimi broadcaster, controllavano la produzione della maggior parte delle cose. Se è vero che i nuovi media avranno uno sviluppo, le opportunità che danno le danno soprattutto ai piccoli, a quelli che nascono con un idea di contenuto da realizzare e con una probabilità di ottenerne un ricavo, economico, sociale o politico che sia.
Austro e Aquilone in questo senso è un esempio, piccolo ma significativo. E’ una rivista che ha una direzione a Milano, la redazione e soprattutto i grandi animatori dell’associazione a Napoli, collaboratori in tutta Italia. Soprattutto non ha una lira e quindi fondamentalmente non sarebbe stato possibile farla senza la posta elettronica che è un sistema di bassissimo costo che determina bassissime barriere all’entrata per la produzione per lo meno dei contenuti.
E questo è vero per moltissime altre iniziative, adesso non voglio farne un elenco, però nascono gruppi di giornalisti indipendenti, freelances che vogliono avere un rapporto diretto con i lettori senza la mediazione dei direttori e dei grandi editori e questo in Italia è il caso di Reporter On Line del quale tra l’altro faccio parte. Esistono singoli designer sconosciuti che hanno raggiunto una notorietà mondiale facendo vedere di che cosa sono capaci con i loro siti su Internet. Esistono tutta una serie di casi nei quali a partire dai contenuti piccoli innovatori sono riusciti a raggiungere risultati importanti.
Terza conclusione: la nuova tecnologia è essenzialmente un mondo di opportunità nuove soltanto per chi le sa cogliere. Qui si pone la decisiva questione dell’inclusione e dell’esclusione di cui parla Salvatore Veca. Ancora una volta direi che non c’è particolarmente niente di nuovo, nel senso che anche il portalettere fondamentalmente serviva solo a chi sapeva leggere e scrivere. I meccanismi di inclusione e di esclusione non dipendono a mio avviso dalla tecnologia.
La tecnologia ha due fortissime dinamiche innovative. La prima è quella del punto più avanzato dell’innovazione, che è comprensibile esclusivamente dalla parte più esoterica dell’Internet, in questo momento più o meno un milione di persone nel mondo. La stessa tecnologia però, per rendersi economicamente valida, tende a semplificarsi per aumentare il proprio mercato. Molto presto ci saranno televisioni che navigheranno su Internet col telecomando in modo molto simile a quello che facciamo con la televisione attuale ed assisteremo al crollo dei prezzi per quanto riguarda l’hardware e le macchine che servono per accedere a Internet. Ovviamente non avremo una esplosione delle persone che sono interessate a questo medium fino a quando i contenuti non saranno veramente popolari o caratterizzati da elementi di interesse generalizzato.
I meccanismi di esclusione ed inclusione riguarderanno dunque quelli che capiscono Internet o che comunque che ne capiscono gli sviluppi più avanzati e quelli che lo usano senza capirlo. Nella seconda fascia c’è ovviamente una maggiore difficoltà a cogliere l’opportunità creata dai nuovi media, però possiamo dire che un grosso editore ed un singolo sono molto più alla pari di quanto non fossero nel precedente scenario tecnologico. Nell’ambito degli inclusi c’è dunque un cambiamento di scenario abbastanza interessante da segnalare.
Un’altra forma di inclusione importante è appunto quella delle nicchie. E’ vero. La televisione è fruibile dal novantasette percento degli italiani senza nessuna competenza tecnologica e Internet in questo momento è fruibile da quattrocentomila persone con atteggiamenti tra l’altro tra loro molto diversi: in questo dato c’è già un significativo rapporto di inclusione e di esclusione. E’ altrettanto vero però che moltissime persone che non si riconoscevano nei contenuti della televisione generalista, che era tale perchè doveva essere tutta uguale per tutti, e quindi tendenzialmente distruggeva le nicchie di interessi diversi, trovano e ancor più troveranno in questo nuovo media un proprio spazio. Questa mi sembra una forma di inclusione molto importante in una società che tende ad essere multietnica, multilinguista o comunque più tollerante per le diversità.
L’ultima cosa che mi resta da dire è che per quanto, dal punto di vista dei contenuti, gli effetti siano abbastanza libertari, c’è un elemento di potere che rimane abbastanza intonso, senza interventi di pubblica opinione significativi, ed è quello del trasporto, dato che effettivamente a questo livello la scelta di chi fa le strutture di trasporto ha sempre più o meno lo stesso valore che aveva prima.
Se il telecomunicatore decide di portarci da un paese A ad un paese B e di escludere il paese C, il paese C è escluso, ed è difficile che si possa da solo rimettere in corsa. A questo problema tenta di rispondere indubbiamente una legislazione europea che va nella direzione della liberalizzazione e dell’aumento della concorrenza e quindi in un certo senso anche dello stimolo alle innovazioni per tutti i telecomunicatori. E bisogna riconoscere che per quanto riguarda l’Italia anche la Telecom si sta muovendo in questa direzione. Non c’è dubbio però che, saranno due, tre o cinque, i trasportatori dell’informazione saranno sempre pochi.
Da qui la quinta e ultima conclusione: c’è un problema di dominio pubblico sulle scelte significative per rendere possibile l’accesso diffuso di queste nuove tecnologie in maniera che i loro effetti principali possano essere fruibili dalla maggior parte delle persone. E’ il problema scuole, il problema servizi dei comuni, il problema dei luoghi pubblici che bisogna pensare di connettere anche se il mercato non li connetterebbe da solo.
Lo scopo? Non certo assistere. Ma aiutare la crescita di tutto il Paese.

| In una grande città bavarese,una azienda automobilistica con circa 7000 dipendenti sta celebrando il decimo anniversario dall’inizio della produzione. Quando, dieci anni fa, questa azienda cominciò a cercare operai, non assunse disoccupati, ma operai specializzati provenienti dalle imprese artigianali già presenti nella zona. Le imprese di meccanici e di carrozzieri dei dintorni persero di conseguenza i loro migliori dipendenti e collaboratori, che si licenziavano per passare alla grande fabbrica che offriva un salario molto più alto e la possibilità di comprare una macchina a prezzi di favore. E ancora oggi circa il 90% dei suoi dipendenti hanno un’istruzione professionale completa. Due anni fa, questa fabbrica ha aperto una filiale negli Stati Uniti, ma la qualità dei prodotti che escono da quello stabilimento non è tra le migliori, nonostante che il 25% dei dipendenti sia composto da operai che vengono dalla Germania e trascorrono un paio di mesi negli Stai Uniti. Le automobili prodotte nella fabbrica americana, prima di essere messe sul mercato, vengono “ritoccate” nella sede della fabbrica in Germania, con costi aggiuntivi di diverse migliaia di marchi. Non che in America non si sappia lavorare bene – si lavora più a lungo e più a buon prezzo che da noi – ma manca una buona formazione professionale. E una buona formazione professionale è una premessa indispensabile per ottenere risultati di ottima qualità. Le stesse statistiche relative alla disoccupazione dimostrano quanto sia importante un’istruzione professionale ad alto livello.Per gli operai generici, senza addestramento professionale, è sempre più difficile trovare un’occupazione e più di 100 000 giovani ( tra Germania ovest e ex Germania est ) non sono riusciti a entrare nel mondo del lavoro nel 95. Nella maggior parte dei casi la disoccupazione ha colpito i ragazzi senza addestramento professionale.(Mi riferisco soprattutto alla situazione nella Germania ovest, nei Paesi della ex Germania democratica il problema della disoccupazione è più sentito anche tra coloro che hanno un’istruzione professionale). In Germania è riconosciuta ufficialmente l’istruzione professionale per 331 professioni. Ma quali sono le professioni che godono del maggior interesse tra i principianti che desiderano imparare un mestiere, a seconda del titolo di studio iniziale? Chi, dopo la maturità, non passa all’università, si orienta verso professioni nel campo dell’economia e del commercio e, in primo luogo, alla carriera in una banca. I giovani che hanno terminato la nostra “Realschule”, che dura due anni di più della scuola media italiana, vorrebbero diventare impiegati di concetto in uffici pubblici o privati e anche l’impiego in un laboratorio medico dentistico è molto ambito. Chi cerca un lavoro dopo la “Hauptschule”, che dura quanto la scuola dell’obbligo in Italia, si orienta verso mestieri nel campo dell’artigianato, soprattutto meccanici, imbianchini, muratori e parrucchieri. Circa 615 000 giovani sono apprendisti nell’artigianato, cioè il 39% di tutti gli apprendisti. La maggioranza dei giovani che si decidono per una qualificazione professionale viene istruita con il sistema duale, cioè con l’accoppiamento di un insegnamento pratico, impartito da un’azienda, con l’insegnamento teorico, dato dalla scuola professionale. L’azienda sostiene i costi per l’addestramento in ditta, mette a disposizione il personale che istruisce l’apprendista, paga la retribuzione mensile e le assicurazioni sociali. Inoltre, per i corsi di aggiornamento extra – aziendali, l’azienda paga la tariffa dei corsi e le spese extra, mentre lo stato o le regioni danno dei contributi e finanziano tutta la scuola professionale. L’apprendista deve frequentare la scuola professionale 1 o 2 giorni a settimana per tre anni o tre anni e mezzo. Qui vengono impartite lezioni relative a materie di cultura generale e, inoltre, quella parte di nozioni prevalentamente teoriche relative al suo ramo di competenza, dato che il giovane può impararle meglio qui che presso l’azienda. Le sue prestazioni vengono attestate in un diploma finale. La scuola professionale è anche la scuola d’obbligo di tutti i giovani che non hanno ancora compiuto i 18 anni d’età e che non frequentano nessun’altra scuola. Questo per l’istruzione scolastica. Per quanto riguarda il tirocinio nell’azienda, le norme dell’apprendistato vengono emanate dai ministri federali sulla base delle proposte avanzate dalle associazioni industriali e artigianali, dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dai sindacati competenti. Queste proposte fissano le materie d’insegnamento e d’esame. L’esame viene presediuto dai comitati degli organi di autoamministrazione dell’economia (Camera dell’Industria e del Commercio, Camera dell’Artigianato e simili). Nella Commissione d’esame sono presenti i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori (normalmente proposti dai sindacati) e degli insegnanti delle scuole professionali. Dopo questo esame, l’apprendista diventa “Geselle”, entra cioè nel primo stadio di operaio specializzato. Dopo circa 5 anni di pratica, può sostenere l’esame di “maestro artigiano” e con questo titolo potrà fondare una sua propria impresa, esercitare una professione artigianale e anche addestrare, a sua volta, i nuovi apprendisti. Un’apprendista guadagna in media 1000 marchi al mese (un po’ meno nei Paesi della ex Repubblica Democratica), 400 marchi in più rispetto a dieci anni fa. Ma dietro a questa media si presentano grosse differenze tra i diversi tipi di lavoro: si va dai 1870 marchi che guadagna un muratore che installa impalcature ai circa 600 marchi di un’apprendista parrucchiera. Considerando questa media di 1000 marchi al mese, vediamo quanto costa e quanto rende un apprendista. Si spendono 29573 marchi all’anno per il personale che istruisce l’apprendista, le tariffe per gli esami, la retribuzione dell’apprendista, i libri di testo, i contributi per le assicurazioni sociali, l’equipaggiamento del posto di lavoro, i corsi di aggiornamento.L’apprendista “rende” all’azienda in media 11711 marchi, e dunque costa all’azienda 17 800 marchi all’ anno. E’ evidente che l’ addestramento costa molto, ma produce anche molti vantaggi ed in particolare: *produttività dell’ apprendista con il suo apporto lavorativo nell’ azienda *formazione di operai specializzati che si possono inserire subito nel ciclo produttivo. E se l’ azienda decide che ci sono le condizioni per assumere l’apprendista dopo il tirocinio, si presentano ancora altri vantaggi: 1) riduzione di costi per nuove assunzioni 2) riduzione di costi per l’addestramento di altre persone che devono venire inserite nel nuovo lavoro 3) minore rischio di assumere persone non idonee 4) minore cambiamento di personale 5) possibilità di avere subito a disposizione personale già addestrato, se un dipendente viene a mancare. L’importanza della formazione professionale viene evidenziata anche dai dati seguenti, che mostrano quale era il bisogno di prestatori d’opera rispetto al loro titolo di studio nel 1987 e quale sarà in futuro, nel 2010. Come dieci anni fa, anche tra quindici anni ci sarà bisogno di persone con un titolo di scuola professionale (il 58%, più della metà!). Aumenterà il bisogno di persone con uno studio ancora più specializzato, sia della scuola superiore d’istruzione professionale, che degli istituti superiori o delle università, ma soprattutto diminuirà in misura rilevante la richiesta di lavoratori senza alcuna qualifica (dal 23,2 al 13%) che saranno di fatto condannasti alla disoccupazione. Data la permeabilità tra istruzione in azienda e istruzione scolastica, è anche possibile arrivare, grazie al SISTEMA DUALE, alla maturità e persino a uno studio universitario. Una completa istruzione professionale, per esempio fino al titolo di “maestro artigiano”, gode di alta considerazione nella società e non ha nulla da invidiare ad una laurea all’ Università, e tra i nostri meccanici, quelli che hanno assolto sia un’istruzione professionale che uno studio universitario sono quelli che hanno un maggiore successo. Da questa mia esposizione sul SISTEMA DUALE si può rilevare il suo ampio grado di accettazione da parte di tutti i settori della società. Stato, Associazioni dell’Industria e dell’Artigianato, datori di lavoro e sindacati collaborano a tutti i livelli per contribuire alla buona riuscita di questo sistema. Naturalmente ci sono anche discussioni e motivi di attrito su alcune questioni e alcuni punti avrebbero bisogno di modifiche. Vorrei farne un breve accenno anche in questa sede. Lo Stato cerca di incrementare l’aspetto scolastico dell’ istruzione professionale, per esempio due giorni di scuola in settimana invece di uno e le aziende non sono daccordo. Ma, in questi tempi di basso tasso di natalità, anche gli insegnanti devono avere un’occupazione sicura ed essi hanno molta voce in capitolo anche in Parlamento, dove rappresentano il gruppo più folto dei deputati. L’addestramento a molte professioni è antiquato e i contenuti spesso non rispondono più alle esigenze del nostro tempo (pensiamo solo all’ informatica o all’elettronica) e, purtroppo, il cambiamento dei piani di studio è impresa lunga e complicata(per le nuove normative del piano di studi dei nostri meccanici ci sono voluti ad esempio dieci anni). Il 5 – 10 percento dei nostri ragazzi vanno a scuola solo per “scaldare il banco” e non hanno la voglia o la capacità intellettuale di seguire le lezioni. E’ nostro compito dare anche a questi ragazzi delle prospettive professionali anche se naturalmente al di sotto del livello medio attuale. Per esempio si può proporre un’istruzione a tempi ridotti – due anni – per mestieri particolari. I sindacati sono contrari a questa proposta, perchè anche il salario di questi ragazzi sarebbe naturalmente più basso. Secondo me invece – ed è opinione dei datori di lavoro – bisognerebbe portar via questi ragazzi dalla strada e dai sussidi di disoccupazione. In grandi città come Monaco di Baviera, circa un terzo degli apprendisti meccanici sospende l’addestramento e un terzo dei rimanenti non riesce a passare l’esame finale, perchè il livello dell’istruzione professionale è molto alto. Per questi ragazzi si potrebbe creare l’addestramento a nuovi mestieri, come per esmpio quello di meccanico del riciclaggio, con un periodo di istruzione di due anni ( invece di tre e mezzo dei meccanici) e minori esigenze dal punto di vista scolastico. La retribuzione degli apprendisti è aumentata molto più dei salari e degli stipendi in generale. Insieme ai contributi per le assicurazioni sociali, questo onere finanziario diventa sempre più pesante per le aziende, anche perchè da noi la situazione economica, anche nell’artigianato, sta diventando sempre più precaria. Forse si potrebbe pensare a un anno senza aumenti della retribuzione, per concedere un po’ di respiro alle aziende e convincerle ad assumere nuovi apprendisti. Sono piccoli e grandi problemi, che però non scuotono il pilastro dell’istruzione professionale in Germania, che rimarrà anche in futuro importante e indispensabile. |

Le innovazioni tecnologiche ed organizzative producono sempre più consistenti risparmi di lavoro per unità di prodotto e quindi hanno effetti molto rilevanti sulle quantità di lavoro impiegate nella produzione di beni e servizi. Sta come è noto qui la genesi di una disoccupazione notevole e crescente, che rappresenta un problema di tutte le società come dimostra l’esperienza della stessa Germania, che nonostante sia orientata ad assumere un ruolo attivo e dominante nel processo di globalizzazione dei mercati, non è certo immune da questi problemi.
Il notevole risparmio di lavoro conseguente alle innovazioni genera non solo problemi di disoccupazione ma anche di sottoccupazione e di precarietà. Nelle dinamiche in atto e, ancor più in quelle attese per il futuro, la possibilità di inserimento nei processi produttivi potrebbe appartenere sostanzialmente al lavoro di alta qualità e a quello di qualità relativamente bassa mentre sembra in vista un ridimensionamento drastico delle possibilità di espansione dell’occupazione per larga parte della fascia intermedia.
Abbiamo in pratica dinanzi a noi una prospettiva nella quale coesisteranno una situazione di disoccupazione di massa e dinamiche occupazionali rilevanti per il polo a più alta qualità e per quello a più bassa qualità, anche se entrambi questi poli avranno essi stessi problemi di precarietà connessi al mutamento continuo ed incessante dei processi produttivi. C’è un problema di capacità di adattamento del lavoro ai processi di cambiamento rispetto ai quali chi non è adattabile sarà sempre più debole.
Il lavoratore che è disponibile ad accettare posti di lavoro di bassa qualità, quelli che nel linguaggio anglosassone sono chiamati bad jobs, posti di lavoro che hanno condizioni di lavoro che generalmente non sono desiderate, sono lavoratori di limitata capacità di adattamento e sono dunque soggetti ad un flusso continuo di entrata ed uscita. Gli stessi processi migratori di massa a livello internazionale contribuiscono a esasperare questa entrata e uscita continua dai processi produttivi del lavoratore che accetta il bad job.
Per quanto riguarda i good jobs, i lavori ad elevata qualità, il problema della capacità di adattamento è legato molto alla possibilità di avere una base culturale adeguata ad accettare il cambiamento, a gestirlo anzi con un ruolo di attore positivo. E’ un discorso molto grosso, che investe la tematica della formazione, i suoi contenuti, il suo rapporto con il lavoro. Una formazione che sempre di più è vista in tutte le dimensioni come una lifelong learning, cioè una formazione che dura per tutta la vita, una vita che data la possibilità di invecchiamento della popolazione tende ad essere sempre più lunga.
Ma i processi di cambiamento in atto stanno avendo un effetto molto importante anche in un’altra direzione, quella del lavoro autonomo (qui occorrerebbe definire che cos’è il lavoro autonomo: l’imprenditore, il libero professionista, l’impresa che ha una base sostanzialmente familiare, lo stesso telelavoro rientra in parte in tale ambito così come forme che sono chiamate di economia informale delle varie realtà del lavoro). Il lavoro autonomo ha avuto un ruolo molto rilevante nel passato ed è stato ridimensionato nella seconda fase della rivoluzione industriale, come dimostrano i dati statistici relativi al peso crescente del lavoro dipendente e al ridimensionamento dello spazio di lavoro autonomo sul lavoro complessivo.
Con la società informatizzata riemerge l’importanza e il significato del lavoro autonomo, e riemerge da più punti di vista. In primo luogo perché il lavoro autonomo è per definizione flessibile e ha una dinamica connessa alla dinamica delle imprese. In tutti i paesi industrializzati le imprese nascono e muoiono con estrema rapidità nel primo anno di vita (non a caso tale fenomeno è chiamato mortalità infantile delle imprese). In media muore più del 30% delle imprese, in alcuni paesi come il Portogallo, addirittura il 50%. In Germania e in Italia, la media è comunque attorno al 30%. È chiaro però che questo fenomeno è accompagnato da quello speculare relativo alla natalità. C’è una dinamica continua di entrata e di uscita di imprese che sono accompagnate da entrate ed uscite di lavoratori.
Proprio la dinamica e la flessibilità del lavoro autonomo lo rendono particolarmente interessante e rilevante nella società informatizzata, perché lo rendono più capace di muoversi in una realtà in continuo cambiamento. È del tutto evidente che questo non basta a spiegare il suo successo crescente. Un altro aspetto positivo sta nel fatto che nella società informatizzata il lavoro autonomo ha caratteristiche molto più innovative di quelle che aveva nella società della seconda fase di rivoluzione industriale. All’inizio il lavoro autonomo era prevalentemente o lavoro agricolo, quindi legato all’attività della terra, o lavoro autonomo di tipo artigianale. In Baviera, per esempio, non so perché erano ebanisti, e il mio cognome è un cognome che significa in tedesco, frei, libero, che vorrebbe dire una persona liberata dalla servitù della gleba in quanto artigiano.
E l’artigiano, in una realtà con un dinamismo non molto marcato, era innovatore, lavorava la materia, faceva l’opera d’arte, aveva il modo di rendere redditiva la propria creatività. Nella società industriale il lavoro autonomo è invece normalmente un qualcosa di collegato al sistema industriale (inteso nel senso anglosassone multisettoriale) un “pezzo” di sistema produttivo dipendente esterno alla realtà d’impresa.
Nella società informatizzata il lavoro autonomo riconquista dunque in misura notevole la propria capacità creativa, di lavoro capace di profonde innovazioni. Per innovare non è più necessario avere grandi capitali, ed è molto più importante il rapporto tra la persona e la macchina (il computer in primo luogo) come dimostra anche l’iniziativa odierna. Questa è una prima novità rilevante rispetto al lavoro autonomo della prima parte di questo secolo.
Una seconda novità sta nel fatto che nella società informatizzata il lavoro autonomo ha una propria capacità di realizzare economie di scala ed economie di scopo, come dimostrano le ricerche che sono state fatte per esempio sui sistemi industriali integrati. Le economie di scala e di scopo producono vantaggi in termini di costo che normalmente nella seconda fase di rivoluzione industriale erano collegati alla produzione di massa (producendo una grande quantità di un determinato bene si produceva ad un costo minore per unità di prodotto).
È chiaro però che per realizzare economie di scala e di scopo, economie di scala legate alla dimensione della produzione, di scopo legate alle interazioni e così via, bisogna che le aziende di piccole dimensioni si colleghino l’una con l’altra. L’azienda di piccole dimensioni da sola non ha capacità di sopravvivenza e la sola capacità creativa non è sufficiente ad assicurarne lo sviluppo. L’azienda di piccole dimensioni ha dunque bisogno di collegarsi in rete con altre aziende con le stesse caratteristiche. Queste reti integrate consentono economie di scala e di scopo addirittura superiori alle aziende di grandi dimensioni, tant’è vero che un famoso economista americano ha sostenuto recentemente che è necessario che la grande impresa acquisisca economia di scala e di scopo riorganizzandosi sotto forma di piccole unità produttive integrate.
Abbiamo finora parlato di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, vorrei ora soffermarmi su un terzo aspetto riferibile alle prospettive del lavoro nella società informatizzata. La più rapida comunicazione, la più rapida interazione e integrazione tra persone e strutture sociali, fa sì che questa società presenti una caratteristica molto importante: una massa enorme di bisogni che il sistema produttivo, in particolare quello che si riferisce ai normali meccanismi di mercato, non riesce a soddisfare.
Si possono fare esempi in varie direzioni. Basti pensare ai bisogni connessi alla salute, a partire da quelli alimentari, ai bisogni di istruzione in senso lato che, come è ovvio, non possono essere finalizzati al pur importante aspetto del lavoro, all’uso corretto e soddisfacente delle risorse naturali. C’è un’esigenza forte di dare risposte positive a questi bisogni che solo in parte viene soddisfatta attraverso il lavoro dipendente utilizzato in quella direzione.
Dunque anche per questa via vi è grande spazio per il lavoro autonomo, il lavoro individuale e quello di imprese di piccole dimensioni anche di tipo cooperativo. C’è un fabbisogno che deve essere soddisfatto e quindi c’è un canale aperto di potenzialità, di impiego di risorse umane che merita attenzione. Arriviamo con ciò al secondo significato del lavoro: il lavoro come bisogno in sé e non soltanto come canale attraverso cui si ottengono i mezzi per soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia. Il lavoro è infatti anche un bisogno in sé, come si coglie da tutta una serie di indagini che riguardano per esempio il lavoro giovanile.
I giovani si sentono frustrati per la mancanza di lavoro non soltanto perché non ottengono reddito per soddisfare i propri bisogni, non hanno la possibilità di concorrere al reddito familiare, ma anche perché non riescono a soddisfare loro profonde esigenze che vanno al di là del reddito e sono in sostanza collegate alla capacità di organizzare la propria vita in un sistema di valori riconosciuto. In pratica il giovane non avendo il lavoro non riesce a organizzare la propria vita in modo organicamente inserito nel sistema di valori proprio della società nella quale vive.
Ovviamente questo aspetto si collega ad altri aspetti, in particolare alla possibilità di contribuire a creare il proprio futuro che è fondamentale sia per i giovani che per gli altri. La possibilità di contribuire a creare il proprio futuro è un bisogno formidabile esistente in ciascuno di noi che porta ad esigere un lavoro non concepito come pura produzione di beni materiali, ma di creazione e di utilità in senso lato. La mancanza di lavoro produce profonde frustrazioni e finisce con l’essere fattore di emarginazione rispetto al contesto sociale.
Questo vale ovviamente anche per chi un lavoro lo aveva e lo ha perso. L’operaio che non riesce a trovare altro lavoro, dopo avere avuto l’illusione che col lavoro nell’industria sarebbe stato lavoratore dipendente per tutta la vita con la garanzia di reddito per sé e per i propri familiari, vive in quanto componente della società una situazione particolarmente drammatica. Il lavoro concepito come bisogno di partecipazione attiva al sistema economico sociale viene ad essere un valore e un bisogno particolarmente importante.
Concepire il lavoro come bisogno diretto che deve essere soddisfatto induce tutta una serie di riflessioni su quelle che possono essere le potenzialità di medio e lungo termine per la creazione di spazi lavorativi che consentano di soddisfare i bisogni potenziali non soddisfatti che prima ricordavo.
A livello internazionale ci sono iniziative di estremo interesse in questa direzione. A parte il discorso che facevo prima relativo all’utilizzo del lavoro autonomo come spazio creativo che tenta di costruire qualcosa di assolutamente nuovo rispetto all’esistente e quindi di innovare dal punto di vista imprenditoriale, vi è tutta una serie di altre esperienze che fanno riferimento alla necessità di concepire il lavoro di cura, il lavoro destinato a soddisfare bisogni essenziali insoddisfatti che riguardano la cura propria e di altri, come forma di partecipazione al sistema economico e sociale in modo attivo. Questo carattere di partecipazione alla realtà collettiva può legare strettamente, in modo interattivo, il lavoro di cura al lavoro per il mercato.
È chiaro che il lavoro di cura non è un lavoro al di fuori del mercato, non è soltanto un valore d’uso, è anche valore di scambio, comporta cioè uno scambio per partecipazione attiva alla realtà economico sociale. Ci sono esperienze, tipo banche del tempo, di estremo interesse dal punto di vista della possibilità di uno scambio a questo proposito.
C’è un esempio che viene fuori dalla nostra esperienza odierna: la mia attività attuale è di questo tipo, cioè un lavoro di scambio, dato che partecipo a un processo di mia autoformazione, dato che sto imparando moltissimo dalla partecipazione a questa iniziativa, e nello stesso tempo sto dando in cambio il capitale umano e professionale accumulato attraverso la mia attività di formazione e di ricerca. Questo rapporto di scambio non è un rapporto monetario, però è sempre un rapporto di scambio e quindi ha un suo significato dal punto di vista del mercato in senso lato: anche se non è un lavoro mercantile in quanto tale è un lavoro che ha un suo significato.
Gli spazi che si aprono sono estremamente interessanti, come dimostrano alcune esperienze a livello europeo. Come fare per coglierli appieno? Come creare nuovi lavori in questa società sempre più automatizzata? E’ il terreno di impegno e di ricerca per ciascuno di noi.

Qui si dirà di profezie, si salterà di passato in futuro, si andrà da frammento in frammento fino ad arrivare a ciò che mette un po’ in discussione il senso della profezia, e di cui pure vorrei parlare: il Museo. Nel trattare di questo confine sottile tra arte e altre forme di possibili culture, e affrontando Leonardo così come esperienze di neo avanguardie contemporanee, mi piace parlare di alcune cose, come ad esempio il dubbio e la contraddizione, che ritengo fondamentali se ci avviciniamo, al di là del mito e della retorica, a personaggi come Leonardo.
L’idea della profezia è nata, come tema programmatico, da una breve frase che dice: “Parleronsi gli uomini di remotissimi paesi li uni a li altri e risponderansi”. Questi uomini che si chiamano e si rispondono da lontani paesi ci suggeriscono molte immagini tecnologiche. In realtà questa è una delle tante frasi, piccolissime, minute, scritte da Leonardo da Vinci con calligrafia al rovescio, esattamente cinquecento anni fa, in una pagina di quel Codice Atlantico che, tutto sommato, non ha avuto un destino favorevole nonostante i diversi auspici di alcune profezie napoletane.
Fu infatti il segretario di un cardinale di Aragona, un certo Antonio De Beatis, recatosi nel 1517 a incontrare Leonardo alla corte del re di Francia, presso Ambois, che annotò l’opinione sua e del cardinale, scrivendo “Leonardo ha tre quadri bellissimi (uno era la Gioconda); Leonardo si dedica a tanti studi ed è paralizzato (aveva una emiparesi ma continuava a disegnare e a insegnare); i suoi codici trattano di infinite cose, sono infiniti fogli, saranno utilissimi, soprattutto se saranno conosciuti e pubblicati”.
Ma quei fogli non sono stati conosciuti, né pubblicati, per tantissimi anni. Addirittura, quando agli inizi del Seicento il Codice Atlantico fu offerto al Granduca di Toscana, fu drasticamente bocciato dai consiglieri di quest’ultimo che affermarono: “Non sono cose degne di Vostra Altezza, sono cose triviali”. Insomma i contenuti di questi scritti di Leonardo, che sicuramente avrebbero portato un ben altro contributo all’evoluzione del sapere in generale e del rapporto tra arte e metodologia della scienza, arte e metodologia della tecnica, si sarebbero potuti conoscere molto prima. E ci saremmo salvati in qualche modo anche dalla scoperta, in fondo tipica del nostro ventesimo secolo, del Leonardo genio italico che aveva inventato tutto quando invece altri prima di lui, o insieme a lui, inventarono le stesse cose.
Il fatto è che in Leonardo c’era un metodo particolare. E questo metodo era naturalmente quello della scienza. Quando Leonardo tratta la scienza è l’artista della scienza, ed è l’artista delle macchine, e in quanto tale affronta la profezia con un taglio particolare, che è veramente stimolante. Avremmo dunque conosciuto con netto anticipo, se fossero state pubblicate e divulgate, profezie come quelle che, in un certo senso, Leonardo scrisse per Austro e Aquilone.
Lui, umanissimo che traversava le più dirette esperienze con vivacità intellettuale, (non era “trombetto”, come diceva lui stesso, ma uomo d’esperienza e del fantastico, dell’immaginario) ci dà la possibilità, sempre nel Codice Atlantico, di leggere questo: “Vedrassi le parti orientali discorrere nelle occidentali, le meridionali in settentrione, così avviluppandosi nell’universo con gran strepito e furore”.
Questa cosa del meridionale in settentrione, questa dell’avvilupparsi dei linguaggi, per Leonardo significava il vento. Egli partiva dall’osservazione di un dato naturale, e da qui creava una metafora e proiettava tutto nella dimensione dell’arte, quella verbale e quella fatta di immagini. E potremo leggere un giorno un Leonardo anche in chiave ideologica.
Farei qui un primo salto verso quelle che sono le profezie contemporanee, quelle che non patiscono i fantasmi e l’ingombro del passato. L’occasione mi viene da un libro che ho trovato tra i Remainder, pubblicato più di venticinque anni fa, dal titolo “Profezie di una società estetica”, e scritto da Filiberto Menna, un grande studioso, un grande critico dell’arte contemporanea, salernitano di origine.
Quando un artista lo odiava, magari perchè non si sentiva capito dal punto di vista critico, diceva di lui: “Ma cosa vuoi, è nato alla critica d’arte partendo da “Lascia e Raddoppia”. Il tutto perché, da professionista che si occupava anche di altre cose, aveva collaborato ad una trasmissione televisiva. In realtà è al meccanismo della passione, quella vera, che corrisponde quel fattore di autenticità che poi rende forti le idee. E ciò vale in particolar modo in tutte quelle che sono le dimensioni delle arti.
Naturalmente, quella profezia di una società estetica è mancata fortemente negli ultimi tempi, anche se in parte “accade” a “tradimento”, d’improvviso.
L’arte è sempre più diffusa nella società contemporanea, ed in quanto tale vive dunque fortemente. Essa non solo subisce tutti i condizionamenti del sistema in generale, ma per certi versi acutizza e precede i sintomi di crisi, cosicchè è naturale trovare nell’arte tanto continue profezie su quella che sarà o potrebbe essere la società di domani, quanto gli immediati sintomi del malessere. Se le ideologie vivono un momento di crisi, se determinate identità vengono perse, o se sono nell’aria i segni di una nuova rivoluzione, l’arte è lì a segnalarlo, proprio come fosse una profezia sistematica.
Qualche tempo fa, un personaggio straordinario come Carlo Giulio Argan, proprio lo stesso che una volta ha scritto: “lo storico dell’arte, il critico d’arte deve essere un profeta o un archeologo” profetizzò, o piuttosto rilevò, la morte dell’arte. Una morte che assolutamente non c’è stata, ma in quella maniera Argan intendeva proporci alcune riflessioni. Al di là dello schematismo di un breve testo, la sua idea del mondo dell’arte, come fabbrica dell’arte, richiedeva la presenza dell’archeologo, del profeta, e di tante altre figure. Come storico dell’arte, la scelta naturalmente era quella dell’archeologo, e naturalmente la morte dell’arte sembrava inevitabile in un sistema che tendeva a escludere, tende a escludere ancora oggi in buona parte, le componenti incontrollabili dell’arte vera.
Questo è un grosso problema che ovviamente la politica sembra sempre meno poter risolvere, perchè i suoi tempi sono troppo diversi da quelli dell’arte. I tempi brucianti, i tempi strumentali della politica, di fatto non possono rispecchiare quelli dell’arte, che sono per certi aspetti velocissimi nell’idea, per certi altri lunghissimi in tutti quelli che sono gli echi sociali.
Un momento di crisi fortissima, nella storia dell’arte contemporanea, nonostante non sia stato molto rilevato, dato che in questo grande arcipelago della cultura che ruota intorno alle arti tutto è vissuto settorialmente, ogni isola non parla con l’altra, e ogni isola non parla con le altre discipline, s’è registrato nel 1979.
Allora si verificò un punto di rottura con la transavanguardia, che ha prodotto per un verso cose giuste, come il recupero di una vitalità interna all’arte, ma per un altro ha messo in crisi di tutte quelle che erano le ideologie dell’arte e tra queste quella nozione di avanguardia che poteva sembrare anacronistica, ma che in realtà contraddistingue tutto un filone utopico e profetico dell’arte dall’antichità ad oggi. Basti pensare al Rinascimento e all’Umanesimo, intesi come antiche avanguardie, e alle avanguardie del ventesimo secolo.
Una delle sue grandi componenti recenti, che mi ha da sempre interessato, è stata quella della poetica della “reverie”. Accanto a una visione razionale delle cose, quella stessa per cui Argan poteva affermare: “Da razionalista ho vissuto, da razionalista voglio morire. Non posso accettare la transavanguardia e un’arte senza ideologia”, c’è nell’arte quella che potremmo definire la componente del “fantastico insidioso” come punto estremo e in questo ambito la poetica della “reverie”, per me, ha sempre inciso moltissimo.
Qualche tempo fa si parlava con un amico del rapporto esasperato e profondo esistente tra la vita privata e il rapporto pubblico, tra il lavoro e la famiglia, tra tutte una serie di coincidenze, perchè un’arte della reverie significa un arte che respira e cresce con noi, un’arte completamente imprevedibile, che ha il suo respiro vitale, e che tende ad avere questo respiro assoluto, tra il mimetizzarsi per tradire le apparenze e lo svelarsi profeticamente.
Posso fare un piccolo esempio, anche per chiarire quanto ci si può immedesimare in queste cose, e poi mi piace salutare persone che in questo momento non sono con me. Tanti anni fa sono stato tra i fondatori di un’associazione che si chiamava Museo-Reverie, il museo immaginario. Questa associazione si è sciolta esattamente tre anni fa, il giorno in cui è stato creato, a Vinci, il museo ideale Leonardo da Vinci. Negli stessi giorni nasceva mia figlia, che si chiama Reverie. In una forma di incarnazione, di materializzazione c’è la possibilità di ricercare sempre un’identità vera e forte, tra idee forti, e quello che è l’attraversamento delle esperienze artistiche, culturali, tecnologiche.
Avendo saltellato abbastanza, vorrei tornare a Leonardo ed alle profezie.
Quando Leonardo scrisse: “Parleransi li omini di remotissimi paesi l’uno a l’altro e risponderansi”, sicuramente poteva pensare alle lettere, allo scrivere la posta, ad una sorta di posta elettronica, ma tutto questo non gli bastava. Leonardo si poneva, ad esempio, il problema del citofono militare, perchè sapeva già che gli antichi sciiti, gli arabi, usavano un sistema di citofoni che consentiva, quasi con la stessa rapidità del telefono, di comunicare velocemente tra loro.
Ma lui arriva anche a dare una definizione, un inquadramento abbastanza preciso delle profezie:
1) profezia delle cose degli animali razionali; 2) degli irrazionali; 3) delle piante; 4) delle cerimonie; 5) dei costumi; 6) dei casi e delle questioni; 7) dei casi che non possono stare in natura, come dire, di quella cosa quanto più ne levi più cresce.
Bisogna capire veramente lo spirito teorico di un saggio che al tempo stesso gioca sull’ambiguità, l’ironia toscana, l’indovinello e che dice, nell’ottava profezia delle cose filosofiche: “e riserva i gran casi inverso il fine e i deboli nel principio, e mostra prima i mali e poi le punizioni”. Vorrei ricordarne alcune di queste profezie.
“Verrà a tale la generazione umana, che non s’intenderà il parlare l’uno dell’altro”, ed in questo caso parlava di un turco ed un tedesco, ed è tuttora misterioso se c’è una ragione ideologica, di guerra, o quale altra consapevolezza. Ma c’è una forma di profezia che chiaramente tocca la fantascienza, perchè la scienza antica è particolarmente vicina ai temi della fantascienza, che mi è venuta in mente leggendo un’intervista a Veca seguita al suo intervento a questo stesso convegno e pubblicata sul Mattino.
Veca dice: “io insisterei molto sul fatto che noi uomini siamo animali parlanti. Il linguaggio è per definizione pubblico, implica condivisione”. Mi sembra molto bello come rapporto. Leonardo ha una profezia, una visione, e scrisse cinquecento anni fa quello che recentemente, per ragioni di mestiere, è stato abbinato al caso forse più retorico, più inopportuno, più propagandistico, ma pieno di effetti speciali: il film “Independence Day”.
Leonardo scrive: “Alli omini parrà vedere nel celo nove ruine, parrà in quello levarsi in volo, et di quello fuggire con paura le fiamme che di lui discendono. Sentiran parlare li animali di qualunque sorta il linguaggio umano, scorreranno immediate con la lor persona in diverse parti del mondo senza moto, vedranno nelle tenebre grandissimi splendori. O meraviglia delle umane spezie, qual frenesia ti ha sì condotto. Parlerai con li animali di qualunque spezie, e quelli con teco il linguaggio umano. Vedratti cadere da grandi alture senza alcun danno”.
Cosa sono, sempre, queste? Sicuramente sono le prefigurazioni che un personaggio aperto a qualsiasi esperienza poteva condensare nell’insieme di quello che dicevo prima: le contraddizioni e il dubbio. In sostanza Leonardo parte da un presupposto: “tutto ciò che è sperimentato è vero, quello che non è sperimentato io non lo credo”, però, via via, continua a dare grande spazio al sogno, all’irrazionale e arriva anche ad affermare di volta in volta, a seconda dei casi, che “quando le ragioni sono chiare non c’è bisogno dell’esperienza”.
Queste contraddizioni sono tipiche di una mentalità che io continuo a considerare artistica. Essa pone tanti interrogativi e tanti dubbi a chi oggi affronta sistematicamente le tecnologie, i sistemi di una comunicazione tecnologica, perchè se si toglie tutta la parte relativa alla profezia estetica, alla componente più imprendibile, inafferrabile, mercuriale di un avanguardia, indubbiamente si tolgono tante potenzialità. Vi leggo ancora un paio di profezie, semplicemente per entrare in una dimensione curiosa di Leonardo. Egli definisce i libri e li chiama “i corpi senz’anima, che ci daranno con lor sentenzie precetti utili al ben morire”. Curiosa questa cosa dei corpi senz’anima.
Leonardo è stato sempre considerato e definito il profeta dell’automazione, e tutto sommato si è interessato alla robotica dato che ha prefigurato forme di automazione che nemmeno la rivoluzione industriale ha introdotto. Ed in effetti nel suo lavoro, nei suoi codici, ci sono degli ipertesti continui con parole, immagini, rimandi e tutta una serie di cortocircuiti tipici del ragionamento informatico. Che lui non avesse la macchina e non potesse costruirsela è un altro discorso.
Ma aldilà dei suoi alberi geometrici e matematici c’è sempre questo carattere, estremamente pregnante per noi oggi, sorprendente, rivelatore. Naturalmente il profeta dell’automazione tende anche a fare un’altra cosa e, per esempio, personifica, perchè per lui tutto è umanizzato: ed allora le piante, sono esseri viventi che parlano, che ragionano, che sono da esempio per l’uomo. La maggior parte degli studi tecnologici di Leonardo si è rivolta all’automazione del mondo tessile, e ci sono decine e decine di macchine concepite per quattro o quaranta persone contemporaneamente, proprio come una visione del sistema del lavoro, dell’economia, del risparmio del tempo, e, problema fondamentale, del risparmio della fatica umana, aumentando i guadagni.
Tra l’altro Leonardo sogna sempre il guadagno, gli piace fantasticare sul guadagno che potrebbe fare lui, gioca anche ai segreti, ai brevetti, e via dicendo. E mentre tende a vedere un progresso in questa tecnologia che porterà al risparmio di fatiche, quando però arriva alla macchina tessile scrive: “sentirassi le dolenti grida, le alte strida, le rauche, infuocate voci di quelli che fiano con tormento e spogliati e alfine lasciati ignudi e sanza moto, e questo fia causa del motore che tutto volge”.
Ritorna ancora una volta la contraddizione, il non poter mai prendere una cosa in senso letterale: questo fa parte del linguaggio artistico. Alcuni giorni fa ho sentito a una dottissima conferenza parlare di Leonardo e ricordare quando egli scrive: “Porterassi neve di state nei lochi caldi, tolta dalle alte cime dei monti e si lascerrà cadere nelle piazze, nelle feste, nel tempo dell’estate”. Tutti a pensare: Leonardo studia il volo degli uccelli e pensa di portare dai monti la neve con chi sa quali espedienti. Invece, molto più semplicemente egli stava parlando ironicamente dell’acqua, la neve d’estate, che si porta nelle piazze per dar vita alle fontane.
Ecco dunque questa capacità di contraddirsi e di sostenere in certi casi, lui che era un uomo pratico in cerca di una teoria, l’importanza non solo del linguaggio verbale, ma dell’icona, della figura. Infatti dice: “è necessario figurare, l’anatomista tutto sommato è inerme, il medico anatomista, perchè non è in grado di figurare adeguatamente”. E ancora: “Quanto più minutamente descriverai con le parole, tanto più confonderai la mente del lettore; è necessario figurare”.
L’aver delineato un Leonardo così multiforme, Leonardo come mondo, Leonardo come epoca, Leonardo come scenario di cultura, mi dà la possibilità di rifare un salto avanti. E mi piace farlo avvicinandomi a un episodio recente, per entrare da un lato nel merito della comunicazione, dell’etica della comunicazione, in quelli che sono i fenomeni di riscoperta o di spettacolarità del presente, di quello che è l’effetto della comunicazione oggi, anche in rapporto al passato e per affrontare dall’altro, ancora una volta, i grandi temi dell’utopia e della profezia.
Tempo fa è uscito su un giornale napoletano una recensione di una mostra, nella quale si dice: “Il sottomarino di Leonardo. Il genio fiorentino voleva sbarcare a Napoli con un sommergibile”. Il riferimento era ad una piccola mostra, un anteprima, che avevo curato al Castel dell’Ovo e che tra l’altro riporta su questo viaggio a Napoli sul sottomarino una serie di mie opinioni, alcune delle quali da me effettivamente sostenute. Il tutto è nato da un titolo di un comunicato stampa che riprendeva il fatto che Leonardo in un suo promemoria di viaggio aveva scritto proprio così: a Napoli con il sommergibile… e con il modo di camminare sopr’acqua. E dal fatto che nella mostra era presentato il sommergibile ricostruito per la prima volta in base ad alcuni accenni di Leonardo.
Ma ovviamente nessuno sbarcava col sommergibile, ed il modo di camminare sopr’acqua è un altro tema che è naturale che affascinasse Leonardo come qualsiasi uomo che sogna profeticamente, che sogna un futuro. Il problema della corrispondenza tra la comunicazione e quello che si vorrebbe comunicare è dunque un punto fondamentale. E a me interessa entrare nel merito di quello che è lo specifico ancora una volta di un approfondimento nello studio dell’antico.
Leonardo aveva le sue utopie, spesso voleva quadrare il cerchio, e studiava il moto perpetuo. “Mi hanno dato oggi – scriveva in una mattina di natale – per mancia questa invenzione”. Aveva trovato cioè la quadratura del cerchio di una luna. Poi cancellava perchè non era vero. Così come di volta in volta scriveva: “eccetera, perchè la minestra si fredda” proprio negli stessi fogli di matematica e andava a mangiare, poi cancellava quello “eccetera” e ricominciava gli studi di matematica. Leonardo sembra profetizzare la mano palmata, oltre al sommergibile, e tutta una serie di espedienti per andare sott’acqua.
E in tutto questo si pone anche un problema di etica, perchè dice: “Certi espedienti – sostanzialmente allude alla guerra sottomarina – non ve li rivelo perchè sono a tradimento. Io vi rivelo altre armi che si vedono, ma non quelle a tradimento, invisibili, perchè fanno parte di una concezione di guerra sleale che non condivido”. (Curioso questa senso dell’etica di uno che definiva la guerra “pazzia bestialissima”). Anche quando si afferma che Leonardo è stato il profeta di tutto questo andar sott’acqua, e addirittura del camminare sull’acqua e volare, bisogna essere sostanzialmente realistici. Va bene colpire la fantasia, l’immaginario del largo pubblico, ma se scaviamo ci rendiamo conto di come già ai tempi di Leonardo ci fossero problemi di comunicazione.
Leonardo ad esempio pensava che le maree non fossero dovute alla luna, ma fosse il fondo del mare che respirava l’acqua. Egli si basava su una verifica empirica e non arrivava a concepire la realtà. Era però informatissimo sulle maree di tutto il mondo, perchè in tutto il mondo cercava corrispondenti. Cosicchè qualcuno, insieme alle maree, gli comunica come in Fiandra camminano sul ghiaccio. E viene a sapere che nell’oceano indiano i cercatori di perle e di coralli usano gli occhiali da neve – così li chiama lui – perchè evidentemente conosceva questi occhialini come occhiali da neve, perchè viene a sapere che nell’oceano indiano li usano i sommozzatori, e che usano anche degli espedienti per restare sott’acqua.
Per quanto tutto questo in parte cancelli il mito di Leonardo profeta del nuoto, del nuoto subacqueo, così come in altri casi sembra cancellarci quello del volo, mantiene però sempre un margine forte di scoperta e di suggestione, dato che quando un artista mette insieme l’idea del volare in cielo, dell’andare sotto l’acqua e del camminare sopra l’acqua, proprio in una maniera da Cristo, ci fa ovviamente impressione. (Il sistema di camminare sull’acqua speriamo presto di sperimentarlo dal vero).
E ciò che resta non è solo tecnologia, ma anche sogno: il sogno del volo, per esempio, non è solo un sogno tecnologico ma è immaginario, è archetipo, è inconscio, è un qualcosa legato alla psicologia di tutti i giorni e dei momenti dell’eccezionale fantastico. E’ curioso vedere come artisti profetici, completamente diversi tra loro, del nostro secolo, un romantico-visionario come Boechlin e Taklin, il famoso costruttivista russo della Rivoluzione, abbiano tutti ripreso le idee di Leonardo e le sue profezie sul volo (alla fine diventano sue, anche se prima di lui molti altri ci lavoravano).
Ma dal volo torniamo un attimo a quello che è una forma “volante” (questo è veramente un salto)di museo. Abbiamo accennato prima alla realizzazione di un museo ideale, ideale anche perchè cerca di raccogliere stimoli, provocazioni, spesso forti provocazioni, per attualizzare una cultura altrimenti troppo mitizzata, ormai stereotipata. Per fare questo non bastava avere una sede stabile, fissa, ma era necessario creare degli strumenti nuovi. Il museo virtuale era anni fa ancora alle premesse, oggi è una cosa del tutto normale.
Il museo volante è una altra cosa che abbiamo dovuto approntare, per spostare fisicamente delle cose; e poi gli archivi che non sono concepiti in maniera statica, ma sempre in maniera molto aperta, e sempre con quella ginnastica tra il passato e il presente, fino al kitsch, fino al consumo, fino ai mass media, fino a tutto quello che è la messa in discussione del mito e non solo della retorica più banale. Questo discorso sui musei è molto importante per quanto riguarda il tema della profezia, perchè il museo apparentemente è una forma codificata, conservativa. Esiste a questo proposito una letteratura infinita: in estrema sintesi si può dire che c’è chi si è scagliato contro il museo, dai futuristi in poi, e c’è chi ha parlato di rinnovamento in maniera a mio avviso sbagliata.
Personalmente proverei a soffermarmi su tre tipi di musei.
Il museo che conserva le grandi opere della civiltà, della cultura, del sapere, e che dovrebbe però essere perfetto. Oggi appare inspiegabile, con tutte le tecnologie ed il sapere in nostro possesso, che i musei, che poi sono fondamentalmente delle macchine anche sul piano del lavoro, dell’economia, della produzione, siano così lontani dalla perfezione che dovrebbero esprimere, anche quando trattano di cose fondamentali per la civiltà del passato e del presente. Caserta ad esempio ha un museo che da solo ha una potenzialità infinita: con i suoi milioni di visitatori ogni anno, è uno dei musei più visitati d’Italia ed è pazzesco pensare che un museo del genere non inneschi tutta una macchina di produzioni culturali, di animazioni, di corti circuiti sociali.
Ci sono poi i nuovi musei, quei musei di arte contemporanea che si muovono spesso tra molti stenti, che si scontrano con l’incomprensione per le forme di arte attuale, perchè inspiegabilmente, dobbiamo riconoscerlo, l’arte che dovrebbe essere più facile per noi, quella del nostro tempo, è profondamente incompresa. E anche tra chi pratica l’innovazione e coloro che praticano l’informazione non sembra esserci alcun rapporto tra esperienze artistiche ed esperienze in cui operino tecnologie. E anche quando tale rapporto è minimo, o magari c’è e non ce ne accorgiamo, rimane pur sempre una sorta di rigetto verso una vera e propria interdisciplinarietà, una vera e propria interazione.
C’è infine quello che ho chiamato museo ideale, o si potrebbe meglio definire museo profetico. Il museo dove tutte le cose s’innestano come in una macchina attiva. Un museo estremamente vivo, che tiene conto di tutta una serie di problemi, innanzitutto quelli di etica e di democrazia.
La profezia di Leonardo relativa a questi uomini che oggi si parlano da lontano e si rispondono, fatta circa cinquecento anni fa, fa sorridere oggi, dato che anche a livello di musei, per esempio, io posso dialogare con tutti i musei del mondo. E infatti succede quotidianamente di parlare ora con l’India ora col Sudamerica. Ma non riesco a parlare nel mio Paese con l’altro museo, quello istituzionale, il museino tradizionale e pubblico, anche a causa delle degenerazioni del sistema politico che tende a creare posti di lavoro sbagliati per le persone sbagliate. Allora cos’è tutta questa comunicazione, se non può funzionare nello spazio di cinquanta metri? Oppure, e salto ancora da un caso all’altro, com’è che viene vissuto questo miraggio di Bill Gates?
Voglio riportarvi un esempio che riguarda da vicino il nostro museo. Volevamo acquistare il codice Hammer, che abbiamo perso all’asta di New York, quando già avevamo scritto il comunicato stampa con il consolato italiano per annunciare che “Torna in Italia il codice Hammer”. Lo compra invece Bill Gates con cinquanta miliardi, fa una biblioteca apposta per accoglierlo, ma poi sta un anno senza vederlo perchè “naturalmente” sa di averlo.
Tutto questo introduce il grande tema dei diritti di autore, di quella che è libertà di informazione, di comunicazione e di quei musei perfetti, di cui parlavo all’inizio, quelli che custodiscono il sapere davvero straordinario, i capolavori assoluti. Ebbene, non si riesce a rinunciare all’idea di esporre l’originale per un secondo, e farti vedere una splendida, fedelissima riproduzione, per consentirti poi di accedere semmai per giorni interi a quelli originali, ma in altra maniera.
Questi musei qualche tempo fa si dovevano rinnovare, ma questo rinnovamento in cosa si è tradotto alla fine? All’inserire nei musei un caffè, un bar e uno shopping, e al tempo stesso nel far pagare diritti carissimi di autore su ogni immagine che viene riprodotta. Questo dal punto di vista della civiltà della comunicazione mi sembra la cosa più grottesca, perchè praticamente si andrà ad introdurre nei musei la vendita delle stesse cose kitsch che venivano vendute sulle bancarelle.
Si è rinunciato a cambiare la sostanza del museo e la sua vivibilità, dato che nessuno prenderà il caffè e si fermerà a dialogare all’interno del bar del museo, e al tempo stesso si sta costringendo tutti gli autori più seri, che finanziariamente non hanno disponibilità inesauribili, a non pubblicare più libri. I libri li pubblicheranno solo i funzionari delle soprintendenze dei musei, perchè questi vincoli insistiti sulla possibilità di fare fotografie, di averle, di pubblicarle, il costo che tutto questo comporta sta limitando fortemente l’informazione.
Credo sia questo un punto interrogativo da porci anche oggi, quando si parla di etica e di comunicazione, quando si parla di profezia della comunicazione, perchè è una profezia perfettamente tagliata.
Quando abbiamo pensato di realizzare il museo ideale avevamo in mente una forma apertissima di comunicazione, dove tutto quanto portasse a un caleidoscopio di scoperte, di situazioni praticabili, vissute, dove veramente anche il museo diventasse un opera d’arte vissuta. Tutto questo perchè? Per il senso profetico di vedere un rapporto costante tra l’uomo e il territorio, fra il museo e il suo territorio e il sociale; per l’idea che la scienza e la tecnologia operino veramente per il progresso civile; perchè tutto questo ci sembra irrinunciabile.
Concludo con una ultima profezia di Leonardo, che è diventata per noi un monumento, ma un monumento non retorico, un modello di monumento che speriamo di realizzare con l’aiuto di tanti e di tutti, compreso voi, in tante città del mondo. Leonardo dice che “piglierà il primo volo, il grande uccello, la macchina volante, sopra del dosso del suo magno cecero (il monte del Cigno presso Firenze) empiendo l’universo di stupore, empiendo di sua fama le scritture, e gloria eterna al nido dove nacque”. Leonardo stranamente parla di gloria, e parla di fama, lui che continuamente si è dovuto scagliare contro i trombetti, contro tutto il sapere accademico e formale e libresco del suo tempo, rivendicando l’arte come scienza, come “prima” delle scienze, proprio per la sua capacità di intervenire sul reale.
Ecco la domanda con la quale intendo concludere: fino a quando, contrariamente a quello che succedeva in passato, l’artista resterà estraneo? Sarà allontanato dalla possibilità di intervenire nel progetto, e nella costruzione di quella che è la città del futuro e di quella che è la società del futuro? Di quella che è in sostanza una società, chiamatela estetica, chiamatela artistica, chiamiamola etica, ma comunque una società che a noi interessa, perchè è sicuramente più vivibile?
Come vedete non è una profezia, ma è una domanda dalla quale però spero nascano delle profezie, grazie anche a tanti piccoli frammenti di utopia realizzata. Del resto oggi è difficile realizzare una grande utopia, lanciare grandi profezie, ma forse possiamo, anche in contesti limitati, valutare la praticabilità di piccoli ma importanti messaggi da realizzare, piccole ma importanti strade da percorrere. E’ questa, con un po’ di retorica, la mia conclusione.

È già stato accennato che cosa significa videolavoro, un termine coniato soltanto recentemente. Per la verità detto così potrebbe sembrare riferito a un lavoro che ha a che vedere con la televisione; invece non c’entra assolutamente niente. Il videolavoro è semplicemente una della accezioni o uno dei modelli a cui si fa riferimento quando si parla di telelavoro.
Il telelavoro è un argomento in questo momento abbastanza sotto i riflettori. In particolare dei mass media. Stamattina in ufficio ho trovato la solita rassegna stampa e nelle prime pagine sembra si parli soltanto di questo. E spesso in modo contraddittorio. Sullo stesso quotidiano, Il Sole 24 ore, si dice ad esempio : “sale la produttività con il telelavoro” e poi “telelavoro decollo lento”; oppure “il telelavoro fa crescere la produttività aziendale” e “nell’era del telelavoro diamo addio allo stress”. In realtà credo che la questione sia un po’ più complicata.
Esistono diversi modelli, diverse accezioni con i quali si può intendere il telelavoro: io farò riferimento soltanto a quei modelli, e a quelle accezioni, per le quali la mia diretta esperienza di lavoro in IBM può dare qualche contributo.
Non parlerò ad esempio di quello che si può identificare come lavoro a domicilio. Molte volte si parla di Telelavoro a domicilio nel senso che il lavoro viene portato a casa del lavoratore la cui casa viene attrezzata con tutti gli strumenti necessari per potergli far svolgere lo stesso lavoro che faceva in ufficio. Non ne parlo perché è un problema di cui non ho diretta esperienza, dato che nella mia azienda, questo tema è in fase di discussione, anche con le organizzazioni sindacali. Non avendo una esperienza molto diffusa su questo terreno, finirei col fare delle considerazioni di tipo teorico, di tipo generale, parlando di quelli che possono essere i problemi di tipo sociologico, organizzativo, psicologico e così via, e non sono la persona più qualificata per potere affrontare questi discorsi.
Parlerò invece di altri due tipi di telelavoro: uno è quello che si chiama normalmente lavoro mobile o ufficio mobile, come lo chiamiamo noi.
nella nostra organizzazione esistono delle figure professionali che sono i rappresentanti, persone che hanno il compito di andare dal cliente, individuare quelle che sono le sue competenze, individuare quindi tra le soluzioni possibili con i prodotti IBM quella che soddisfa meglio le sue esigenze.
Fino a qualche tempo fa anche il rappresentante IBM andava in giro con la sua borsa e con le sue carte, da un anno a questa parte invece circa duemila di loro sono dotati di un calcolatore portatile, un notebook, che si può collegare su di una linea telefonica chiamando un numero verde, quindi a totale carico della società. Sia a casa propria, sia presso il cliente egli può collegarsi quindi al sistema informativo aziendale.
A quale scopo? quali sono i vantaggi o i risultati che si possono ottenere da tutto questo?
Il rappresentante può ad esempio avere in tempo reale la presentazione di un determinato prodotto che serve al cliente in quel determinato momento; se, parlando con il cliente, si accorge che deve modificare qualche cosa nel contratto ha la possibilità di farlo direttamente in linea avendo i documenti che servono effettivamente in quel momento. Tutto questo fa sì che si riduca moltissimo il tempo che viene perso normalmente quando il rappresentante va dal cliente, discute, prende appunti di quello che serve al cliente, ritorna in ufficio, fa le sue cose, ritorna poi dal cliente con la documentazione e la dimostrazione pronta e così via. Oggi può essere realizzato tutto sul posto, ed è una soluzione che rende sicuramente più produttivo il lavoro. Non so se del 13% come si sosteneva su qualche giornale ma so che è un risultato ottenibile proprio perché persino intuitivamente è chiaro che si riducono moltissimo quelli che sono i tempi morti del contatto con la clientela.
Questo è quindi un primo tipo di modello di telelavoro o ufficio mobile.
Vorrei ora soffermarmi su di un altro tipo di modello e di accezione del telelavoro che riguarda direttamente la mia attività. io dal ’92 dirigo qui a Napoli un centro che ha come missione quella di sviluppare applicazioni multimediali. in queste applicazioni quindi ci sono testi, ci sono video, suoni, voci e immagini in movimento, animazioni ecc.
Queste applicazioni multimediali hanno una ulteriore caratteristica: per il loro sviluppo si richiede l’integrazione di diverse professionalità. Una è certamente la professionalità o la competenza informatica. C’è poi l’esperto di comunicazione ovvero colui che dà la sceneggiatura o fa la sceneggiatura dell’applicazione, che individua quello che è il target come utente dell’applicazione e quindi definisce qual è l’applicazione o come deve essere strutturata in modo da raggiungere gli obiettivi prefissati. C’è l’esperto dei contenuti, che conosce la materia che si sta trattando in quel momento e che quindi fornisce i contenuti; il grafico, che sa fare i disegni, le animazioni; colui che produce l’audio; quello che produce o gestisce il video; quello che acquisisce le immagini. tutte queste professionalità vengono integrate dalla professionalità informatica per avere un insieme integrato e quindi una applicazione multimediale.
Queste diverse professionalità, per realizzare una applicazione informatica, devono concorrere in modo molto interattivo, devono cioè interagire continuamente tra di loro. Si rischia altrimenti, se non sono coordinati opportunamente, che ognuno vada per la sua strada, con il risultato di ottenere un prodotto che non funziona, che non riesce a raggiungere quelli che sono gli obiettivi prefissati. Ora queste figure professionali possono essere presenti tutte in una medesima struttura, non so nel mio centro piuttosto che in una qualsiasi altra struttura che produce applicazioni multimediali?
E questo che cosa comporta come risvolto negativo?
comporta ad esempio che mi dovrei rivolgere, se avessi sempre a disposizione, ad esempio, i grafici, sempre a quei determinati grafici, sia che produca un corso per bambini delle scuole elementari, sia che produca un chiosco informativo che serve per dare delle informazioni ai cittadini sul turismo, sui beni culturali o quant’altro. mi dovrei rivolgere sempre ai miei, perché li avrei in casa.
ma questo avrebbe sicuramente un influsso negativo sulla qualità del prodotto finale.
Molto meglio è infatti potere accedere alle singole professionalità di cui parlavo prima, quelle che nei singoli momenti, nelle singole attività, nei singoli progetti che sto sviluppando ritengo più opportune, più qualificanti, più adatte per quella determinata realizzazione.
Ma queste professionalità dove sono? sono sparse nel territorio. E se io vi devo accedere, se devo continuamente lavorare con queste professionalità, dato che , come dicevo prima, l’applicazione richiede un forte grado di interazione non mi resta allora che fare riunioni, incontrarsi, vedersi, con un aumento considerevole dei costi e dei tempi necessari a mettere assieme il grafico che si trova a Milano piuttosto che a Bari e così via.
Noi stiamo utilizzando quella che si chiama videoconferenza, cioè la possibilità di collegare i nostri strumenti di lavoro. Linee telefoniche, personal computer, telecamera e software appropriato consentono di scambiare, con la persona con cui si sta lavorando in quel momento, il proprio schermo.
Collegandomi con il grafico che sta a Novara è come se lo avessi affianco: lui riesce quindi a farmi vedere sul mio video quello che sta facendo in quel momento, io gli faccio vedere quello che sto facendo e quindi in quale punto, in quale momento il suo lavoro si integra con il mio.
In questo modo è come se effettivamente lavorassimo fianco a fianco, dato che tali mezzi mi permettono di interagire in qualsiasi momento lo ritenga più opportuno.
Nel produrre una determinata applicazione posso collegarmi con qualsiasi di quelle professionalità di cui abbiamo parlato prima in modo da verificare, confrontare e lavorare insieme.
Questo che cosa comporta? Comporta riduzione di costi, perché a non devo andare avanti e indietro; comporta riduzioni di tempi di realizzazione e quindi ancora di costi, e soprattutto mi consente di svincolarmi completamente dai problemi di distanza fisica, nel senso che per me il grafico o l’esperto di comunicazione che si trovi a Napoli piuttosto che a Casoria , o a Domodossola, è esattamente la stessa cosa che si trovi in Germania o in Inghilterra.
ho quindi la possibilità di potere collaborare e potere lavorare insieme con le professionalità che di momento in momento, di progetto in progetto, ritengo più opportuno per il mio scopo. E se associamo a queste possibilità insite nel lavoro in videoconferenza, che poi in realtà è più un misto tra videoconferenza e lavoro cooperativo, (altro elemento estremamente importante!) con altre strutture, con le possibilità offerte dalle reti tipo internet, (aldilà degli aspetti di moda) si può accedere a tutta una serie di informazioni che riguardano l’esistenza di possibili professionalità a cui far ricorso per poter collaborare insieme.
Ad esempio professionalità o gruppi di persone che si trovano in un paesino sperduto di una delle tanti valli italiane hanno la possibilità di mettere le informazioni, le sue pagine su internet e dunque di lavorare con noi, o con qualsiasi altra struttura, come se fosse a fianco a noi.
In definitiva l’esperienza che ho fatto e che sto facendo con il mio lavoro mi dice che il videolavoro è veramente molto utile per sviluppare prodotti, migliorare la produttività della mia azienda e delle altre stutture che possono così crescere senza il bisogno di dovere essere a fianco della mia azienda o trovarsi nei posti dove si produce. È evidente che tutto ciò ha un presupposto fondamentale nella vera realizzazione delle autostrade informatiche: le linee telefoniche devono esserci, devono esserci a sufficiente velocità e devono essere soprattutto a tariffe che siano accessibili.
Tutto il discorso infatti casca, peggio del famoso asino, se a un certo punto tutta questa disponibilità di tecnologie, di esigenze, di soluzioni ecc, non fosse supportato da strumenti che consentano di utilizzarlo.

La falsificazione
In termini generali la falsificazione può essere definita come l’assunzione, da parte di un soggetto, o il conferimento da questi, ad un oggetto, di una identità o di un modo di essere diversi da quelli posseduti, ovvero propri di altri soggetti o oggetti. La finalità di questa assunzione e di questo conferimento di identità consiste nel tentativo, per colui che li pone in essere, di conseguire un vantaggio rispetto ad altri, o, anche, in quello di creare uno svantaggio – in alcuni casi – a chi è usurpato della propria identità – in altri – a chi, non avendosi modo di rendersi conto dell’usurpazione, orienta il suo agire sulla base di una rappresentazione fondata sulla certezza dell’autenticità dell’identità che viene offerta alla sua percezione.
La falsificazione, dunque, è un tipo di azione che può essere posta in essere da un attore che interagisce con altri in una situazione di tipo competitivo/conflittuale, nella quale il primo annette alla sua iniziativa la possibilità di ottenere qualche beneficio per sè o per gli altri, a cui in una determinata occasione può essere collegato da una sintonia di interesse – anche attraverso la sola produzione di un impedimento alla realizzazione degli obiettivi che intendono proseguire i soggetti nei cui confronti l’azione in questione viene ad essere concepita e sviluppata. In quest’ottica la falsificazione si pone sia come strumento di aggressione dell’altro che di difesa da questi o di sabotaggio delle sue capacità offensive. Due sono le principali modalità attraverso cui può essere attuata la falsificazione da parte di un soggetto su se stesso o in relazione ad uno specifico prodotto che egli appronta: l’occultamento e/o la mimetizzazione dell’identità posseduta ; l’assunzione di una identità diversa da quella che gli è propria e/o l’approvazione di un’ identità di altri.
Queste due modalità si concretizzano, per lo più, nel ricorso ad una delle seguenti azioni nonché a combinazioni tra esse :
a) la soppressione di caratteristiche dell’identità o della condizione originaria;
b) la modifica di caratteristiche dell’identità o della condizione originaria;
c) l’aggiunta di caratteristiche non possedute dall’identità o alla condizione originaria;
d) la totale creazione di una identità inesistente ;
e) la riproduzione e l’utilizzazione degli elementi che contraddistinguono l’identità propria di altri.
Il fenomeno della falsificazione dei prodotti manifatturieri
Le dimensioni che il fenomeno della falsificazione ha raggiunto nel corso degli ultimi dieci anni sono davvero strabilianti. Nessun settore delle attività produttive, artistiche, culturali, e finanche scientifiche, si può dire al riparo dalle insidie di falsari sempre più aggressivi e dotati di strumentazione e di conoscenze tecniche di elevatissimo livello. La storia ci segnala che da “sempre” falsi e falsari sono stati presenti ed attivi nelle vicende sociali economiche del consorzio umano, tuttavia è negli anni a noi più vicini che le attività di contraffazione, in relazione specialmente ad un ampia gamma di prodotti manifatturieri, hanno assunto, diffusioni aspetti e caratteristiche che le rendono non solo una preoccupante minaccia di tipo economico, ma anche, in un numero crescente di situazioni, un pericolo per l’incolumità e la salute di vaste schiere di persone.
Il pericolo dei falsi
In quasi tutte le società industriali, per la maggior parte dei cittadini e dei consumatori, allorquando viene loro posto il problema della contraffazione nel settore manifatturiero, il riferimento visivo che, in modo immediato e spontaneo viene ad essere evocato attiene per lo più a prodotti relativi all’abbigliamento alla pelletteria, o, ancora, all’orologeria ed ai preziosi in genere. Sulla base di rappresentazioni di questo tipo, l’atteggiamento nei confronti del fenomeno della falsificazione finisce con il variare all’interno di due opposte sponde, da un lato, quella caratterizzata dal timore di poter incorrere in spiacevoli “bidoni” dall’altro, quella segnata da una certa ammirazione per l’ingegnosità e per la perizia di alcuni falsari particolarmente”bravi”. Le reazioni sarebbero, però, ben diverse se si tenesse in debito conto che, per i beni in questione:
a)produttori e venditori non sono certo tra coloro che pagano le tasse per i profitti che ricavano dalle loro attività;
b)nella stragrande maggioranza dei casi, quanti materialmente lavorano produzioni delle merci contraffatte non sono minimamente tutelati nè per quel che attiene al salario, a diritti previdenziali o alle condizioni igieniche, di sicurezza e di salute;
c)in altre aziende ed altri lavoratori da essi dipendenti possono ricevere danni anche molto ingenti da questa forma dipirateria commerciale.
Queste reazioni porterebbero, poi, un segno ancora più intenso e forte se ai cittadini ed ai consumatori potesse essere rammentato che, oltre alle produzioni appena citate, l’industria della falsificazioni immette sul mercato prodotti chimici, medicinali, fitofarmaci fertilizzanti, impianti elettrici, pezzi di ricambio, e freni per auto ed aerei, privi di qualsiasi validità che costituiscono spesso, attentati pericolosissimi alla vita delle persone e che, essendo pressoché tutte le produzioni realizzate da aziende che operano clandestinamente è estremamente probabile che da esse vengano dispersi nell’ambiente senza alcuna precauzione residui nocivi e velenosi.
Dai falsi di lusso a quelli relativi ai consumi quotidiani
Oggetti preziosi, orologi di alta precisione e qualità dimateriali, opere d’arte, reperti archeologici, pezzi di antiquariato, capi di abbigliamento, atti a conferire prestigio ai loro possessori/ostentatori, in ragione di profonde modifiche dei canoni attraverso i quali definire il “Bello” e di manifestare la riuscita sociale dei singoli, hanno occupato posizioni di crescente importanza nelle scelte di consumo di una molteplicità di attori sociali , ma anche nelle aspirazioni di altri totalmente privi di risorse adeguate per pervenire al loro acquisto. Nella prima fase dello sviluppo delle società industriali, contraddistinte dai cosiddetti consumi di massa, la produzione e la commercializzazione di beni contraffatti ha riguardato, ancora principalmente, merci di lusso, per la cui realizzazione erano indispensabili, ai fini di una riuscita dell’inganno, la padronanza di competenza tecniche e buona capacità professionale, le quali se, da un lato, non erano facilmente reperibili,ed andavano adeguatamente remunerate, dall’altro, davano luoghi a prodotti che, per quanto fosse in espansione l’insieme dei loro possibili acquirenti, potevano contare su un assorbimento di dimensioni circoscritte. Benché in progressivo ampliamento, quindi, la gamma delle produzioni contraffatte, sempre incentrate sui generi di lusso, ha mantenuto a lungo le sue antiche e nette caratteristiche quali:
l’accuratezza delle realizzazioni;
la ridotta produzione, da parte delle singole unità di fabbricazione (anche se il numero dei soggetti che hanno orientato in direzione della falsificazione manifatturiera la loro attività di procacciamento di profitti è andato progressivamente crescendo);
i prezzi di vendita dei singoli prodotti relativamente elevati, tanto perché potesse essere possibile, con numero ridotto di esemplari falsi, ricavare introiti che ne rendessero conveniente la produzione e il commercio, quanto perché l’acquirente da ingannare potessero essere indotto a ritenere di trovarsi di fronte a merce autentica, pagata, si spera, ad un prezzo di mercato inferiore a quello praticato ufficialmente, ma non tanto basso da destare sospetti di imbroglio.
Fino all’incirca a due decenni fa il mercato dei falsi è stato costituito essenzialmente da prodotti dotati di queste peculiarità, fermo restando che nel periodo bellico ed in quello immediatamente successivo ad esso, essendo divenuto di lusso anche tanti generi alimentari, oppure di scarso valore di mercato prima della guerra (come ad esempio, le sigarette), questi vennero falsificati, via via manipolati, per realizzare artificiosi aumenti delle quantità offerte in vendita al mercato nero. E’ nel corso del periodo che in molti hanno indicato come la Grande Crisi degli anni settanta e ottanta e che ha sconvolto logiche ed assetti finanziari e produttivi di tutti i paesi aprendo la strada ad aspre forme di competizione globale, che nell’area delle produzioni e del commercio dei falsi manifatturieri sono avvenute profonde modificazioni. Il mercato della contraffazione si è infatti rapidamente trasformato in una sorta di comparto dell’economia illegale non più incentrato principalmente sulla realizzazione e sulla vendita di limitate quantità di beni di lusso, bensì sulla realizzazione e sulla vendita in massa di beni di largo consumo.
Vari elementi si sono combinati tra loro – e in tutti i paesi ed in tutte le aree del mondo,più o meno incertamente avviati a da tempo marcatamente assestati lungo percorsi di crescita incentrata sulle attività di produzione manifatturiera hanno dato luogo a quella che è possibile indicare come la nascita dell’industria del falso.
Tra essi certamente di rilievo sono state :
la condizione di difficoltà di molte piccole e piccolissime unità produttive, escluse dalla possibilità sia di mantenere la pur esigua parte di mercato raggiunta, sia di operare (o di farlo con qualche margine di profitto accettabile) per conto di iniziative di dimensioni più grandi e di maggiore peso sulla scena economica ;
la crescita di manodopera disponibile a fornire prestazioni lavorative in modo clandestino, occasionale e a basso prezzo ;
le semplificazioni di molti processi produttivi posti in atto dalla quasi totalità delle imprese di medie e di grandi dimensioni, al fine di ridurre costi, personale, e tempi di produzione ;
la crescente disponibilità sul mercato di strumenti e di attrezzature tecniche capaci di rendere agevole la duplicazione (di variabile riuscita) di prodotti già esistenti ed affermati e, soprattutto di tutto ciò che può consentire un’appropriazione dei tratti con i quali essi sono riconosciuti dai consumatori ;
le forti e perduranti tensioni e confusioni che, con alti e bassi di inflazione e l’alternarsi di stagnazioni e ripresa hanno introdotto stabilmente nel mondo del commercio e della distribuzione e che hanno comportato situazioni di fortissimo disorientamento dei consumatori.
I falsi ed i “doppi”
Nel corso degli anni ottanta attraverso il diverso combinarsi degli elementi appena segnalati, nei diversi contesti economico territoriali, ha cominciato, pertanto, a fare la loro apparizione sul mercato un’enorme quantità di falsi di tipo nuovo rispetto al passato, realizzati per essere inseriti nel grande calderone dei beni di appartenenti alla sfera dei consumi quotidiani di ogni cittadino, senza differenziazioni di reddito. Accanto ad essi, si è moltiplicata la presenza di altri prodotti, appartenenti ai più svariati comparti manifatturieri, dotati di aspetti e di confezioni fuorvianti ed ingannevoli, che spesso qualcuno chiama “falsi”, ma che in realtà non possono essere definiti tali, dal momento che essi si propongono ai consumatori mimetizzando la loro vera identità, e quella delle imprese che li realizzano, pur senza annullarne completamente ogni traccia. In altra sede sono stati approfonditamente esaminati i diversi componenti di questo mondo dei doppi che ha invaso i mercati in tutti i Paesi del mondo, tuttavia è qui opportuno rammentare quelli che marcano una maggiore presenza, segnalando sinteticamente i tratti più significativi che li caratterizzano. Il primo tipo di doppio è quello che scaturisce dall’imitazione confusoria dei prodotti (tipologie produttive, forme, insegne,marchi , confezioni, ecc..), una operazione che si sostanzia nella produzione e/o nell’introduzione nel mercato di beni, nel genere e nell’aspetto, molto simili, ma, volutamente, non perfettamente identici ad altri realizzati da altre imprese e già, in qualche modo, affermati. L’intento di coloro che pongono in essere iniziative di questo tipo è essenzialmente quello di introdurre i consumatori all’acquisto inducendo in essi il convincimento di trovarsi di fronte al prodotto noto ed apprezzato verso il quale essi avevano progettato di dirigere la propria scelta, avendolo conosciuto attraverso gli investimenti pubblicitari effettuati dal suo realizzatore. Solo procedendo ad una più minuziosa osservazione del luogo o del corredo di indicazioni concernenti l’identità del produttore, di cui la normativa prescrive la presenza e che nella maggioranza dei casi corredano questi doppi, è possibile scoprire la reale identità della merce replicata. Una variante di questa modalità di inganno dei consumatori è rappresentata dal secondo tipo di doppio, il richiamo confusorio di un marchio altrui, una situazione che si configura allorquando i diversi elementi che caratterizzano l’immagine d’insieme di un prodotto, realizzato da una impresa già operante e nota ai consumatori, vengono utilizzati da un’altra azienda che propone al pubblico una merce che, pur evidenziando, ad un esame più attento, una autonoma identità, si avvale, per il primo impatto con i potenziali acquirenti, di accattivanti effetti di “famigliarità” e di positive sensazioni di “già visto” che la privilegiano ai loro occhi rispetto ad altri anonimi concorrenti della stessa linea merceologica e, probabilmente, della stessa modesta qualità, traendo beneficio dal prestigio conquistato e dagli investimenti promozionali effettuati da un’altra iniziativa manifatturiera di ben più solido livello. Un terzo insieme di questa schiera di replicanti è costituito da beni realizzati da unità produttive che si impossessano di noti marchi distintivi che contraddistinguono prodotti di aziende particolarmente affermate in altri comparti manifatturieri e li utilizzano per caratterizzare le proprie merci, appartenenti a diverse aree merceologiche, più o meno limitrofe – ma non le stesse nelle quali operano le unità depredate, con lo scopo di lasciar supporre ai consumatori l’esistenza di legami giuridici o economici tra i loro prodotti e quelli realizzati dai titolarti dei marchi di successo o addirittura, che, quanto da essi immesso sul mercato, indichi che società che anno portato alla notorietà i loro marchi in uno specifico settore hanno fatto ingresso in nuovi ambiti produttivi, per ampliare e diversificare dalle loro tradizionali attività. L’imitazione del prodotto esteriore e del design di un prodotto – con o senza l’appropriazione del processo produttivo necessario per realizzarlo – con cui un impressa si è presentata con una specifica identità di fronte ai consumatori ottenendo i loro consensi, costituisce una quarta modalità di ampliamento della schiere dei doppi, nella misura in cui questa operazione (che in taluni casi deborda anche in azioni di spionaggio industriale) viola i diritti di ideazione di quest’ultima ed induce gli acquirenti a ritenere di trovarsi in presenza del bene fabbricato dall’azienda che ha sopportato i costi necessari per concepirlo e lo ha fatto affermare sul mercato. Se è vero, pertanto, che ognuno di questi tipi di duplicazione si estrinseca nell’assunzione, variamente accentuata, di sembianze altrui, inquinando il mercato, creando danni ad una serie di imprese ed ingannando i consumatori, essi costituiscono qualcosa di ben diverso rispetto all falsificazione totale, in ragione di un dato caratterizzante di quest’ultima di estrema rilevanza. La falsificazione totale – infatti consiste nella produzione clandestina e nella collocazione di beni il più possibile simili – specialmente per quello che riguarda la loro “veste di presentazione” ai consumatori – a quelli realizzati d un altra impresa (che li ha ideati, lanciati, fatti affermare) e spacciati per questi. Mentre i doppi di marchi e/o beni già esistenti le imprese che li fabbricano non si occultano, masi mimetizzano ed operano sfruttando l’equivoco, l’ambiguità il cavillo e le loro attività di produzione e di commercializzazione avvengono attraverso modalità non troppo diverse da quelle di altre iniziative che quotidianamente si confrontano lealmente sul mercato, gli operatori della falsificazione totale fanno di tutto per rendersi il più possibile invisibili ed insistenti Nei confronti delle prime, quindi, le aziende che ritengono di subire dei danni, in ragione delle sembianze che esse conferiscono ai loro prodotti, come pure i consumatori, indotti ad erronei acquisti, possono intraprendere azioni di tutela dei propri diritti (che il più delle volte hanno successo) essendo possibile la individuazione delle loro controparti, nei confronti dei secondi, invece, tanto le ditte danneggiate, quanto i consumatori che si accorgono di essere stati ingannati hanno enormi difficoltà a scoprire gli autori della fabbricazione della immissione sul mercato dei falsi in senso stretto. I luoghi nei quali avvengono le produzioni, le forme di trasferimento da questi ai punti vendita, la parte più consistente dei canali di smercio sono tenuti gelosamente nascosti, pronti ad essere smantellati o bloccati quanto c’è il sentore, da parte dei falsari, dei un aumento della probabilità di essere scoperti.
Consumatori ignari e falsari “ignoranti”
I preziosi orologi offerti dai “pataccari”, le 536 tonnellate e le 600 mila confezioni di prodotti alimentari di grandi marche, scaduti e riconfezionati con nuove date di scadenza, scoperti nel salernitano qualche settimana fa dai NAS, possiedono, dunque, lo stesso comune denominatore della clandestinità delle loro produzioni e delle loro modalità di collocazione sul mercato, ma essi, – come è stato detto – si differenziano tra di loro per il fatto che gli uni appartengono alla sfera dei consumi di lusso e gli altri a quelli della quotidianità. Questa difformità comporta, sullo scenario relativo ai comportamento dei consumatori, in specie a partire dagli ultimi dieci -. quindici anni, altre importanti differenze, che è opportuno rimarcare. La prima delle quali consiste nel fatto che ancora oggi è dato incontrare “sconosciuti” che propongono l’affare dell’ orologio di gran marca a basso prezzo, la stragrande maggioranza degli interpellati è consapevole che l’eventualità di trovarsi di fronte a uno spacciatore di falsi è certa. Chi davvero intende fare dono di un orologio d’oro o vuole gratificarsi acquistando una costosa borsa, segnata dal marchio di una grande casa, si reca in un orificeria di fiducia o nell’elegante negozio di vendita della maison. Per converso, la totalità di coloro che acquistano prodotto di largo consumo contraffatti li comperano e li utilizzano senza sospettare di potere avere a che fare con dei falsi. Il livello di attenzione di cui viene degnato un bene posto in vendita ad un prezzo relativamente basso, come può essere un detersivo, un lubrificante per l’automobile, un biglietto per la metropolitana, non consente di cogliere – se vi sono – difetti o anomalie del loro aspetto esteriore. E se qualche esercizio o qualche bancarella del mercato rionale praticano sconti incoraggianti non insospettiscono più di tanto anche eventuali leggere imperfezioni delle confezioni. Ancor meno, poi, ci insospettisce il farmacista che ci da un farmaco. Inoltre, a causa sia della relativa semplicità di realizzazione di molti dei prodotti di consumo quotidiano, che sono entrati e continuano ad entrare nel mirino dei falsari, sia della perfezione che, con l’uso di alcuni non eccessivamente costosi macchinari, può essere raggiunta nell’approntamento delle confezioni e delle “sembianze esteriori” dei beni contraffatti, ha iniziato a contrarsi sempre più l’area delle merci falsificate grazie a ll’intervento di specialisti dei diversi comparti merceologici entro i quali trovano collocazione i singoli tipi di falsi. Agli artigiani falsari, dotati di una certa professionalità e specializzazione, sono andati a sostituirsi nel caso di una molteplicità di beni, operatori specializzati nel falso manifatturiero in genere, che non hanno nessuna capacità personale di fabbricare prodotti dei quali ignorano peculiarità ed aspetti tecnici ma, in compenso, sanno bene come – a prezzi convenienti – acquistare i materiali che possono essere usati per la fabbricazione dei loro simulacri, dove reperire soggetti che possono eseguire le lavorazioni e gli assemblaggi (senza fare troppe domande e senza divulgare notizie) ed in che modo mescolare nel flusso commerciale i risultati di questi due insieme di operazioni. Paradossalmente, la loro ignoranza tecnica è anche il loro elemento di forza e di sostegno per una costante presenza nel mercato della contraffazione, dal momento che, a fronte di possibili cambiamenti degli orientamenti dei consumatori, all’adozione di qualche scoraggiante misura anticontraffazione da parte delle imprese da essi falsificate, all’improvviso scemare della domanda del bene su cui avevano concentrato la loro attività, all’apparire di nuovi prodotti molto richiesti, essi dispongono sempre delle “risorse” sufficienti per iniziare a contraffare altre merci, anche di settori e con tratti caratteristici molto distanti rispetto a quelli propri delle produzioni precedentemente oggetto del loro interesse. Questa assenza di specializzazione tecnica e di conoscenze merceologiche di base, così come è un elemento che gioca a favore di chi trae profitto dall’attività di produzione e di smercio dei falsi, costituisce anche la principale ragione dei rischi gravi che possono correre molti di coloro che acquistano prodotti contraffatti appartenenti all’ampia sfera dei beni consumati/utilizzati quotidianamente da milioni di persone. Il falsario negli anni ottanta e novanta è spesso una specie do apprendista stregone che concentra le sue attenzioni e le sue capacità sull’obiettivo della massima perfezione esteriore del prodotto attraverso il quale ha deciso di realizzare i suoi profitti, incurante ed ignorante delle implicazioni che possono avere i materiali, i componenti e i processi di fabbricazione che gli consentono di ottenere a buon mercato falsi dotati di livelli elevati di somiglianza al bene autentico. La tragedia del “vino al metanolo”, dovuta al tentativo di innalzare chimicamente il tasso di alcool di uve scarsamente zuccherine ; la “strage dell’olio di colza”, causata dai processi di “rinaturizzazione” per mezzo della soda caustica di partite tolte dal commercio come eccedenze e, quindi, denaturate per impedirne la riutilizzazione a fini alimentari ; gli inspiegabili incidenti domestici, provocati da materiali elettrici contraffatti, i rischi corsi da molti automobilisti inconsapevoli acquirenti di pezzi di ricambio falsi, sono solo alcuni esempi di una casistica che potrebbe essere molto lunga e che minaccia di ampliarsi ogni giorno di più.
Silenzi e grida
In presenza di questa trasformazione e di questa invasione del crescente esercito dei falsi manifatturieri, sul versante delle difese approntate dalle imprese produttrici dei beni contraffatti, la situazione attualmente in corso è paradossale ed allarmante. Premessa l’esistenza di un manipoli, ancorché modesto, di aziende molto impegnate nella lotta ai contraffattori dei propri posti, la situazione generale si presenta con i connotati del paradosso. Le imprese che all’apparenza appaiono più tenacemente protese nello sforzo di contrasto dei contraffattori e, certamente, quelle che più delle altre rendono manifesto il fatto che le proprie merci vengono falsificate, sono quelle che realizzano prodotti di lusso. Le aziende, invece, che fabbricano molti dei beni che tutti consumano abitualmente ogni giorno, o quasi, nella loro maggioranza, non danno segnali dai quali si possa desumere che siano minimamente coinvolte nel problema. Le prime sembrano ignorare che, da vari anni a questa parte, una percentuale elevatissima di coloro che comperano esemplari falsi dei loro prodotti non sono persone che si fanno abbindolare, ma soggetti che compiono i loro acquisti con consapevolezza che si tratta di contraffazioni. I falsari quindi non sottraggono acquirenti alle imprese produttrici dei beni di lusso più di quanto non lo facciano i livelli di reddito detenuti da quelle fasce di consumatori per i quali i beni di lusso si pongono al di fuori delle loro possibilità. Ciononostante, non sono poche le aziende di questo particolare settore che non perdono nessuna occasione per sottolineare la propria condizione di danneggiate e per proporre alla pubblica opinione di interpretare le aggressioni dei contraffattori come indicatori del loro successo e delle desiderabilità dei propri prodotti. I falsi si offrono come possibilità di invio di messaggi, neanche troppo impliciti, di invito all’acquisto. Messaggi che, quando provengono da aziende i cui prodotti sono realmente oggetto di contraffazione, costituiscono una scelta (forse opinabile)di comunicazione promozionale, fondata sul tentativo di trarre vantaggio da una apparente circostanza sfavorevole, quando, invece, di certi prodotti non sono in circolazione neppure quantità minime di contraffazione, l’ostentazione – con inserzione su intere pagine di grandi quotidiani nazionali – di una condizione di vittima dei falsari, accompagnata dalla sollecitazione a “provare il piacere di possedere” esemplari autentici di quei beni, mentre smentisce quanti sostengono che i falsi dei prodotti di lusso costituiscono una minaccia se non economica almeno d’immagine della realizzazione delle grandi case, la dice lunga sulla rappresentazione che, purtroppo, ancora negli anni novanta, alcune aziende ed alcuni pubblicitari hanno dei consumatori. Una rappresentazione che non è molto distante da quella che sembra ispirare i comportamenti di tante imprese produttrici di beni di largo consumo le quali, benché ricevano prove e segnalazioni di rinvenimenti di falsi di propri prodotti, evidenzianti più la propensione a far si che le notizie in questione e i propri nomi non trapelino il meno possibile attraverso i media, che quella di tentare di erigere qualche barriera più efficace – ma purtroppo per loro non priva di costi che scoraggi i contraffattori. Nelle stesse relazioni annue dei Nuclei Antiosofisticazione e Sanità dei Carabinieri è più facile leggere che “è stato scoperto un deposito un cui erano custoditi notevoli quantità di confezioni di olio dietetico contraffatto di una importante azienda nazionale” che incontrare la denominazionedel prodotto, oppure, è più facile trovare la notizia sull’ “Herald International Tribune”(22 Maggio 1992) che nel museo del falso di Salerno sono state esposte etichette con date contraffatte della “Nutella”, della Maionese Kraft”e del “Nesquik”, piuttosto che uno solo di questi nomi abbia modo di essere pubblicato sui molti dei quotidiani e periodici italiani, che pure hanno lodato il lavoro di ricerca svolto nella struttura di ricerca dell’Ateneo salernitano sulle tematiche della falsificazione del settore alimentare. Se poi i falsi riguardano i prodotti medicinali il silenzio è ancora più fitto e negare è quasi un obbligo per le imprese, a meno che non si parli di contesti geografici lontani da noi. Nel 1995 il Museo del Falso ha proposto un esposizione sulla contraffazione dei farmaci esponendo assieme a reperti verbali di sequestri effettuati dalle forze dell’ordine anche alcune lettere di risposta ad un questionario inviato alle aziende farmaceutiche italiane, circa le eventuali falsificazioni subite, nelle quali esse dichiaravano di non avere avuto questo tipo di problema, mentre nelle bacheche dell’Università le confezioni contraffatte dei loro prodotti e atti ufficiali delle forze dell’ordine le smentivano. In alcuni casi il grande impegno a impedire che siano di dominio pubblico i rinvenimenti dei falsi è connessa al timore che la notizia possa comportare l’abbandono traumatico e generalizzato dei consumatori dei prodotti caduti nel mirino dei contraffattori, con la conseguente scelta, da parte loro di orientare i propri acquisti su produzioni di aziende concorrenti, dimenticando il non irrilevante dato di fatto che gli operatori del falso, in genere, dirigono le loro attenzione su tutte le marche che hanno una certa presenza sul mercato, quindi, anche su quelli delle imprese le cui merci possono rappresentare delle teoriche alternative e di cui, prima o poi, verrà rinvenuto qualche esemplare contraffatto. In altri casi il black aut costituisce l’espediente per non dirottare risorse finanziarie, già programmate per altre finalità, in attività ed iniziativa di tutela dei prodotti di scoraggiamento dei falsari. In altre situazioni, ancora, la politica della negazione delle evidenze, della minimizzazione degli episodi, del silenzio derivano – specialmente per le aziende appartenenti a grandi gruppi o ad articolazioni di imprese multinazionali- -dalle logiche spietate del rapporto costi benefici.
Quali profitti potranno essere ricavati dalle spese impegnate per combattere le contraffazioni?
Se si tratta solo di uscite non c’è convenienza !
Lezioni Napoletane è un ciclo di conferenze promosso dalla Fondazione Feltrinelli, dalla Facoltà di Lettere e Filosofia della Federico II e da AustroeAquilone per discutere e mettere a fuoco la vasta serie di mutamenti che stanno avvenendo nella società, nella cultura, nell’economia alla fine di questo che si è soliti chiamare il secolo breve.
Ai diversi relatori chiediamo di scrutare i segni del tempo, di essere interpreti del cambiamento, dei rischi e delle opportunità ad esso connesso mentre, con la storia alle calcagna, siamo impegnati a riarredare le nostre stanze sconvolte dall’irrompere di nuovi linguaggi, fenomeni, processi, tecnologie.


Napoli, 30 Ottobre 1998
Sono molto felice del fatto che ci siano degli studenti, e delle studentesse, all’avvio di questo ciclo di conferenze che, con gli amici di Austro e Aquilone e della facoltà di Lettere e Filosofia, abbiamo voluto chiamare “Lezioni Napoletane”, anche se questo da un certo punto di vista rende per me ancora più difficile le cose. Insegnare – come diceva Freud – è una di quelle cose quasi impossibili. Egli riteneva che – non so se avesse ragione – ci fossero tre cose praticamente impossibili: comandare, insegnare e – questa è la cosa più onesta da parte sua – guarire.
In ogni caso quello che mi propongo stamattina è di esplorare con voi due ambiti di questioni: il primo è di natura politico istituzionale e si riferisce alle democrazie rappresentative pluralistiche; il secondo è di natura sociale.
Ciò che in particolare mi interessa presentare alla discussione sono i segni che intravedo dal mio punto di osservazione. Mi interessa saggiare innanzitutto alcune trasformazioni relative al primo ambito, cioè relative alle istituzioni, alle regole, alla natura delle nostre democrazie pluralistiche costituzionali. Mi interrogherò poi sulle trasformazioni che invece attengono non alle istituzioni politiche di una democrazia rappresentativa quanto piuttosto a quello che si usa chiamare il mutamento sociale.
Ho più volte sostenuto la tesi che in realtà le trasformazioni che hanno spicco, quelle che mettono in moto le altre, sono le seconde. La mia tesi, non particolarmente originale, è quindi che il cambiamento scientifico, il cambiamento culturale, il cambiamento tecnologico, il cambiamento economico latu sensu, siano determinanti in vari modi e influiscano sulle risposte che le istituzioni politiche danno al mutamento sociale.
La mia tesi è una tesi sulla priorità esplicativa della società nei confronti delle forme del suo essere politicamente istituzionale e istituzionalizzata. Le società in condizioni ordinarie non sono cambiate dalla politica ma cambiano per ragioni scientifiche, tecnologiche, economiche, culturali e religiose, per cui la politica risulta essere solo un sotto insieme in questo paesaggio in cambiamento e diverse possono essere le risposte che essa può dare al cambiamento sociale.
Ci interrogheremo quindi sulle trasformazioni delle istituzioni politiche e sui più rilevanti cambiamenti nell’ambito del paesaggio sociale in cui noi viviamo, nella parte ricca del mondo, con l’idea che il cambiamento del paesaggio sociale sia quello che occorre per spiegarsi il cambiamento delle istituzioni politiche e segnatamente della democrazia rappresentativa.
Nella seconda parte della mia esposizione mi chiederò se siano sensati quei tipi di cambiamenti su cui richiamerò l’attenzione, quale natura abbia o debba avere una teoria della democrazia che sia capace di essere coerente con il mutamento delle istituzioni politiche e con il mutamento sociale che lo induce.
La seconda parte, quindi, non ha a che vedere con delle cose ma con delle teorie su certe cose; ha a che vedere con un punto centrale nella discussione contemporanea delle migliori teorie della democrazia, la teoria dello spazio pubblico democratico.
Mi chiederò perché la migliore teoria della democrazia, la miglior filosofia politica della democrazia di fine secolo mostri qualche deficit a proposito della interpretazione e della prescrizione della natura dello spazio pubblico democratico, e cercherò di far vedere in conclusione quali potrebbero essere dei modi per uscire dalle difficoltà fin de siècle.
La prima parte del mio ragionamento la possiamo intitolare L’ascia del nonno o Il quadro dello zio Piero.
Devo dire per onestà intellettuale che mutuo queste espressioni da una conversazione che ho avuto con Alessandro Pizzorno, uno dei pochi scienziati sociali italiani che stimo profondamente, il quale ha tenuto proprio qui all’università di Napoli una Vico lecture sulla trasformazione dei sistemi democratici rappresentativi.
Immaginate che in una casa ci sia una stanza e in questa un punto identitario, uno di quei feticci che non mancano neppure nelle bidonvilles: un quadretto, una fotografia, un CD particolare: nel nostro caso avremo l’ascia del nonno. Immaginate che con grande soddisfazione un membro della famiglia faccia vedere ad un ospite l’ascia del nonno, esclamando: “Guarda che meraviglia l’ascia del nonno!. È una cosa ereditata a cui teniamo moltissimo. Papà le ha cambiato il manico e io le ho cambiato la lama che non andava più”. Ora provate a sostituire all’ascia del nonno la democrazia rappresentativa: esaminate una serie di punti distinti e chiedetevi se non sia accaduto o se non si possa dire che stia accadendo alla democrazia il destino dell’ascia del nonno.
I tipi di cambiamento che mi interessa sottolineare, seppure distinti fra loro, non sono indipendenti; si potrebbe pertanto tentare di vedere che cosa tiene assieme cambiamenti che a prima vista sembrerebbero una lista della spesa. Rinuncerò per ora a tale tentativo perché renderebbe troppo analitica questa parte e lo riprenderò nell’ultima parte, quella che sarà più sadica da parte mia nei vostri confronti, quella cioè di tipo teorico.
Mi pare utile precisare che le mie tesi non si riferiscono meramente alla democrazia rappresentativa o alla democrazia costituzionale italiana, bensì alle democrazie rappresentative in generale, perché molti fenomeni che riteniamo essere solo nostri, interessano, ovviamente con specificità diverse (quelle che i tedeschi chiamano sonderweg), molti altri paesi.
Considerate, ad esempio, l’aumento costante nell’ambito di sistemi democratici della funzione, del ruolo e dell’istituzione di autorità non elette: authorities per la concorrenza, per la competizione, per la tutela della privacy, per le comunicazioni. Pensate a quanto stanno proliferando forme di autorità che hanno la caratteristica, in un quadro di una teoria della democrazia rappresentativa e nella pratica della stessa, di non rispondere a una qualche forma di consenso espresso da una constituency. A chi rispondono?
Sappiamo a chi rispondono quelli che sono eletti. Sappiamo qual era l’ascia del nonno prima che cambiassero manica e lama. Sappiamo che è proprio di una procedura democratica e di un funzionamento di un regime democratico il fatto che non puoi disporre di autorità se non sei autorizzato dal consenso di coloro che ti preferiscono ad altri.
Che ciò sia stata una grande conquista è indubbio, eppure oggi le democrazie mature vedono aumentare istituti d’autorità che non hanno la loro legittimazione entro quello che era il DNA dell’ascia del nonno, prima che si cambiassero manico e lama.
Io non sostengo – lo dico per evitare fraintendimenti di cui sarei colpevole – delle tesi valutative, non sto dicendo che è bene o male che vi siano authorities indipendenti, mi sto però ponendo il problema e lo pongo a voi.
L’aumento dei poteri non democraticamente legittimati proprio di democrazie basate sulla legittimazione via consenso dell’uso di autorità è un primo fatto.
Considerate ora un secondo fatto che è abbastanza diffuso e che ha ancora una volta ragioni differenti in diversi paesi: l’aumento, nell’ambito delle democrazie rappresentative, del ricorso alla risorsa del diritto in sede individuale o in sede collettiva, l’aumento quindi del potere delle corti.
E’ un problema non solamente italiano e non riducibile a tangentopoli: sono fenomeni questi che sappiamo essere in trend crescente nell’ambito di molte democrazie rappresentative.
Il ricorso al potere giudiziario aumenta sempre di più. Vi sono varie ipotesi per spiegarlo. Si tratta comunque di un cambiamento interessante a cui si aggiunge l’aumento del ruolo di organi che hanno giurisdizione non solo a livello della legislazione ordinaria ma anche a livello del controllo di costituzionalità.
Anche le vicende della tensione tra corti costituzionali, consigli costituzionali, corti supreme e legislazione ordinaria non riguardano solo l’Italia ma tutte le democrazie fin de siècle.
Considerate poi il rapporto in termini di efficacia, di influenza e di potere tra chi ha risorse politiche di influenza e chi ha risorse economiche di influenza.
Appare sempre più evidente la relativa debolezza delle risorse di autorità politica nei confronti dei potenti operanti sui mercati che tra l’altro non operano sistematicamente nello stesso spazio dei primi ( in genere uno spazio nazionale dotato di confini).
Anche in questo caso si ripete la storia dell’ascia del nonno, in quanto una serie di effetti e di decisioni non politiche finisce per superare o premere su una serie di effetti, di scelte e decisioni pubbliche o politiche. Abbiamo quindi una asimmetria, una ineguaglianza in termini di poteri di influenza, tra chi detiene risorse economiche e chi detiene risorse di autorità politica legittima.
Considerate infine che in quasi tutte le democrazie rappresentative mature quegli attori politici collettivi che usiamo chiamare partiti politici vedono indebolire alcune delle loro funzioni originarie. Su questo aspetto tornerò nell’ultima parte, perché mi interessa anche dal punto di vista teorico, ma non c’è dubbio che in generale nelle democrazie rappresentative mature i partiti politici intesi come agenzie, stabili nella durata, di definizione, tutela, promozione o sanzione di interessi, aspettative o ideali nella società, abbiano quasi completamente perso due delle tre funzioni che sono state all’origine della nascita delle democrazie rappresentative a suffragio universale, soprattutto nell’Europa continentale, e mantengano solo la funzione di selezione del personale candidato al governo, ai livelli locali, nazionali o transnazionali.
Le due funzioni che sembrano aver perso sono la funzione della distinzione programmatica e la funzione della produzione di beni di identità.
Come nascono infatti i partiti stabili nel tempo (non i partiti come coalizioni elettorali che eppure ne costituiscono in parte l’origine)? Nascono con la funzione di costruire comunità solidali attraverso l’erogazione di beni di appartenenza o di identità: questi sono i miei e i miei non possono che proporre questo o tentare di fare questo qualora siano al governo è un espressione che ben riassume una delle grandi funzioni identitarie: la generazione di identità tramite la differenziazione programmatica.
La funzione che meglio si conserva è la terza cioè quella di selezione di personale al governo o all’opposizione, mentre risultano indebolite quella della distinzione programmatica e quella della funzione di offerta di comunità solidali. Questa profonda trasformazione in qualche modo si può legare ad alcune di quelle trasformazioni a cui ho fatto prima riferimento.
L’ipotesi emersa dal tentativo di saggiare trasformazioni dal punto di vista delle istituzioni, dei processi e delle regole democratiche, ovvero dal tentativo di trovare quelle che Kant chiamava i signa prognostica, cioè quei sintomi che ci dicono dove stiano andando le cose, potrebbe avere una prima conclusione provvisoria: si stia indebolendo la capacità della politica democratica di modellare e di determinare esiti collettivi.
Detto in altri termini, si sta indebolendo la capacità di attuare programmi o promesse di politiche capaci di influire sui destini collettivi o individuali delle persone. E tale indebolimento appare ancor più evidente se pensiamo la politica come qualcosa che si muove entro i confini dello stato nazione.
Quella che io chiamo la crescente percezione dei limiti della politica, ovvero dei limiti di ciò che si può fare con la politica, vale a fortiori; consideriamo dunque i limiti di ciò che politicamente si può fare entro i confini di unità nazionale.
Le trasformazioni che attengono al nostro paesaggio sociale sono cose che ci riguardano da vicino. Il problema della natura della comunicazione pubblica – il problema della stampa, il problema della televisione – è uno dei problemi che sta sullo sfondo di tutta questa faccenda. Naturalmente il mutamento del paesaggio sociale è di vario tipo e ognuno può stare in diversi punti del paesaggio sociale che muta ed esserne avvantaggiato o svantaggiato, ma in ogni caso il paesaggio sociale è qualcosa che riguarda le cose più vicine a noi.
Questo secondo punto mi piacerebbe chiamarlo – me lo suggerisce una inchiesta sui giovani che ho visto su Le Monde di domenica scorsa – telefonini e tatuaggi.
Perché passare dall’ascia del nonno a telefonini e tatuaggi? Perché ciò che cambia i nostri paesaggi sociali è qualcosa che in condizioni ceteris paribus non dipende dalla politica, ma dipende, ad esempio, dalle tecnologie.
Chi aveva progettato un tale cambiamento? Nessuno. Una delle mie tesi centrali è che le società cambino sotto la pressione di volte di incertezza generate da mutamenti tecnicamente esogeni rispetto alla politica come, ad esempio, le migrazioni.
Il tema delle migrazioni sarà il tema dei prossimi anni in Italia, e in parte lo è già. Possiamo discutere politicamente, eticamente, religiosamente le migrazioni ma non evitare che esse avvengano. Nuove culture, attraverso le migrazioni, cambieranno il paesaggio sociale, cambieranno in qualche modo le nostre stesse vite. C’è chi non ne sarà toccato e chi ne sarà messo invece in ginocchio.
Ma torniamo all’articolo su Le Monde che diceva che un tempo una telefonata esordiva con un: Come stai?, ora, grazie al cellulare, esordisce con un: Dove stai?.
Si possono fare tanti esempi. Potete immaginare un mondo in cui non ci sia una televisione a colori e non si possa fare zapping? Voi no. Io, che sono un vecchio signore, si. Che cosa ha prodotto la televisione? ci si chiede più volte. In genere produce un bel po’ di cose tra cui le idiozie dei filosofi che parlano della televisione. Bourdieu che è uno dei più grandi sociologi viventi, le uniche cose stupide le ha scritte sulla televisione, e non so perché Sartori, che è un buon politologo, abbia scritto un libro che è di una totale banalità sul problema della televisione. Personalmente cerco di non parlarne mai forse per tutelarmi rispetto all’idiozia.
Questo accade perché gli uomini sono animali che leggono i cambiamenti con gli occhiali del passato e ciò rende conto del fatto che se uno ha un passato più lungo il costo della conversione è maggiore. Allora l’esempio del come stai e del dove sei è un esempio adatto a suggerirci che in qualche modo il cambiamento sociale è l’effetto non atteso nel suo insieme o non intenzionale di cambiamenti tecnologici.
Internet è un altro fatto che cambia sicuramente il paesaggio sociale. Ma che cosa suggerisce la faccenda delle stupidaggini degli intellettuali sulla televisione? Suggerisce che il cambiamento del paesaggio sociale generato dalle innovazioni tecnologiche, o dalle migrazioni, è un cambiamento che altera la distribuzione di costi e benefici che a un tempo dato è presente in quel paesaggio sociale. E in genere il cambiamento lascia sul tappeto perdenti sociali, che non erano necessariamente tali prima del cambiamento, e vincenti sociali.
Ogni mutamento di tipo scientifico, tecnologico, culturale o religioso ridistribuisce biglietti positivi e negativi a chi partecipa al gioco sociale. Quando la borsa dei valori, dei vantaggi e degli svantaggi sociali, viene sistematicamente alterata, qualcuno viene buttato fuori, qualcuno guadagna moltissimo e qualcun altro resta al palo. Per questo è importante osservare con attenzione i “signa prognostica” di Kant, i sintomi di ciò che cambia nelle nostre vite e che non dipende da trasformazioni politiche.
Sia chiaro che la mia non è una tesi antipolitica, ma una tesi sui limiti della politica in base alla quale le istituzioni, le scelte collettive sono le risposte – che come tali possono essere buone o cattive, migliori o peggiori – agli effetti generati da mutamenti che esse non producono, generati cioè da mutamenti sociali, economici o culturali.
Detto in poche parole, non credo che la politica possa o debba avere in mente che la società deve cambiare. La responsabilità di una politica democratica è piuttosto quella di minimizzare i costi del mutamento sociale perché la virtù di una società che cambia non si converta nel vizio e nell’inaccettabile condanna di alcuni o di molti ad essere nella parte svantaggiata o esclusa.
Questo è il punto su cui si finisce abbastanza ineluttabilmente per riflettere se tentiamo di collegare i mutamenti delle istituzioni politiche nelle democrazie rappresentative ai mutamenti sociali. E qui ritorna il tema dei tatuaggi! Non accade mai nulla di completamente nuovo nel mondo. Nessuna svolta è epocale.
Benjamin Constant diceva: “Non è una transizione particolare. Siamo sempre in transizione”. I telefonini riguardano ancora gli interessi delle persone. Sappiamo infatti che i cambiamenti tecnologici ridistribuiscono premi o sanzioni sulle persone, premiando o sanzionando i loro interessi, generando utilità o disutilità collettiva.
Il tema dei tatuaggi ha invece a che vedere con un altro aspetto del mutamento sociale che non riguarda gli interessi delle persone. I tatuaggi hanno infatti a che vedere non con gli interessi ma con quella strana cosa che è l’identità, cioè con le risposte alle domande su chi noi siamo. Anche questo non ha niente di epocale. Infatti le generazioni che entrano nella società hanno sempre avuto strategie diverse per definire la propria identità, e in genere le identità giovanili si definiscono per un linguaggio di contrasto rispetto ad altre identità: la mamma, il papà, e via discorrendo. Non c’è bisogno di Edipo e Giocasta! Tutto ciò è tipico.
Abbiamo conosciuto fasi in cui uno dei modi con cui ci si riconosceva identitariamente ne “i nostri” era attraverso strategie, per esempio, vestimentarie. Negli anno ’60, per esempio, i figli dei fiori indossavano i jeans e portavano i capelli lunghi. Quello che è interessante è che prima per dare segni distintivi si usavano cose che riguardavano il corpo mentre adesso si usa direttamente il proprio corpo.
Concludo questa parte su telefonini e tatuaggi cercando di chiarire quali siano i due effetti principali di un mutamento del paesaggio sociale.
Uno è quello a cui accennavo prima: la redistribuzione di costi e benefici.
Pensate al caso in cui voi siate esclusi permanentemente da prospettive di lavoro per il fatto che abilità che avete ottenuto non sono più abilità riconosciute socialmente utili. Da cosa dipenderebbe una tale esclusione? Dipenderebbe da mutamenti tecnologici o economici che chiedano e che premino altre capacità e altre competenze. E allora bisognerà mettere al centro delle nostre riflessioni il come educare persone che sono esposte alla lotteria delle competenze. Il tema dell’educazione è uno dei grandi temi europei ma è un tema che in ogni caso riguarda gli interessi delle persone.
Ma il mutamento sociale genera anche un altro effetto: mette sotto pressione le risposte e le domande su chi noi siamo, cioè sottopone a pressione la certezza dei riconoscimenti.
Qui non si tratta di interessi. Per poter dire i miei interessi devo sapere chi sono. Io ho interessi in quanto sono io che li valuto e li comunico ad altri. Ma se va sotto pressione la mia capacità di rispondere al mio nome è come se avessi una crisi sul fatto di riconoscermi. Questo fa sì che non ci sia più un problema relativo agli interessi ma un problema relativo alla identità. E allora in tal caso è meglio tatuarsi perché così so di riconoscermi con gli altri e di fare parte di una determinata tribù.
Credo pertanto che una delle caratteristiche del mutamento della mappa sociale sia la progressiva segmentazione delle nostre società, la progressiva ridefinizione delle cerchie che includono alcuni escludendone altri. E’ un processo di tribalizzazione che rende molto più difficile, all’interno di comunità politiche nazionali, il senso dell’espressione Noi in quanto concittadini o concittadine, in quanto parte della stessa comunità politica.
La tribalizzazione erode così il vincolo di cittadinanza. Ed in effetti le identità nazionali e collettive di cittadinanza sono sotto pressione in molte società mature.
La redistribuzione di costi e benefici da un lato e la definizione di identità entro cerchie distinte (attraverso per esempio i tatuaggi) dall’altro fanno sì che in tutto possiamo riconoscerci eccetto che nella sorte condivisa dell’essere cittadini o cittadine della repubblica.
Ancora una volta non mi sto impegnando dal punto di vista normativo, cioè su come dovrebbero essere le cose, ma sto cercando di capire in quale paesaggio ci poniamo le nostre domande. Quest’ultimo punto è il punto che rende terribilmente difficile pensare da un lato ad una politica democratica virtuosa, in un paesaggio sociale che tende a tribalizzarsi piuttosto che a sostenere solide e durature identità, che abbia capacità di generare effetti sulla società (è il tema dei limiti della politica).
A questo punto, se teniamo presente questo tipo di possibile mappa dei mutamenti, possiamo mettere alla prova le migliori teorie della democrazia, la migliore filosofia politica contemporanea della democrazia, facendo però una premessa che mi servirà per la conclusione.
Ci sono tre livelli da considerare: uno è quello a cui ho accennato ricorrentemente nella prima parte della mia relazione: è il livello delle comunità politiche coincidenti con gli stati nazioni; un altro è il livello transnazionale (a cui è legata la questione del progetto o del processo dell’unione europea); l’ultimo è il livello subnazionale che chiameremo per convenzione livello locale (in tal caso locale può significare regionale, territoriale o metropolitano). In corrispondenza con questi tre livelli possiamo pensare la politica come risposta al mutamento sociale transnazionale, nazionale o subnazionale.
Se questi sono i fatti, quale sarà il loro rapporto con la teoria? Considererò per cenni due tra quelle che ritengo tra le migliori esemplificazioni di filosofia politica, fra le più importanti e le più coerenti nell’ambito della teoria democratica: le tesi sul liberalismo politico di John Rawls e le tesi sulla democrazia deliberativa di Jurgen Habermas.
Prendiamo in considerazione una nozione che è centrale in entrambe queste teorie: la nozione dello spazio pubblico democratico.
La tesi di Rawls è quella sul libero impiego della idea di ragione pubblica che ciascun cittadino, ciascun partner della comunità politico – democratica, deve potere adottare per mettersi alla prova con altri sulle questioni pubbliche.
Pericle, nella celebre orazione funebre, diceva qualcosa di simile: Ciascuno di noi ha la stessa capacità di ciascun altro di giudicare la politica. Questa è l’uguaglianza democratica: l’uguaglianza nella capacità del giudizio sulle politiche. E, aggiungeva Pericle, noi non riteniamo la discussione un ostacolo alla deliberazione politica saggia.
L’idea centrale di Rawls è dunque quella di azione pubblica. L’idea di Habermas è quella di democrazia deliberativa, cioè della uguale opportunità per chiunque di partecipare ad una conversazione su interessi, ideali, principi o bisogni, sotto la condizione naturalmente che la situazione per ciascun partecipante sia equa o sia eguale e che questa discussione non sia distorta da risorse negoziali o di minaccia o di potere.
Queste sono le due idee: democrazia deliberativa e liberalismo politico. Potremmo dire che da questo punto di vista lo spazio pubblico è il luogo in cui in una democrazia si mettono alla prova, si confrontano tra loro, prospettive alternative sull’interesse collettivo di lungo termine, sulla giustizia, sull’equità, sui diritti, su qualsiasi cosa possa essere oggetto della controversia democratica (laddove per la democrazia la controversia, il conflitto, la messa alla prova delle ragioni costituiscono una virtù preziosa).
Naturalmente potremmo pensare che, nell’ambito dello spazio pubblico, differenti possano essere i criteri del giudizio politico, per cui il problema rilevante diventa come sia possibile che questo conflitto tra criteri di giudizio politico si converta in discussione, scambio tra argomenti, traffico di ragioni, in modo tale da rendere lo spazio pubblico democratico più vicino all’ideale della eguaglianza di opportunità per ciascuno di avanzare la propria interpretazione dell’interesse collettivo e affinché tale confronto generi la deliberazione.
Questo è il cammino virtuoso che queste teorie configurano. L’idea è che la razionalità pubblica o deliberativa sia una risorsa grazie alla quale società caratterizzate dal pluralismo delle lealtà, dal pluralismo delle versioni del mondo, dal pluralismo degli attaccamenti, dal pluralismo dei nostri impegni etici, religiosi, culturali, possano essere società democratiche apprezzabili, ben ordinate e stabili nella durata.
Ci si può chiedere però cosa succede se qualcuno che fa parte del club del pluralismo non è interessato o non è disponibile o defeziona dall’impiego della razionalità pubblica o non sta alle regole conversazionali, cioè vuole parlare con gli altri ma non accetta che per parlare democraticamente si debbano seguire certe regole. L’idea di Habermas è infatti una specie di catalogo delle buone maniere per conversare, che riguarda l’area della opinione pubblica. Ma qui abbiamo un impasse.
Rawls sostiene che la possibilità di adottare ragioni pubbliche sia quella che può generare, anzi, che deve generare, tra i cittadini di una democrazia pluralistica, il cosiddetto “consenso per intersezione”. Mentre per Habermas noi dobbiamo condividere principi e procedure per vagliare i nostri differenti argomenti a favore o contro qualcosa, per Rawls noi divergendo su tante cose dobbiamo pur poter condividere un grappolo di valori politici fondamentali.
Ritorna qui un punto che ho sostenuto anche in Dell’incertezza: il modello canonico, lo spazio pubblico democratico che troviamo nelle importanti teorie di Rawls e di Habermas si basa sull’idea che sia possibile risolvere la questione del pluralismo e la questione del conflitto trasformandoli in cooperazione nella conversazione nella polis e che ciò che operi la trasformazione della guerra dei criteri di giudizio in conversazione pubblica sia la risorsa della nostra razionalità o della nostra ragionevolezza, perché è questa che consente, preannuncia e promette la possibilità della nostra convergenza al di là, nonostante, e in virtù, delle differenze che ci separano e che ci dividono.
La mia idea è che questo modello canonico sia prezioso, ci suggerisca cose importanti e tuttavia sia intrinsecamente e gravemente incompleto, e tenterò di dimostrare perché.
Vi propongo perciò un piccolo esercizio di archeologia del moderno, un piccolo esercizio genealogico che può essere utile per capire che cosa non funziona nel modello canonico dello spazio pubblico offertoci da queste importanti teorie.
Dov’è l’origine di queste teorie? É nell’arcaico modello dello spazio pubblico liberale, intendendo qui il termine liberale nel suo senso storico. Pensate a una società liberale in cui hanno competenza politica soltanto frazioni ristrette di popolazione, i cittadini ritenuti autonomi. Se si vuole un esempio canonico del modello dello spazio pubblico liberale si può considerare la celebre risposta di Kant alla domanda Che cos’è l’Illuminismo?. Tutti sanno più o meno che la sua risposta fu: Pensa con la tua testa!.
Ciò che trovo interessante nella risposta sull’Aufklarung è che Kant distingue due tipi di uso che noi possiamo fare della ragione: l’uso pubblico e l’uso privato. Ma cosa ha in mente Kant per uso privato della ragione? Lui fa tre esempi di uso privato della ragione: l’esempio del sacerdote di una chiesa, del contribuente e del militare. Se un superiore dà un ordine a un militare, il militare, se usa privatamente la ragione, deve ubbidire. Il contribuente deve pagare le tasse dal punto di vista privato del suo uso della ragione. Il prete può non essere d’accordo con l’ultima enciclica ma deve, se insegna in quella Chiesa, usare i criteri che sono lì definiti.
Cosa vuol dire ciò? Che l’uso privato della ragione riguarda le ragioni che noi abbiamo in quanto ci riconosciamo in una cerchia data della società, in un ruolo sociale (per esempio il prete in quanto è uno che fa parte di quella Chiesa, il contribuente in quanto è uno che fa parte della cerchia di cittadinanza, il militare in quanto è uno che appartiene a una certa organizzazione). L’uso privato della ragione è quindi l’uso di ragioni che noi accettiamo e proponiamo ad altri in quanto siamo definiti o ci definiamo entro una certa comunità identificante.
In che cosa consiste allora l’uso pubblico? Abbiamo un uso pubblico nel caso in cui, per esempio, il contribuente può uscire dalla sua cerchia in cui deve condividere quei criteri e comunicare ad altri le ragioni della sua critica allo schema di imposizione fiscale; il prete può uscire dal riferimento alla sua cerchia e può comunicare ai teologi o e al pubblico il suo dissenso; il militare ubbidisce ma può, in una cerchia alternativa, comunicare al pubblico le ragioni della sua critica.
L’uso pubblico che ha in mente Kant è quello che presuppone che in una società vi sia la possibilità di costituire cerchie di riconoscimento alternative a quelle date. Ma perché ciò avvenga quali sono le condizioni che devono essere soddisfatte?
Se la ragione è una risorsa e gli attori nello spazio pubblico liberale sono disposti a esporre alla discussione argomenti relativi ai loro interessi è perché tutti fanno parte dello stesso club, della stessa cerchia alternativa a quelle date e, soprattutto, perché nel fare ciò si riconoscono come pari. Vi è qui l’idea di una cerchia degli eguali. Che cosa in particolare caratterizza questa cerchia? La razionalità della discussione è garantita perché gli interessi in gioco possono essere valutati da individui la cui identità è immunizzata rispetto alla incertezza e stabile nel tempo grazie a risorse sociali, siano esse culturali o morali, ma in ogni caso non politiche.
Affinché, quindi, il modello dello spazio pubblico liberale funzioni occorre che individui che si misurano nello spazio pubblico dispongano di un principio di assicurazione sulla loro identità che renda razionale confrontare gli interessi. Ma cosa dà loro identità? La proprietà.
La proprietà privata è un modo di dare identità alle persone. Tutto ciò non è sorprendente e lo si ritrova in grandi pensatori liberali come Kant o come Constant, liberali nel senso storico del termine, che erano molto coerenti nel dire che non tutti potevano essere cittadini. La cerchia di cittadinanza era esclusiva, non era includente. Perché? Perché non si poteva pensare che valutassero attraverso criteri di giudizio politico coloro la cui identità era debole e intermittente; quindi questi erano esclusi mentre coloro che facevano parte del club, dell’area della eguaglianza liberale, avendo identità non politicamente ottenuta, potevano valutare la politica e l’ideale della opinione pubblica come l’arena in cui si valutano la politiche indipendentemente dal potere che la politica ha di fissarti l’agenda.
E’ esattamente questa concezione liberale, che è alla base delle teorie dello spazio pubblico democratico, che non funziona più in esse. Perché, quindi, l’ideale della cerchia della discussione dello spazio pubblico liberale resti un ideale, qualcosa a cui valga la pena tendere, bisogna che chiariamo la natura del cambiamento dello spazio pubblico democratico quando passiamo dalla versione liberale a quella democratica.
Nel fare ciò mi riferirò a due tipi di conflitto: il conflitto di interessi, il conflitto in cui chi ha interessi confligge con altri che hanno interessi alternativi o antagonistici ed il conflitto identitario ovvero il conflitto per essere riconosciuti in certi modi.
Quello su cui bisognerebbe riflettere è il fatto che il modello del conflitto per il riconoscimento non è un frutto maturo delle democrazie pluralistiche ma qualcosa che marca fin dalle origini la natura delle democrazie pluralistiche e la conversione degli stati liberali in comunità politiche democratiche.
I conflitti sociali per l’inclusione di ampie sezioni di popolazione escluse dalla cerchia dei diritti di cittadinanza non sono infatti conflitti che rispondono al modello del conflitto distributivo ma sono conflitti per il riconoscimento. In questo tipo di conflitti non si negozia perché la posta in gioco è la possibilità di negoziare e per poter negoziare bisogna essere riconosciuti.
Qui non abbiamo tanto le ragioni della democrazia quanto le passioni identitarie democratiche. Le passioni di chi confligge con altri nell’azione collettiva per il riconoscimento non sono irrazionali – come potrebbe sostenere un teorico osservatore – ma sostengono quelle che diventeranno le ragioni nello spazio pubblico trasformato in virtù dell’inclusione di chi prima era escluso.
Ora quello che mi interessa sottolineare è che il mutamento democratico e il suo spazio pubblico sono questioni che concernono le identità di individui e collettività e non solo i loro interessi. Si potrebbe dire allora che la libertà democratica per eccellenza è la libertà di identificazione collettiva alternativa a quella data.
Questa è la storia delle democrazie, specialmente in Europa continentale. Posso ricordare a proposito la legislazione antisocialista di Bismark. Non si poteva, per una lunga fase delle democrazie non pluralistiche, al tempo stesso avere lealtà nei confronti della comunità politica e avere lealtà di parte. Ciò che era incompatibile mutuamente era la doppia identificazione, e la mia tesi è che le democrazie pluralistiche sono nate esattamente quando è stata conquistata questa libertà che sembra così elusiva, la libertà della identificazioni mutuamente compatibili in comunità alternative.
Si potrebbe aggiungere, con una formulazione ironicamente e blandamente infedele dello slogan di Popper, che una società aperta è una società che promette ampie o maggiori probabilità di costituzione e ricostituzione di identità collettive nel tempo. Ma come pensare le condizioni di possibilità di un processo aperto e continuo di negoziato tra identità proprio dello spazio pubblico democratico trasformato senza che la Babele delle differenze sullo sfondo della segmentazione, della tribalizzazione e del decentramento del paesaggio sociale si trasformi a sua volta nel bellum omnium contra omnes?
Vi suggerisco solo un abbozzo di argomento a proposito di questo difficile problema, un abbozzo che ha più dello stile eracliteo che parmenideo, in cui la tensione tra interessi e identità, tra ragioni e passioni, resta aperta.
La passione identitaria è responsabile, dal punto di vista delle nostre motivazioni, del nostro prender parte ad una azione collettiva o del nostro prendere la parola nello spazio pubblico democratico. Hume diceva: “Le ragioni non motivano. Le motivazioni motivano”. Le ragioni sono ragioni esterne e solo se si convertono in motivazioni motivano. Motivare significa fare sì che le persone facciano cose e trovino ragioni per farle. E noi troviamo ragioni per fare cose se abbiamo motivazioni per fare cose. Devono darsi motivazioni perché valga la pena di usare ragioni. E in tutti quei casi in cui abbiamo fenomeni di apatia o di silenzio o di defezione rispetto allo spazio pubblico nelle nostre società occorre chiedersi se per caso questo non dipenda dal fatto che gli individui credano che non valga la pena di partecipare all’azione politica collettiva di presentazione di interessi e di pagarne i costi.
Questo è un problema che riguarda tanto la rappresentanza politica quanto la rappresentanza sociale degli interessi, e perciò riguarda anche i sindacati. Nelle società affini alla nostra vi sono casi così severi di esclusione che diventa prevalente la convinzione che non valga la pena partecipare ad una azione politica collettiva, ed è per questo che possiamo osservare conflitti che non hanno più come posta in gioco l’inclusione in una qualche cerchia ma l’uscita, insomma conflitti di divorzio e non per negoziato.
E allora le passioni del prendere parte, di cui ho cercato l’origine, nell’esercizio archeologico democratico, nelle antiche matrici delle democrazie rappresentative pluralistiche, sono la risorsa essenziale per l’apprendimento delle maniere della partecipazione alla discussione pubblica e al confronto tra criteri alternativi di giudizio politico.
Due, allora, in conclusione, potrebbero essere i fini di una politica democratica degna di lode, sullo sfondo di alcune trasformazioni dell’ascia del nonno.
Il primo dovrebbe essere quello di modellare istituzioni che funzionino come arbitraggio dei discorsi dei partecipanti sociali, cioè vale a dire istituzioni con funzioni di arbitraggio audita utraque parte, secondo la concezione del liberalismo del conflitto. Il fatto che le parti siano udite non esclude la deliberazione ma la presuppone.
Il secondo fine riguarda la giustizia distributiva, cioè l’equità: ridurre per quanto è possibile ineguaglianze e svantaggi in termini di opportunità che per chi è nel cono d’ombra della società rendono farisaica o – peggio ancora! – incomprensibile la promessa democratica che ciascuno possa essere un partner nello spazio pubblico.
Trovo più tragico il fatto per cui la promessa che ciascuno dovrebbe avere pari opportunità di partecipare allo spazio pubblico sia incomprensibile. Non si vede che senso ha tutto ciò. Questa inadempienza può considerarsi la radice di forme di estraniazione politica o di ritiro della fiducia nella possibilità di essere insieme in qualche modo nella polis.
Ora, naturalmente, questo secondo fine non può essere pensato, a differenza del primo, nel quadro delle politiche a livello nazionale.
Se abbiamo intenzione di ridisegnare un welfare lo dobbiamo pensare solo come europeo, non ha alcun senso pensarlo nell’ambito degli stati nazionali perché in tal caso genereremmo le guerre come è successo e succederà sulle politiche fiscali. Allora l’idea di un welfare europeo è una idea che è legata al secondo fine di una politica democratica, quello di rendere comprensibile la promessa che ciascuno possa autonomamente prendere la parola e che il fare ciò abbia qualche senso nello spazio che condivide con altri nel suo destino collettivo.
Si potrebbe ironicamente sostenere in conclusione che la mia tesi è una tesi che più che basarsi su ragioni irresistibili si basi sulla passione identitaria di uno che fa filosofia politica. Io non ho nessuna difficoltà a riconoscere che potrebbe essere così e non vedo perché uno non dovrebbe avere passione per la ragione. In questa mia passione filosofica vi è una vecchia idea, il sogno di una cosa: l’ideale di un modo di vivere insieme che veda coesistere la ragionevole diversità e quindi il confronto fra le nostre prospettive. Ma perché ciò sia possibile occorre minimizzare socialmente quello che socialmente si può minimizzare, cioè la sofferenza delle persone.

| Napoli, 29 Gennaio 1999 Buongiorno a tutti, quando mi è stato chiesto di venire questa mattina a parlare qui con voi, ho pensato soprattutto alle cose da dire ai più giovani. Confesso che mi è difficile immaginarmi nei panni di chi è intento a “scrutare i segni del tempo” ma ho trovato interessante, stimolante, la richiesta che mi è stata avanzata. E poiché non è facile per me dirvi quale sarà il futuro che ci aspetta, cercherò di dirvi quale vorrei che fosse il futuro per molti di noi. Nell’immaginario collettivo di tante persone, soprattutto dei più giovani, il futuro è spesso descritto come una sorta di antro buio della convivenza tra le persone, basta pensare all’immagine che ci viene data da tante forme di rappresentazione culturale, dal cinema alla letteratura, ai fumetti. Per chi come voi immagino abbia un rapporto con queste cose, per chi ha delle passioni, degli interessi di questo tipo, non è difficile riandare ad immagini note, a parole scritte e apprezzate tante volte. La produzione letteraria affida addirittura ad un genere come la fantascienza la descrizione delle vicende future e straordinari scrittori, da Bradbury ad Asimov a Phil Dick si sono lungamente esercitati, sconfinando per fortuna dai limiti del genere, per descrivere mondi carichi di angoscia, di preoccupazioni, di nevrosi . E le stesse immagini, quelle ad esempio create da disegnatori straordinari come Jean Giraud, che conoscerete come Moebius, o come Corben, descrivono spesso un futuro che ha i tratti a cui mi sono appena riferito. Venendo qui andavo con la memoria ad alcune scene di un film che ha segnato una parte dell’esperienza della mia generazione, 2001 Odissea nello Spazio, con questa astronave che viaggia verso il buio sulle note allegre di un valzer di Strauss, “Danubio Blu”. E credo che molti di voi ricorderanno l’inizio di un altro film importante per la mia generazione, “Blade Runner”, ambientato in una San Francisco di un’epoca “lontana” dallo scrittore del libro da cui il film è tratto, Phil Dick. Il libro ha per me un titolo di grandissimo fascino “Gli androidi possono sognare le pecore elettriche” e la San Francisco del 1992 (che nel film diventerà la Los Angeles del 2019) è una S. Francisco in cui Dick scrive che i granelli di polvere radioattiva sono così tanti e talmente grigi da oscurare il sole. Siamo davvero condannati ad un futuro così? E’ davvero inevitabile un futuro carico di tanti elementi potenzialmente negativi? Io penso di no. Penso che le persone che oggi hanno ruoli di responsabilità debbano lavorare perché soprattutto le generazioni più giovani abbiano un futuro nel quale il sole sia visibile. E il sole, per le generazioni future, sono gli elementi di certezza, la possibilità di realizzare sè stessi come persone. Per fare questo, credo sia necessario dare risposte positive a tre questioni prioritarie: la prima, la più delicata nella società attuale, è quella relativo al sapere, anzi, come è più corretto dire, ai saperi; la seconda è quella relativa al lavoro, ai lavori; la terza è rappresentata dai diritti, quelli universali, quelli di cittadinanza, quelli connessi con le attività lavorative comunque definite e dovunque espletate. Perchè il sapere, i saperi? Perché il sapere, i saperi, la ricerca, in qualunque campo espletata, sono fondamentali per l’evoluzione di una società. Perchè il tasso di civiltà di una società si misura sulla quantità di occasioni che quella civiltà, quella società, sanno offrire alle generazioni più giovani. Io spero dunque che nell’Italia degli anni a venire questo tema, quello dei saperi, abbia la collocazione giusta, una collocazione assolutamente prioritaria. E sono convinto che la scuola è lo strumento fondamentale per offrire un’occasione di crescita culturale, attraverso l’apprendimento, alle persone più giovani. Penso perciò che la scuola italiana vada aiutata con interventi mirati a farne davvero il primo luogo nel quale i cittadini si formano, apprendono e diventano cittadini consapevoli del mondo. La scuola italiana ha oggi problemi seri. Una parte di questi problemi si sono trascinati negli anni in ragione del fatto che le risorse disponibili erano poche. La crisi che ha colpito l’economia italiana, le difficoltà finanziare dalle quali stiamo uscendo solo adesso hanno infatti ridotto oggettivamente le risorse disponibili anche per le attività direttamente o indirettamente connesse alla scuola. Ma oggi esistono le condizioni, in virtù della fase di risanamento che questo paese si è messo in larga parte alle spalle, perché si possa tornare a investire. Io credo che queste spese, questi investimenti futuri, debbano essere destinate prioritariamente alla scuola. E penso di conseguenza ad una scuola in grado di riformarsi rapidamente e di diventare luogo attrattivo per tanti ragazzi. I problemi sono tanti, e noti agli insegnanti e ai studenti che li vivono in prima persona, ai genitori e agli adulti in genere. La scuola necessita di investimenti, di risorse consistenti, destinate ad offrire una effettiva pluralità di strumenti, linguaggi, conoscenze. Diceva prima Moretti che il mondo che ci aspetta è un mondo in cui le tecnologie hanno un peso, un rilievo, molto più determinante che nel passato: è indispensabile che la scuola sia in grado di conoscere per tempo queste tecnologie e possa utilizzare le più efficaci per fornire un servizio migliore ai cittadini, in questo caso ai ragazzi. C’è poi un problema, strettamente connesso al precedente, che riguarda i programmi di aggiornamento, le forme di conoscenza che vengono afferte ai ragazzi. E c’è l’esigenza improcastinabile di riformare e riorganizzare i cicli scolastici. Soltanto il combinato disposto di un riassetto dei cicli, della struttura, delle tecnologie e dei programmi potrà far fare alla scuola italiana il salto qualitativo che è necessario. Io penso che questo rilancio dell’attività scolastica, delle occasioni con le quali si offrono elementi di conoscenza indispensabili per la vita di una persona, debba avvenire nel rispetto delle norme costituzionali. Ritengo perciò che si debba uscire da una disputa invero pericolosa, sbagliata, sui rapporti tra scuola pubblica e scuola privata e credo che sia lecito lavorare perché nel futuro lo Stato non rinunci ad un obbligo fondamentale come quello di offrire ai suoi cittadini gli elementi di formazione e di conoscenza che servono. Da questo versante il ruolo della scuola pubblica è insostituibile. Non soltanto perché è definito dalle norme costituzionali, ma perché è compito fondamentale di uno Stato offrire ai suoi cittadini tutto quello che serve per farli essere in grado di gestire sé stessi e il proprio destino con gli strumenti culturali necessari. Questo significa per me agire in modo tale che le famiglie siano messe nelle migliori condizioni per avviare alla scuola i propri figli. Significa applicare norme costituzionali senza avere trasferimenti dello Stato verso le scuole private ma utilizzando la leva fiscale per dare a tutti i cittadini le stesse possibilità e le stesse condizioni per scegliere qual è la scuola nella quale decidono di formarsi e di istruirsi. Stesse condizioni, leva fiscale da utilizzare in un rapporto stretto con le condizioni di reddito in modo tale che si realizzi un diritto di cittadinanza fondamentale. Bisogna agire sulla domanda e non sull’offerta, dunque, affinchè l’offerta non subisca alterazioni, affinchè non ci siano violazioni del dettato costituzionale, affinchè a tutti siano offerte le stesse condizioni. Ovviamente la scuola da sola non basta ed è importante che ad essa vengano affiancati luoghi e percorsi formativi attraverso i quali le persone possano apprendere e aggiungere conoscenza a quella che la scuola offre. Considero in questo ambito molto importante il fatto che si sia recuperata un’attenzione al tema della formazione. La formazione è uno straordinario strumento di competizione per chi la sa utilizzare al meglio e l’obbligo della formazione fino a 18 anni, introdotto con l’accordo che abbiamo siglato qualche settimana fa, è un passo avanti importante. Perchè nasce dalla consapevolezza di quanto sia importante mettere a disposizione di tanti ragazzi luoghi per imparare, aggiornarsi, diventare cittadini consapevoli e lavoratori forti. Perchè i paesi che prima di altri hanno destinato risorse ed attenzione a questo tema hanno saputo reggere meglio di altri anche le vicissitudini a volte complesse relative agli andamenti del ciclo economico. E’ certo indispensabile offrire delle occasioni di lavoro, tornerò su questo tema, ai giovani, ma bisogna sapere che per loro non ci saranno più le regole, le condizioni che sono valse per le generazioni precedenti e quel che si impara oggi a scuola avrà bisogno di essere aggiornato, rinnovato, con una celerità che non era necessaria per le nostre generazioni. L’utilizzo di nuove tecnologie, la padronanza di nuovi linguaggi, impongono aggiornamenti sistematici, continui. Bisognerà studiare per tutto l’arco della vita, bisognerà mettersi in condizione di apprendere, arricchire le proprie conoscenze sempre. Per essere cittadini consapevoli e lavoratori in grado di collocarsi nel processo produttivo senza subire pesanti effetti negativi quando il ciclo economico flette. E veniamo dunque al tema del lavoro, che, per le ragioni che spero siano emerse da quanto ho detto finora, è strettamente connesso ai temi della scuola e dei saperi. Perché alle generazioni più giovani vengano offerte occasioni di lavoro, perché ci siano una prospettiva positiva per tante persone è indispensabile che vengano realizzati contestualmente più obiettivi. Nel mondo che ci aspetta le barriere tra i paesi saranno sempre più tenui e la competizione avverrà tra grandi aggregati sovranazionali. Credo che la globalizzazione vada considerata anche così, come un processo che può favorire, se positivamente gestito, una crescita, una evoluzione per tanti paesi e tante economie, come una occasione di emancipazione per milioni di persone. Certo, come tutti i processi, non sarà lineare né privo di ambiguità e di rischi, ed i suoi esiti dipenderanno da come gli uomini e le donne lo orienteranno, a partire da coloro che hanno incarichi di responsabilità. Ma è un processo che presenta tante potenzialità. Alla base della costruzione dell’Unione Europea non ci sono soltanto valori ideali (le vecchie, nobili idee dei padri dell’Europa), ma anche esigenze e bisogni materiali di un mercato globale nel quale si può competere meglio e più efficacemente se si sta insieme, se si costruiscono dimensioni economiche e poi istituzionali e politiche più ampie di quelle precedenti. E questo non vale soltanto per la piccola impresa che deve internazionalizzarsi (sapete come è importante per molti produttori, anche italiani, il rapporto e l’integrazione con altri produttori nello stesso settore, nella stessa attività) ma anche per le economie dei paesi che vogliono competere nel mercato globale . L’Unione Europea è anche la conseguenza di questo processo, non soltanto della realizzazione di importantissimi valori ideali. Certo, in questo mondo più piccolo, nel quale le distanze sono più brevi in virtù delle tecnologie disponibili, la globalizzazione porterà anche momenti di tensione, di conflitto tra gli aggregati che si sono via via costituiti. E’ importante però che da questi conflitti, da queste tensioni, nasca comunque un processo evolutivo e che lo sviluppo delle economie, e le politiche espansive, siano sempre al centro delle scelte che verranno di volta in volta fatte, pur senza perdere di vista il giusto equilibrio tra politiche espansive e condizioni oggettive di gestione finanziaria di un paese o di un aggregato nazionale. L’obiettivo è quello di fare crescere ogni singolo paese, ogni aggregato, perché soltanto dallo sviluppo e dalla crescita possono venire le condizioni per offrire concretamente occasioni di occupazione e di impiego a milioni di persone, a cominciare da quelle più giovani. Siamo entrati da qualche mese in un consesso importante come l’Unione Europea, la costruzione della moneta europea è stata la porta di accesso all’Europa comunitaria. Il nostro paese ha sopportato sacrifici consistenti per realizzare gli obiettivi che ci hanno consentito l’ingresso nella moneta unica, sacrifici che non avevano alternative dato che l’esclusione dalla comunità europea avrebbe avuto conseguenze drammatiche e arrecato danni enormi, soprattutto agli interessi dei più deboli. Le crisi finanziarie di paesi lontani, quelle del sud est dell’Asia o quelle di paesi sudamericani avrebbero infatti avuto qui ripercussioni pesanti, saremmo stati oggetto di speculazioni e con tutta probabilità la nostra moneta sarebbe stata svalutata. Chi ne avrebbe tratto vantaggio? Forse qualche piccolo settore, come quelli che negli anni passati hanno utilizzato la svalutazione per competere, ma per i più deboli, per i pensionati, i lavoratori dipendenti, per tantissime famiglie la svalutazione della moneta sarebbe stata un danno rilevante. Lo dico oggi a posteriori per ricordare, in primo luogo a chi ci ha criticato per la nostra scelta europeista fin dalla prima ora, quali sarebbero state le derive pericolose, in qualche casa addirittura disastrose, per il Paese, se si fosse dato retta ad alcune sirene che volevano rinviare nel tempo l’ingresso nell’area dell’euro. Per ragionare seriamente di lavoro e occupazione occorre stare insieme agli altri, occorre far si che l’Europa diventi un aggregato competitivo nel mondo, recuperi la sua capacità di sviluppo e di crescita e l’utilizzi per dare risposte positive e convincenti a tanti cittadini, con la consapevolezza che lavorare non è solo un modo attraverso il quale le persone hanno un’occasione di reddito ma anche una strada per realizzarsi. Ma l’Europa per noi è indispensabile anche per risolvere i nostri problemi specifici, a cominciare da quelli del Mezzogiorno, da quelli che assillano voi ragazzi e le vostre famiglie. Il nostro è un paese dai tratti a volte persino paradossali. Alcune provincie italiane sono tra le provincie a più bassa disoccupazione di tutta Europa (quella nella quale sono nato io nel 1998 ha avuto ad esempio una disoccupazione inferiore al 4%); ma siamo allo stesso tempo il paese che ha le provincie con la più alta disoccupazione d’Europa. La bellissima città che ci ospita oggi è per l’appunto una città di questa parte d’Italia che ha problemi seri da risolvere rapidamente. Questa contraddizione la dobbiamo risolvere noi, è compito di chi governa questo paese, delle forze sociali che possono contribuire alla ricerca di soluzioni efficaci, dare risposte positive alle esigenze della parte più debole. Ciascuno di noi sa che senza una crescita complessiva del Paese, senza politiche espansive che coinvolgano anche gli altri paesi difficilmente avremo le risorse necessarie per risolvere i problemi del Mezzogiorno e pur tuttavia nessuno può sottrarsi all’obbligo, mentre chiede politiche efficaci e coerenti nel resto dell’Europa, di fare la sua parte qui, di affrontare tutti i temi che sono tipici della sua condizione, della società e dell’economia nella quale vive. Per questo anche in Italia bisogna crescere, bisogna completare il processo di risanamento che negli ultimi anni è stato avviato e che per fortuna abbiamo in larga misura alle nostra spalle. Non bisogna abbandonare le politiche di rigore che ci hanno consentito di arrivare fin qui; non bisogna sottovalutare le anomalie che ancora permangono, il fatto che il nostro debito sia più alto di altri paesi europei. Contemporaneamente, bisogna utilizzare una quota della ricchezza che si produce per creare lavoro, perchè il lavoro viene dagli investimenti, dagli investimenti tradizionali e da quelli innovativi. Bisogna realizzare le condizioni perché questi investimenti vengano realizzati, perchè attraggano nei territori più deboli gli imprenditori privati, e rendano remunerativo lo sforzo che a questi imprenditori si chiede. E credo che molte delle cose che debbono essere fatte, soprattutto quelle che servono ad abbattere le diseconomie, sono quelle a cui ci riferiamo molti di noi, e dei nostri interlocutori di governo o di impresa, quando parliamo di infrastrutture da realizzare, di formazione da rendere disponibile. Quando in tanti territori mancano ancora infrastrutture elementari come le strade, le ferrovie, i porti, quando non ci sono stati processi di innovazione nelle infrastrutture e nelle tecnologie, come quelle che consentono di connettere noi che siamo qui con altri, in questo caso gli studenti e gli insegnanti dell’istituto Mario Pagano, che ci vedono, ci ascoltano e dialogano con noi da un altro luogo, quando le città non sono state cablate, quando le tecnologie informatiche sono così carenti in quantità e qualità, non ci sono soltanto condizioni negative per chi investe, ci sono condizioni negative anche per chi vive, e noi dobbiamo porci sempre il problema di facilitare la crescita economica per consentire, attraverso il reimpiego della ricchezza che si produce, di dare una risposta positiva a molti problemi, a cominciare da quello del lavoro, e contemporaneamente dobbiamo pensare alla qualità della vita delle persone che sono impegnate in questo processo. Globalizzazione, Europa, Mezzogiorno e politiche attive per il lavoro: soltanto una soluzione positiva di questi aspetti può portare il futuro positivo al quale facevo riferimento. Anche il mercato globale ha naturalmente bisogno di regole. Ciò vale per i grandi aggregati sovranazionali, questo nuovo fronte, più ampio rispetto a quello tradizionale nell’ambito del quale siamo cresciuti, così come vale per i singoli paesi e, per la parte di autonomia che gli resterà, anche per le imprese e per le organizzazioni dei lavoratori. La qualità nella competizione e nel mercato globale va considerata infatti anch’essa come una priorità nelle scelte che devono essere realizzate nei vari livelli che vi ho indicato, perché qualità significa regole e un mercato senza regole rischia di essere una sorta di giungla nella quale soggetti che hanno nell’esigenza di sopravvivere il motore principale dei loro comportamenti si contendono spazi a colpi di clava. Il mercato è tale quando ha regole, quando impedisce la sopraffazione dei forti sui deboli, quando impedisce il crearsi di monopoli che marginalizzano il restante delle attività. Ho trovato spesso stucchevole la discussione, non ancora terminata, sulle privatizzazioni, in un paese come il nostro, non perché consideri questa discussione inutile ma perché penso che sia indispensabile far precedere alla discussione sulle privatizzazioni scelte coerenti di liberalizzazione dei mercati. Nel mercato globale si confrontano due modelli: uno nel quale si considerano come fondamentali per la competizione esclusivamente la diminuzione sistematica dei costi delle merci e dei servizi che vengono prodotti e offerti e un altro nel quale invece è la qualità dei prodotti e dei servizi che vengono offerti ad essere considerata decisiva. La qualità porta con sé l’esigenza di avere sempre protezioni adeguate non soltanto per le persone che lavorano ma anche per quelle che vivono nel mondo. E ciò si traduce in diritti fondamentali rispettati, i diritti delle persone, i diritti universali, quelli di cittadinanza e quelli del lavoro. Nessuno può ignorare che questi due modelli siano a confronto, e o prevarrà il secondo, come io spero, oppure il prevalere del primo ci consegnerà un mondo diverso da quello che noi auspichiamo, un mondo che potrebbe essere simile a quello dove “i granelli di polvere radioattiva erano tanti da oscurare il sole”. Ecco perché il tema dei diritti, l’esigenza di regole, di protezioni sociali per i cittadini che abbiano un equilibrio tra il costo necessario per garantirle e la ricchezza che viene prodotta, va considerato con un’attenzione che spesso sfugge a molti. C’è nella cultura europea un’idea forte di Welfare, di protezione per i cittadini, che non va abbandonata. Certo, sarebbe un errore considerare il welfare come una somma di protezioni immutabili nel tempo. Lo Stato sociale risponde fin dalla sua origine alla condizione data, ai bisogni prevalenti delle persone alle quali era destinato. Cambiando la composizione sociale, mutando i bisogni delle persone, è necessario che le protezioni vengano sistematicamente aggiornate. Ma aggiornate e non cancellate. Così come sono importanti i diritti delle persone e non può essere mai considerato un conservatore chi si fa carico dell’esigenza di vedere rispettati i diritti fondamentali delle persone, siano essi diritti di cittadinanza o diritti delle persone che lavorano. In un mondo che cambia così rapidamente e nel quale altrettanto rapidamente si trasforma il lavoro c’è ad esempio bisogno rapidamente di offrire protezioni a quella parte di lavoro “nuovo” che ancora non ne ha. La crescita delle grandi organizzazioni sindacali, anche la crescita importante e tumultuosa dei tempi più recenti, ha sempre avuto questo tratto. I sindacati confederali si sono caratterizzati, come molti di voi sanno, proprio per la loro capacità di difesa delle condizioni materiali e dei diritti di quelle persone che allora lavoravano prevalentemente in fabbrica, con un organizzazione taylorista del lavoro. E’ un mondo oggi in via di progressivo superamento, che rimane ancora consistente in alcuni settori e in alcune attività, ma che in tanti altri viene via via sostituito da forme diverse di lavoro, più frantumato, più diffuso nel territorio, con caratteristiche diverse da quello precedente. E molti dei rapporti di lavoro che si instaurano oggi non sono più assoggettati alle stesse protezioni che erano state garantite invece a coloro che lavoravano in fabbrica o nell’ufficio tradizionale. Io credo che sia compito del sindacato farsi carico rapidamente e con politiche efficaci dei problemi di questa parte consistente di lavoro nuovo che ormai coinvolge milioni di persone. Un sindacato distratto sarebbe un sindacato colpevole, si caricherebbe inevitabilmente di contraddizioni e si avvierebbe verso un ineludibile declino. Noi aspiriamo ad essere sindacati confederali che hanno un’idea forte della rappresentanza generale e che proprio per questo si fanno carico dei problemi di tutte le persone che lavorano e vogliono tenere coerentemente in equilibrio i loro problemi con le esigenze di quelle che un impiego non hanno. Il confine dei diritti è dunque un confine importante. Una società nella quale si compete mettendo in discussione i diritti delle persone è una società dai tratti sinceramente illiberali. Io credo che sia per questo necessario in ogni momento, in ogni circostanza, porsi il problema di come si garantiscono le persone, come si dà loro una prospettiva positiva, e non bisogna mai prescindere dal considerare che in qualsiasi momento della vita delle persone esistono diritti universali da rispettare, quelli che dovrebbero rappresentare un antidoto allo sfruttamento terribile dei bambini, quelli che dovrebbero consentire ad un bimbo di crescere sereno e di vivere la sua infanzia senza essere costretto dal bisogno o dall’ignoranza a svolgere attività falsamente remunerate. Diritti in tutte le forme e in tutte le attività, produttive o di servizio, sia per chi sta nella grande industria come per chi sta nella piccola impresa, sia per chi ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia per chi ha un lavoro a tempo parziale, o limitato. Diritti che vanno commisurati con i loro costi e con la loro efficacia, ma diritti. E nel nostro futuro tutte le volte che ci capiterà di incontrare questo problema sulla nostra strada dovremo essere in grado, come abbiamo cercato sempre di fare, di scegliere e io credo sia giusto, tutte le volte che si pone l’alternativa tra un diritto e un bisogno, scegliere il rispetto del diritto. Certo è difficile. E sarebbe opportuno che chi gestisce l’economia di un paese così come chi rappresenta i bisogni o gli interessi delle persone evitasse di creare, magari involontariamente, le condizioni che portano a questa alternativa drammatica. Ma quando la contraddizione è in campo bisogna pensare prima al rispetto dei diritti che non alla realizzazione di quello che serve a soddisfare un bisogno. Uno dei temi che impegnerà tutti nei mesi e negli anni a venire è quello relativo al come si crea e come si vive in una società multietnica. Un mondo nel quale le distanze crollano, che avvicina paesi lontani, è un mondo nel quale anche le persone si muovono con più intensità rispetto al passato. E’ non solo inevitabile, ma vorrei dire che è bello ci sia questa possibilità, ci sia la condizione per tanti di noi di vivere e di lavorare insieme a persone dalla cultura, dalle tradizioni, dalla religione diversa dalla nostra. Il confronto tra le etnie ha delle potenzialità straordinarie, può far crescere tutti e dunque anche questo non deve essere vissuto come un dramma incombente ma come un’occasione. Ma, ancora una volta, perché sia così servono non solo regole da rispettare, da applicare, da attuare ma serve anche un atteggiamento positivo, una disponibilità soggettiva delle persone. Ho sentito spesso usare, nelle discussioni che come sapete accompagnano in questi giorni tante riflessioni sui problemi che sono propri dei processi migratori, il termine “integrazione”. Vi confesso che è una parola che non mi convince; integrazione finisce col significare che qualcuno deve rinunciare a qualcosa per accettare la cultura degli altri mentre io spero si possa lavorare insieme per avere una società nella quale nessuno rinunci alle sua particolarità, alle caratteristiche della sua etnia e tutti siano capaci di rispettare le diversità. Io mi fermo qui. Ho cercato di indicare alcuni elementi che a me paiono importanti, temi dell’oggi che è difficile separare da quelli che ci aspettano nell’immediato futuro. Credo in definitiva che sia importante che ognuno, consapevolmente, per la parte che lo riguarda, non si nasconda le difficoltà e affronti le contraddizioni con lo spirito e l’intenzione di risolverli, di garantire un quadro di riferimento che crei fiducia, che generi aspettative positive e non preoccupazioni od ombre, timori o perplessità. Ho ricordato all’inizio come in verità la descrizione del futuro sia spesso buia, a volte addirittura catastrofica. Ho citato, facendo tesoro delle mie curiosità, delle mie passioni, un film che molti di voi conoscono, “Blade Runner”, che comincia come vi dicevo in questa metropoli buia, multietnica, non casualmente di un futuro apparentemente lontano. E’ un film nel quale non c’è mai uno squarcio di luce salvo alla fine, quando l’ultimo dei replicanti, seduto sul tetto di una casa, prima di morire dice all’uomo che ha il compito di ucciderlo queste parole (che non esistono nel libro e state introdotte nella sceneggiatura): “Ne ho visto di cose che voi umani non potreste immaginare: ho visto navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Danoiser e tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. E’tempo di morire”. E a questo atto estremo, la rinuncia alla vita, fa seguito la liberazione di una colomba bianca che si alza verso il cielo mentre appare l’unico squarcio di luce in quel film buio e tetro. Ecco, io vorrei concludere la prima parte della nostra discussione così. Credo che il nostro futuro possa avere questo squarcio di luce. Sono convinto soprattutto che il mondo che aspetta i più giovani, se quelli che giovani non lo sono più faranno fino in fondo il loro dovere, non avrà tanti granelli che oscurano il sole ma avrà la luce che si vede quando quella colomba bianca si alza nel cielo. |

| Napoli, 19 Marzo 1999 Desidero ringraziare vivamente Austro & Aquilone, la Fondazione Feltrinelli e la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Federico II per l’opportunità concessami di parlare innanzi a Voi. Il nome dell’Università, Federico II, risale ad un sovrano che con la sua politica saggia e moderna cambiò la situazione economica e di conseguenza anche culturale di Napoli. Ci si aspetta simili mutamenti di fondo anche dall’introduzione dell’Euro. Anche se le basi sono già state poste, resta ancora da vedere se l’Euro susciterà, in futuro, delle associazioni altrettanto positive a quelle connesse all’imperatore del casato degli Hohenstaufen. Il 1° gennaio ha preso il via l’Unione monetaria europea in undici Paesi. I tassi di cambio dei Paesi partecipanti sono stati irrevocabilmente fissati sia tra di loro che nei confronti dell’Euro. Una tappa fondamentale per il processo d’integrazione europea è stata così segnata. Il Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC) ha assunto la responsabilità per la politica monetaria di Eurolandia. Il Sistema Europeo delle Banche Centrali è composto da undici banche centrali nazionali giuridicamente autonome e dalla Banca Centrale Europea (BCE) fondata già nel giugno 1998 con sede a Francoforte sul Meno che possiede anch’essa una personalità giuridica. Tra i compiti del Sistema Europeo delle Banche Centrali si annoverano in primo luogo la definizione e l’attuazione della politica monetaria comune, la realizzazione di operazioni in valuta estera, la custodia e l’amministrazione delle riserve monetarie ufficiali degli Stati membri nonché la promozione di un funzionamento impeccabile dei sistemi di pagamento. L’organo direttivo e decisionale supremo del SEBC è il Consiglio Direttivo della BCE ed è costituito dai sei membri del Comitato Esecutivo della BCE e dagli undici presidenti delle banche centrali nazionali. Il Consiglio Direttivo della BCE stabilisce in particolare la politica monetaria in tutta l’Eurolandia fissando le linee direttrici e prendendo le decisioni necessarie. La BCE è responsabile dell’attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo della BCE. Essa deve comunque appoggiarsi – nella misura in cui appaia possibile e pertinente – alle banche centrali nazionali. All’interno del nuovo spazio monetario la politica monetaria può essere unitaria solo se sono unitari i tassi d’interesse delle banche centrali nazionali. Le singole banche centrali nazionali non possono quindi adottare tassi d’interesse diversi oppure particolari linee di rifinanziamento. Per questo motivo, le banche centrali nazionali operano, malgrado la loro autonomia giuridica, come componenti integranti del SEBC secondo le istruzioni e le linee direttrici della BCE. Questo garantisce l’unitarietà della politica monetaria. Il Trattato di Maastricht stabilisce per tutti i Paesi partecipanti che l’obiettivo primario della politica monetaria è la garanzia della stabilità dei prezzi e che le banche centrali nazionali godono di uno stato di indipendenza. Essendo fissati mediante un trattato, entrambi i punti sono sottratti a decisioni di modifica unilaterali da parte dei parlamenti o dei governi nazionali. Dal lato organizzativo ed istituzionale, di conseguenza, non vi sono praticamente ostacoli al successo della politica di stabilità europea. Importante è tuttavia che i responsabili si basino, in futuro, effettivamente su questo quadro giuridico. In Germania, la Bundesbank è stata indipendente sin dall’inizio nei confronti del Governo, del Parlamento e dei gruppi d’interesse ciò ha finora permesso al suo Consiglio Direttivo di seguire con coerenza una politica della moneta stabile ed anche di tener duro in periodi di crisi. Di riflesso, i rapporti tra la banca centrale tedesca ed i rispettivi governi non sono stati sempre privi di tensioni. A volte le decisioni di politica monetaria hanno provocato tensioni ed i consigli e le prese di posizione della Bundesbank hanno suscitato un’eco negativa presso le istanze politiche. Tuttavia l’indipendenza della banca centrale non era e non è fine a se stessa. Da sola non potrà sicuramente assicurare la stabilità monetaria. Essa contribuisce, però, come lo dimostra la storia del marco tedesco, al raggiungimento di una maggiore stabilità dei prezzi e all’istituzione di una cultura della stabilità. Innanzitutto essa promuove una stabilità a più lungo termine in politica e sui mercati. Per questo motivo lo status di indipendenza della banca centrale ha trovato, nel frattempo, notevole appoggio ed applicazione non solo in Europa ma anche su scala mondiale. Non è però neanche corretto parlare in maniera indifferenziata della Banca Centrale Europea come della “copia” della Bundesbank. Che il Sistema Europeo delle Banche Centrali non sia una copia della Bundesbank lo dimostra già la posizione giuridica delle banche centrali nazionali in confronto alla posizione delle banche centrali dei Lander in seno alla Bundesbank. Infatti, mentre le banche centrali dei Lander sono delle amministrazioni principali non autonome della Bundesbank, il Sistema Europeo delle Banche Centrali è costituito da undici banche centrali nazionali giuridicamente autonome nonché dalla Banca Centrale Europea di Francoforte. Quindi, con l’inizio dell’Unione monetaria le banche centrali nazionali hanno demandato i loro poteri decisionali generali in ambito monetario al Consiglio Direttivo della BCE. Però tutti i presidenti ovvero governatori delle banche centrali nazionali che hanno aderito all’Unione monetaria partecipano, assumendosi la propria responsabilità, a tutte le decisioni in materia monetaria prese in seno al Consiglio Direttivo della BCE il quale non sottostà ad alcun tipo di istruzioni. Poiché la responsabilità del Consiglio Direttivo della BCE si estende all’intera area monetaria, i Presidenti nazionali delle banche centrali nel Consiglio Direttivo della BCE non possono farsi paladini di interessi nazionali. La loro responsabilità personale concerne piuttosto la garanzia della stabilità del valore monetario in tutta l’Eurolandia. In effetti, l’Euro è una moneta sovranazionale, diversa dalle monete nazionali finora in uso; questa responsabilità sovranazionale si evidenzia già nelle strutture decisionali interne. Ogni membro del Consiglio Direttivo della BCE possiede un voto dello stesso peso. È qui che emerge la responsabilità personale dei membri del Consiglio Direttivo della BCE. Una ponderazione dei voti in relazione alla grandezza ed all’importanza economica del Paese d’origine è prevista solo per alcuni settori ristretti non di primaria importanza monetaria. Di conseguenza, solo per le deliberazioni riguardanti il capitale della BCE, il trasferimento di riserve monetarie alla BCE, la ripartizione delle entrate monetarie delle banche centrali nazionali e la ripartizione dei profitti netti della BCE, solo in questi settori i voti dei presidenti nazionali sono ponderati in base alle quote delle banche centrali nazionali sul capitale della BCE. In questi casi i membri del direttorio non partecipano alla votazione. La Banca Centrale Europea si basa nella sua strategia monetaria su due elementi principali. Da un lato la quantità di moneta avrà un ruolo di rilievo. Data l’origine monetaria della dinamica dei prezzi nel medio e lungo periodo, su cui vi è un ampio consenso, informazioni utili sulla loro evoluzione futura possono essere desunti dagli andamenti della quantità di moneta detenuta dal pubblico, che costituiscono perciò un importante strumento di orientamento per la conduzione della politica monetaria. Inoltre, l’analisi degli aggregati monetari può contribuire alla valutazione complessiva dell’evoluzione del sistema finanziario più in generale del sistema economico. Un aggregato monetario può essere definito come la somma del circolante più le consistenze in essere di alcune passività delle istituzioni finanziarie, il cui “carattere monetario” è particolarmente evidente o la cui liquidità, intesa in senso lato, è elevata. La BCE ha definito un aggregato monetario ristretto (il cosiddetto Ml), uno intermedio (M2) e uno ampio (M3). Questi aggregati differiscono da loro per quanto attiene al “carattere monetario” delle attività incluse. Secondo l’analisi condotta dalla BCE e dal suo predecessore, l’istituto Monetario Europeo, gli aggregati monetari ampi dell’area dell’Euro, pur essendo forze meno controllabili nel breve termine, presentano, rispetto a quelli ristretti, caratteristiche migliori in termini di stabilità e forniscono maggiori informazioni sull’andamento dei prezzi nel medio termine. La strategia di politica monetaria della BCE richiede l’individuazione di un aggregato monetario che rappresenti un indicatore stabile e affidabile dell’inflazione in un orizzonte di medio termine. Per questa ragione il consiglio direttivo della BCE ha deciso di attribuire all’aggregato monetario ampio M3 un ruolo di primo piano nella strategia di politica monetaria, attraverso l’annuncio di un valore di riferimento quantitativo per il suo tasso di crescita annuale. Il primo valore di riferimento per M3 è stato fissato in una quota annuale del 4,5%. La metodologia utilizzata per individuare il valore di riferimento si basa sulla ben nota relazione tra la crescita monetaria, l’inflazione, la crescita del PIL reale e le variazioni nella velocità di circolazione, tenendo conto della definizione di stabilità dei prezzi annunciata dal Consiglio Direttivo della BCE nell’ottobre 1998 (cito: “un aumento nell’indice armonizzato dei prezzi al consumo inferiore al 2 per cento annuo”). L’individuazione del valore di riferimento si è inoltre basata sull’ipotesi relative alle tendenze di crescita del PIL reale (dal 2 al 2,5 percento annuo) e di riduzione della velocità di circolazione di M3 nel medio periodo (una riduzione da circa 1/2 ad i percento annua). Il rapporto tra la crescita monetaria effettiva ed il valore di riferimento reso noto anticipatamente è regolarmente sottoposto all’accurata analisi da parte del Consiglio Direttivo della BCE. L’esito ditale analisi e la sua importanza per le decisioni di politica monetaria vengono ampiamente spiegate all’opinione pubblica. Dall’altro lato, le previsioni per l’andamento dei prezzi e i rischi per la stabilità dei prezzi vengono esaminati mediante una vasta gamma di indicatori economici e finanziari. Tra questi sono incluse molte variabili che hanno la proprietà di essere indicatori anticipatori degli andamenti futuri dei prezzi. Queste variabili includono, fra l’altro, i salari, i tassi di cambio, i prezzi di titoli e la curva dei rendimenti, varie misure dell’attività economica reale, indicatori fiscale, indici di prezzi e costo nonché inchieste condotte presso le imprese e i consumatori. Ovviamente, nel valutare se l’orientamento della politica monetaria è appropriato, è anche utile guardare alle previsioni di inflazione formulate sulla base ditali variabili. A questo riguardo, la BCE valuta l’insieme delle previsioni sull’inflazione prodotte dalle organizzazioni internazionali, da altre autorità, dagli operatori del mercato, etc., e produce altresì una propria valutazione sulle prospettive per l’inflazione. Sia le previsioni che le analisi dei singoli indicatori contribuiscono a informare il Consiglio direttivo circa la natura specifica del quadro macroeconomico e dei fattori di disturbo all’economia, da cui le decisioni di politica monetaria normalmente dipendono. Questa strategia sottolinea che il Consiglio Direttivo della BCE persegue rigorosamente il suo obiettivo primario. la garanzia della stabilità dei prezzi. Essa contribuisce inoltre ad una maggiore trasparenza nel processo decisionale del SEBC. In futuro il Consiglio Direttivo della BCE dovrà attuare una politica di stabilità in undici Paesi partecipanti che continueranno ad essere in larga misura sovrani e, in parte, avranno concetti politici autonomi. Le decisioni del Consiglio in materia monetaria avranno uguale valore in tutta l’area dell’Euro. Pertanto, i Paesi partecipanti dovranno, in futuro, frenare con le proprie forze gli sviluppi divergenti nella congiuntura, nella crescita e nell’occupazione e adottare le relative misure di adeguamento, il che rende indispensabile una maggiore flessibilità dei mercati dei beni e del lavoro nazionali visto che i Paesi partecipanti non dispongono più di tassi di cambio e della politica monetaria per poter giungere ad un tale adeguamento. Occorre tuttavia anche coordinare sufficientemente le politiche nazionali per assicurare in Eurolandia un policy mix che agevoli la stabilità e stimoli la crescita e per evitare tensioni inutili con la politica monetaria comune. Qui la politica finanziaria detiene una forte responsabilità. Per questo motivo il Patto di stabilità e di crescita fissato in maniera vincolante con un trattato, non deve essere toccato. Il migliore contributo della politica monetaria a favore di una crescita duratura e una maggiore occupazione consiste in un orientamento verso la stabilità che faciliti i calcoli in economia. Questo vale innanzitutto nella situazione attuale essendo le cause della disoccupazione in Europa perlopiù di natura strutturale. La politica monetaria europea non può assumersi, in questo caso, i compiti degli altri settori politici. La stabilità dei prezzi è una condizione generale importante per l’economia nel suo insieme. Essa aumenta la trasparenza dei prezzi, è rilevante per un’allocazione efficace delle risorse, consente dei tassi di interesse bassi, mantiene stabile il valore dei redditi e dei risparmi. Nel contempo, la stabilità dei prezzi interna è il presupposto per contribuire alla stabilità del valore esterno della moneta. L’Euro ha preso il via partendo dalla base di una stabilità dei prezzi in larga misura realizzata. L’inizio promettente è inoltre il risultato di un duro lavoro di preparazione, ma è solo l’inizio. Ora si tratta di trasformare questa moneta introdotta con successo in una moneta stabile a lungo termine. Negli ultimi mesi prima dell’inizio dell’Unione monetaria, gli investitori internazionali avevano già scelto le monete dell’area dell’Euro come porto sicuro per le loro monete – probabilmente anche confidando nella futura stabilità dell’Euro. Sullo sfondo dei più recenti dibattiti politici in Europa sulle target zones, sull’integrazione della politica monetaria tesa a stimolare la crescita e l’occupazione, e sulla messa in questione di ulteriori passi di consolidamento e delle riforme strutturali, ci si dovrebbe chiedere, ora, se la fiducia che era stata anticipata esiste ancora. Questo anticipo di fiducia non deve essere tradito. Esso deve ora essere riscattato non solo dalla politica monetaria, bensì anche da altri settori politici attraverso decisioni credibili miranti alla stabilità. Una moneta stabile non è una cosa scontata anche se la stabilità dei prezzi raggiunta sembra suggerirlo. Persino il marco tedesco, forte su scala internazionale, ha perso nel corso degli ultimi 50 anni circa tre quarti del proprio potere d’acquisto. Per la stabilità si deve lottare continuamente. Tutti i Paesi partecipanti dell’Unione monetaria devono, quindi, attenersi ad un orientamento comune verso la stabilità. Attualmente è in corso un aspro dibattito sul ruolo della politica monetaria. Il nocciolo della questione è in fondo di stabilire se coinvolgere la politica monetaria maggiormente nella responsabilità della politica congiunturale (nel senso di demand-management). Non vorrei inserire una nota sbagliata nel dibattito: naturalmente le condizioni monetarie influenzano sia le prospettive congiunturali a breve termine che quelle a medio termine nonché il percorso di crescita economica a lungo termine. In questo contesto vale per la politica monetaria quel che vale per ogni settore politico: una buona politica di per se non può risolvere i problemi in economia, una cattiva politica, al contrario, può crearvi molti problemi. Credo sia incontestabile che una politica monetaria tesa alla stabilità si ripercuota in maniera positiva sulla congiuntura e la crescita. La prospettiva di prezzi stabili consente tassi d’interesse bassi, soprattutto in un’ottica a lungo termine. Una banca centrale altamente credibile attenua le aspettative d’inflazione ed i premi di rischio. Peraltro, se una strategia monetaria è orientata verso il potenziale produttivo, essa contiene già una specie di stabilizzatore automatico. È certo lecito chiedersi: può una politica monetaria, oltre a seguire l’obiettivo della stabilità, spingersi oltre, partecipare in misura ancora maggiore alla vita economica? Nel dibattito emergono voci che sottolineano sì quanto sia importante una moneta stabile, aggiungendo però immediatamente che ormai l’inflazione è morta. Di conseguenza, esse chiedono una politica monetaria attiva, espansiva. Ci si dovrebbe porre con scetticismo dinanzi ad una tale conclusione affrettata. La stabilità monetaria non è né un dono del cielo né è mai garantita in maniera duratura. Essa esiste fintanto che i settori decisivi, ovvero quello della politica salariale, finanziaria e monetaria, operano in maniera responsabile. Ed è minacciata dal momento in cui anche un solo settore commette errori più gravi. E non appena la stabilità monetaria verrebbe compromessa, molti di coloro che oggi preconizzano la morte dell’inflazione, lancerebbero immediatamente un nuovo dibattito di relativizzazione sostenendo che in fondo la stabilità si estende a molto più che solo all’andamento dei prezzi. Un tasso di inflazione del 2% non è troppo poco? – chiedono i sostenitori di questa tesi. Vale davvero la pena sopportare i costi di una politica antinflazionistica? Naturalmente sarebbe sleale limitare l’attuale dibattito a questo. Ovviamente si può anche proporre seriamente quasi una sorta di “politica monetaria divisa in due”: se vi sono dirette minacce d’inflazione, la banca centrale deve agire decisamente per arginare il fenomeno. Se, invece, non vi sono dirette minacce d’inflazione – così come sembra che sia tutto sommato attualmente – allora la banca centrale deve però ridurre i suoi tassi d’interesse nella maniera più drastica possibile. Una tale posizione appare subito del tutto legittima, infatti si richiama proprio al testo del Trattato di Maastricht nel quale la stabilità monetaria è citata solo quale compito primario accanto ad altri compiti. Questa posizione conduce in fondo ad una politica monetaria di più breve respiro e più volatile. (E proprio in un momento in cui tanti Paesi, tra cui ad esempio l’Italia, si sono allontanati da questa politica che persegue diversi scopi di importanza perlopiù eguale.) Sorge qui dapprima la questione se il grande bisogno di informazioni per questo orientamento ed i time Lags non rendano estremamente difficile, già solo sul piano tecnico, il perseguimento di un tale approccio monetario. Ma innanzitutto una politica monetaria più volatile e più a breve termine comporterebbe una serie di pericoli e di svantaggi che non vanno dimenticati. In primo luogo, poiché una politica monetaria più volatile aumenta l’incertezza generale, i tassi d’interesse sarebbero in media, durante un ciclo, tendenzialmente piuttosto alti che non bassi. In secondo luogo, sarà pur vero che con una politica del genere si possono realizzare limitati periodi con tassi d’interesse artificialmente bassi. Tuttavia, tale politica è un’arma a doppio taglio. Essa può facilmente lanciare segnali sbagliati che possono determinare investimenti errati e asset prices gonfiati mettendo persino in pericolo i risparmi privati, il che spingerebbe i mercati finanziari tendenzialmente in direzione del tanto citato capitalismo da casinò. Aumenta, inoltre, la possibilità di subire un contraccolpo nel passaggio ad una politica monetaria nuovamente più restrittiva. In terzo luogo, una politica monetaria a più breve termine provocherebbe naturalmente anche un più forte orientamento a breve termine della cultura finanziaria, il che rende l’economia più soggetta a sbalzi congiunturali. In tal senso è tutto sommato giusto che la politica monetaria agisca non solo in funzione della stabilità, ma tenga anche conto degli aspetti della continuità e dell’affidabilità – e non si lasci tentare dall’adottare un approccio interventistico. Questo non significa, però, un rifiuto nei confronti della congiuntura oppure della domanda macroeconomica. In effetti è giusto, che l’economia europea necessita della domanda interna sostenibile, soprattutto quella dei beni d’investimento, poiché in essa si trova in primo luogo il potenziale per gli effetti moltiplicativi. Nell’ambito degli investimenti le decisioni si prendono sempre anche in un’ottica a lungo termine. Esse necessitano soprattutto della costanza e dell’affidabilità delle condizioni generali, e non solo della politica monetaria ma anche soprattutto della politica economica, finanziaria, salariale e fiscale. Ciò non può essere messo in disparte nell’attuale dibattito sul ruolo della politica monetaria. Questo orientamento a lungo termine della politica monetaria rientra peraltro anche nella logica del concetto di una moneta depoliticizzata. Una moneta depoliticizzata non vuoi dire però che si disconosce il valore politico della moneta. La moneta non è apolitica. Al contrario, la stabilità della moneta è di grandissima importanza per la stabilità dello Stato e della società. Una moneta depoliticizzata significa tuttavia proteggere la moneta il più possibile da influssi politici giornalieri, calcoli a breve termine e tendenze di moda nonché da compromessi politici. Il concetto di una moneta depoliticizzata comporta per l’Euro l’opportunità economica di una maggiore stabilità e continuità. Ma nell’Unione monetaria, la moneta depoliticizzata è importante anche per un altro aspetto. Poiché gli Stati membri restano sovrani, il tentativo di subordinare la moneta comune a singoli interessi politici, sarebbe ancora più pericoloso che in ambito nazionale. Ne conseguirebbero inevitabilmente conflitti tra i Paesi, e la capacità d’azione della politica monetaria ne verrebbe altamente compromessa. Divergenze politiche continue sul ruolo della politica monetaria e sulla priorità del principio della stabilità potrebbero facilmente creare tensioni di fondo nell’Unione monetaria. A quel punto, non si possono più escludere eventuali conflitti tra i Paesi partecipanti e la sovranazionale Banca Centrale Europea. Un’Unione monetaria particolarmente conflittuale o fragile non sarebbe, comunque, problematica solo dal punto di vista economico, bensì potrebbe anche nuocere al processo d’integrazione europea nel suo insieme. Questo non deve accadere. Dobbiamo pertanto adoperarci con il massimo impegno affinché la ratio economica del rigore monetario prenda piede in Europa in maniera duratura. Ed infine: l’introduzione dell’Euro non richiede una politica che conduca ad un’ulteriore armonizzazione ed europeizzazione in tutti i settori della politica economica. Una tale politica sarebbe un grave errore dal punto di vista della politica dell’ordinamento, indipendentemente dalla violazione del principio di sussidiarietà. Il processo d’integrazione europea non può essere portato avanti mediante l’armonizzazione di tutte le politiche e l’uniformazione di tutte le regioni e tutti gli ambiti di vita, ma è realizzabile solo attraverso maggiore concorrenza e diversità. L’Europa vive della sua molteplicità economica, sociale e culturale che non può venire distrutta attraverso l’uniformazione. In ultima analisi l’integrazione europea serve a mettere meglio in risalto i vantaggi delle rispettive differenze tra i singoli Paesi e a rafforzare la dinamica dell’insieme. L’Euro rappresenta in questo processo un elemento importante e – speriamo – un catalizzatore per meglio preparare ‘Europa alle future sfide economiche e politiche. Così l’Euro potrà passare alla storia economica e politica europea con lo stesso successo con il quale l’imperatore degli Hohenstaufen Federico Il passò alla storia napoletana ed anche europea. Vi ringrazio per l’attenzione. |

Napoli, 14 Maggio 1999
Buongiorno a tutti. Sono Diego Piacentini e sono il general manager della Apple Europa.
Perché a tenere questa Lezione qui a Napoli è stata chiamata la Apple e non la Microsoft, mi sono chiesto quando sono stato invitato? (Per chi non lo sapesse il mercato dei sistemi operativi è controllato da due grandi gruppi. Il primo controlla il 95% del mercato, e non siamo noi, il secondo il 5%, e siamo noi. Volendo guardare la faccenda in un altro modo, viene da chiedersi come mai un sistema operativo che è giudicato dal mondo intero il migliore, il nostro, ha una posizione di minoranza sul mercato. E forse ci si può semplicemente rispondere che non sempre nelle economie moderne chi ha il prodotto migliore ha anche il prodotto più affermato).
Uno dei motivi per i quali la Apple sta a proprio agio in una sede prestigiosa come questa è illustrato dal famoso filmato che ha come protagonisti Ghandi, Einstein, Clay e tanti altri simboli del “pensare differente”.
Sono “Coloro che sono abbastanza folli da pensare di cambiare il mondo” quelli che lo cambiano davvero, e in questa stessa sala abbiamo alcuni rappresentanti di questa follia, un gruppo di “insegnanti coraggiosi” che sono riusciti, superando molte difficoltà, a far lavorare i bambini nella realizzazione del sito web della loro scuola elementare, il 70° circolo di Ponticelli (la cosa veramente coraggiosa sta nel fatto che l’idea, la progettazione, il lavoro è venuto tutto dalla base).
Fatta questa differenziazione per così dire “ideologica”, peraltro doverosa, cerchiamo di inquadrare l’argomento di oggi, o meglio, i vari argomenti di oggi (dovrete perdonarmi un po’ di inglesismi, ma lavoro fuori dall’Italia da tantissimo tempo e poi ci sono alcune parole che tradotte in italiano perdono molto della loro efficacia).
Oggi parliamo di società basata sulle informazioni, in inglese knowledge society, nella quale ciò che conta è la possibilità di avere a disposizione la globalità delle informazioni, la globalità dei sistemi di comunicazione.
Parliamo dunque di tecnologie. La possibilità di accesso a tutti delle informazioni è infatti reso possibile dalle tecnologie: le tecnologie sono lo strumento, l’accesso alle informazioni il fine (ovviamente in questo caso stiamo parlando di tecnologie di Internet).
In questo contesto la crescita economica è basata sulla conoscenza e il vantaggio comparativo deriva dalla capacità di creare, accumulare, acquisire, sfruttare conoscenza.
Si sono dunque rovesciate tutte le formule del capitalismo classico: ciò che conta oggi è la conoscenza. Il punto è quindi come utilizzare la conoscenza, come accedere alla conoscenza, che cosa farci sulla conoscenza (quando parlo di conoscenza non intendo dire strettamente cultura ma informazione. Il punto è dunque ancora una volta come utilizzare al massimo l’informazione di carattere finanziario, di carattere economico, di carattere tecnologico, di carattere sindacale).
I contenuti sono diversi ma l’importante è accedere in maniera efficiente ed efficace a questa conoscenza. E l’accesso facilitato alla conoscenza porta con sé trasformazioni culturali e sociali che mi pare interessante approfondire.
In molti sostengono che più presto tutti i protagonisti di questa economia che chiamiamo globale – governi, partiti, imprenditori, sindacati, insegnanti e quant’altro – riconosceranno la profondità e la pervasività di queste trasformazioni culturali e sociali e meglio sarà per tutti. Vero? Falso? Sicuramente vero. Se però non si perdono mai di vista alcuni fatti importanti.
Il primo attiene al gap tra economie sviluppate, quelle del Nord, e le economie non sviluppate del Sud (ovviamente non sto parlando di Italia, ma del mondo).
La società dell’informazione è globale nello scopo ma non nella diffusione.
Internet dà accesso all’informazione a tutti ed effettivamente in teoria qualsiasi persona da qualsiasi parte del mondo può accedere a Internet.
Ma in realtà chi sta utilizzando Internet in questo momento? Chi sta utilizzando effettivamente le nuove tecnologie?
In questo momento il 93% del mercato del ICT sta nei paesi sviluppati; ci sono appena 600 milioni di telefoni su sei miliardi di persone che popolano la terra ed il 75% di questi telefoni (non sto parlando di Internet, sto parlando di diffusione della voce, neanche di dati) si trovano nel Nord America, nell’Europa e nel Giappone che rappresentano solamente il 15% della popolazione; il 50% della popolazione mondiale non ha mai fatto una telefonata in vita sua .
Se ci postiamo un attimo dal nostro contesto culturale italiano, europeo, dove “alzi una mano chi non ha un telefonino”, e ci spostiamo un po’ più su, su di un satellite che guarda sul globo, sono questi i dati che vediamo.
Non intendo dare giudizi di valore ma semplicemente offrire uno spunto di riflessione, segnalare che il gap esistente tra Nord e Sud del mondo può portare ad una ulteriore marginalizzazione di chi è già emarginato.
L’altro punto assai importante riguarda la trasformazione del lavoro.
Segnalo innanzitutto la maggiore mobilità, nel senso che i lavoratori che fanno uso dell’informazione hanno ormai superato le barriere relative alle città e ai continenti, sono totalmente mobili. L’informazione sta cerando delle élites di lavoratori, i cosiddetti knowledge worker, che sono esperti di tecnologie, di web, di computer, di software, di informatica che hanno la possibilità di ampliare e potenziare la loro capacità di lavoro indipendentemente da dove si trovano.
Un caso emblematico è rappresentato dal dibattito attualmente aperto negli USA (il cuore di tutto questo, checché se ne dica, è ancora lì, e neanche in tutti gli Stati Uniti, ma nella Silicon Valley, più qualche altra isola nel New England dove sta l’IBM e nel Texas dove stanno la Compaq e la Dell).
In questo momento nella Silicon Valley c’è una domanda di lavoro assolutamente inferiore all’offerta. Più del 50% degli sviluppatori di software non è americana; in gran parte si tratta di indiani (non pellerossa, indiani dell’India) che per vari motivi sono tra quelli più adatti a questo tipo di lavoro. E il dibattito è: come gli diamo il visto, come li facciamo stare in America più di sei mesi, più di quello che è previsto dal permesso di soggiorno? Le aziende si contendono questi lavoratori a suon di migliaia di dollari. Ed altri esempi si potrebbero fare in relazione a sviluppatori di software che vengono dal Pakistan e da altri paesi.
C’è poi il fenomeno definito creative distruction, distruzione creativa. Un esempio mi aiuterà a spiegare di cosa si tratta.
Nel 1975 il 33 – 34% dei lavoratori americani apparteneva all’industria, erano blue collar, oggi sono il 15%, nel 2020 saranno il 2%, anzi meno del 2%: di fatto si sta distruggendo una categoria di lavoratori.
Questa distruzione è però di carattere creativo perché l’80% di questi posti di lavoro nel 2020 saranno posti di lavoro legati alla informazione, legati alla informazione che deriva dall’innovazione tecnologica, creati dalla società tecnologica.
Distruzione creativa: si distruggono dei posti di lavoro, si distruggono delle fasi di processi lavorativi per crearne altri di altro tipo nello stesso luogo e spostare i precedenti processi lavorativi altrove. Si possono ovviamente fare altri esempi.
L’industria manifatturiera di PC in Europa sostanzialmente non esiste più a parte un po’ di assemblatori locali che non hanno probabilmente un futuro e ad alcuni gruppi legati a certi luoghi specifici. Penso all’Olivetti o alla Siemens, l’unica azienda europea che fa PC.
Tutti i posti di lavoro di PC in Europa sono scomparsi man mano e scompariranno sempre di più ma dal punto di vista globale questi posti di lavoro stanno ricomparendo altrove, a Taiwan, in India, a Singapore dove chiaramente il costo del lavoro è più basso, le aziende riescono a produrre a minore costo e riescono ad essere più competitive sul mercato.
Ancora una volta quindi distruzione creativa. E’ chiaro che chi perde il posto di lavoro in un determinato momento soffre in maniera tangibile (ancora una volta non sto dando un giudizio di valore ma spiegando che a fronte di tali sofferenze si creano dei vantaggi competitivi da altre parti); ed è altrettanto chiaro (o almeno dovrebbe esserlo) che coloro che operano sul territorio, (non sto parlando necessariamente di Stato, sto parlando di imprenditoria, di forze economiche) devono essere sufficientemente veloci da pensare come sostituire questi posti di lavoro con altre opportunità.
Tutti ad esempio sanno che in Italia gli impiegati delle poste sono più del doppio di quelli necessari, però continuiamo a mantenerli anche perché se licenziassimo ci sarebbe un impatto sociale assai consistente. Cosa sta facendo il ministero delle Poste o L’Ente Poste per far si che questi posti nel medio periodo diventino produttivi? Come intende affrontare i prossimi anni nei quali l’e-mail pian piano eliminerà la necessità di avere un ufficio postale sotto casa?
Personalmente non scrivo più una lettera da chissà quanto tempo, senza perdere l’abitudine di scrivere, perché la maggior parte delle persone con cui comunico hanno un indirizzo e-mail.
Ma guardiamo ancora una volta la faccenda in termini di grossi aggregati.
Se il ministero delle poste fosse un azienda legata comunque alla necessità di fare profitto e quindi forzata all’innovazione avrebbe una strategia tale per cui trasformerebbe una parte di questi lavoratori da postini ad esperti di e-mail.
E’ un esempio paradossale, che illustra però efficacemente quali meccanismi guidano l’innovazione tecnologica, l’accelerazione di questi processi che portano a sostituire i posti di lavoro distrutti dalla creative distruction.
E vengo alla promessa di interconnettività globale.
Parlo di promessa perché siamo ancora letteralmente agli albori, Internet è all’infanzia, neanche all’adolescenza, e quello che succederà attraverso Internet non riusciamo ancora ad immaginarlo compiutamente.
Ritorno per un attimo all’esempio delle poste.
Ho fatto recentemente visita all’amministratore delegato delle Poste Svizzere, che hanno fama di essere assai efficienti. Questo signore mi ha spiegato che la sua strategia prevede la creazione, lo stanno già facendo, del supermercato Internet delle poste.
Il suo ragionamento è più o meno il seguente: “sono il miglior trasportatore di pacchi in Europa, il miglior trasportatore di prodotti e di lettere anche perché ho l’infrastruttura di base per farlo. Mi creo il sito Internet, do la possibilità di accesso a tutti i produttori di libri, di dischi, di cibo, di pizza, e mi offro di trasportare i loro prodotti agli utenti che li ordinano”.
Vi assicuro che questi signori stanno portando avanti questo progetto in maniera molto seria e saranno loro i competitori della famosa Amazon di cui parleremo dopo.
Internet è ancora alla sua infanzia, però se poi ci metto il Ministro delle poste inglesi, quello delle poste francesi e quello italiano è evidente che gli affari su internet sono destinati ad ampliarsi considerevolmente (vedremo più avanti delle statistiche sul mercato italiano di vendita di beni e servizi sulla rete).
Un’altra grossa industria, un altro grosso settore che sta sfruttando Internet al massimo è quella dello spettacolo, dell’entertraiment.
Negli Stati Uniti in questo momento non si parla d’altro, oltre che della guerra del Kossovo, del fatto che la Lucas Film, produttrice di Star Wars, sta per irrompere nelle sale cinematografiche con il suo Star Wars IV.
Il film uscirà sugli schermi il 17 di Maggio e tutti stanno prenotando i biglietti in anticipo: ad oggi tutte le sale cinematografiche sono occupate e non si riesce a prenotare un biglietto fino al 25 di giugno. Ebbene, la Apple ha fatto un accordo con la Lucas Film che ha portato allo sviluppo del trailer su tecnologia Quik Time. Apple e Lucas Film hanno poi annunciato che chi lo desiderava poteva scaricare il trailer, ai miei tempi si chiamava provino, di Star Wars IV, collegandosi ai siti della Apple e della Lucas Film: nel giro di 20 giorni ci sono stati dieci milioni di download. Questo significa 10 milioni di persone almeno che si sono collegate ad internet ed hanno scaricato, (tale operazione, secondo la velocità del modem, poteva durare anche di 30 minuti) il trailer di Star Wars IV.
Tutto questo non fa altro che invogliare la gente ad andare a vedere il film (Star Wars IV molto probabilmente batterà Titanic in termini di biglietti venduti e quindi di fatturato). E torno a sottolineare che siamo nell’infanzia di Internet.
Nel futuro prossimo venturo avremo nuove forme organizzative degli spazi, una nuova competizione fra forze di coesione e di frammentazione.
Internet può portare coesione a livello di club, di circoli culturali, di persone all’interno di una stessa nazione o di più paesi, di uno o più sistemi, una o più scuole; Internet può essere un modo per creare contenuti e migliorare l’accesso a questi contenuti, fornire strumenti importanti per la didattica.
Assieme a questi aspetti che favoriscono la coesione però, se tornate sul satellite che guarda sulla terra, vi accorgerete che Internet crea frammentazione perché chi non appartiene alle élites di chi la può e la sa usare viene ulteriormente emarginato.
Non intendo ovviamente dipingere scenari pessimistici o negativi, tutt’altro. Ho letto che Cofferati nell’altra lezione citava Blade Runner. Ecco, diciamo che siamo un pò più ottimisti di Blade Runner e che la colomba sicuramente alla fine vincerà. E’ sempre bene però avere presenti tutti gli aspetti del problema.
E vengo al superamento delle politiche nazionali.
Io leggo pochi giornali italiani perché sto poco in Italia, leggo Repubblica.it quando posso collegarmi al mattino e mi accorgo che sempre di più sulle prime pagine si parla delle nostre cosine: centro sinistra, centro destra, partiti politici ed altro. A mio avviso tra le nostre forze politiche manca del tutto la consapevolezza che tra un po’ di queste forze politiche come sono organizzate adesso non gliene fregherà niente a nessuno perché saranno le forze politiche sovranazionali che alimenteranno e supporteranno gli sviluppi tecnologici.
Ancora una volta provo a fare qualche esempio. Internet sta creando un grosso problema nella sicurezza dei dati, quindi nella security: io mi collego ad una banca per trasferire dei soldi da un conto corrente ad un altro e ho paura che qualcuno più intelligentemente di me può collegarsi, rubarmi il codice, trasferire i miei soldi sul suo conto corrente. Come risolvere questo problema?
La security non può evidentemente essere regolata da legislazioni nazionali e deve essere regolata da legislazioni sovranazionali che regolamentino gli standard, le tecnologie da utilizzare, i codici di encription ecc.
La proprietà intellettuale, i brevetti sono cose che su Internet sicuramente non faranno altro che aumentare le problematiche di adesso e quindi anche in questo caso ci vorranno interventi di carattere strutturale che andranno al di la delle forze legislative nazionali.
Un’altra problematica legata ad internet che richiederà interventi sovranazionali è quella legata ai problemi fiscali. Io ho comprato sul sito amazon.com due cd che non trovavo in Italia. Mi sono arrivati nel giro di una settimana e non ho pagato IVA. Sia chiaro che sono arrivati in dogana e che in dogana arrivano circa 500 mila pacchi al giorno con caratteristiche di questo tipo.
Chi importa dovrebbe pagare l’IVA al 20% ma per lo Stato Italiano la gestione della transazione per 500 mila pacchi al giorno di questo tipo sarebbe assolutamente diseconomica.
Tutto questo ci porta alla necessità di uniformare la tassazione sul valore aggiunto (in Europa non c’è paese che abbia la stessa aliquota IVA e si va dalla Svizzera che ha il 6% alla Svezia che ha il 25%).
Stiamo chiaramente andando in una direzione sovranazionale e l’Unione Europea è una delle forze destinate a contare sempre più. L’Unione Europea dovrà a sua volta decidere assieme ad altre forze equivalenti a livello mondiale e quindi l’abbattimento delle barriere date dalle politiche nazionali è incredibilmente visibile (è probabile che ciascuno cerchi di difendere il proprio orticello, ma ad un certo punto arriverà l’ondata che spazzerà tutti quelli che non se ne sono accorti).
Ma quali sono le tendenze e gli sviluppi che ci possiamo attendere?
L’innovazione porta allo sviluppo tecnologico, lo sviluppo tecnologico porta alla crescita, la crescita porta all’innovazione: è un circolo assolutamente virtuoso. Può apparire banale ma è quello che sta accadendo in questo momento.
Di che cosa ha bisogno l’economia globale in questo momento per permettere alla gente di arricchirsi? Fatemi passare il termine ma in questo momento il trasferimento di ricchezza è ciò che genera la crescita che a sua volta genera innovazione e sviluppo tecnologico.
E’ in atto una grossa crescita dei settori caratterizzati dall’innovazione. Quando una società di PC cresce del 2% il titolo di questa azione crolla perché Wall Street dice, i mercati dicono “non hai una crescita tale che ti possa garantire di essere sul mercato”. Quando l’industria dell’auto cresce del 2% il titolo sale perché l’auto è un’industria matura con opportunità di crescita limitate (ovviamente anche nell’auto continua ad esserci innovazione ma è una innovazione che incide sulla sicurezza, sull’impatto ambientale, sulla comodità, sul design, ma che non genera crescita al di la di quella fisiologica). Nel caso dei PC la famosa legge di Moore è già stata superata e oggi nel mondo dei microprocessori si triplica la velocità e i costi vanno giù più del 50%.
C’è chi sostiene che tra non molti anni anche i settori legati all’innovazione, oggi ad alta crescita, diventeranno maturi, e saranno quelli che vendono contenuti a fare la parte del leone sui mercati mondiali. Personalmente ritengo che prima che questi settori abbiamo una crescita marginale più bassa passeranno ancora molti anni. Ma di certo le aziende che vendono contenuti cresceranno in maniera spropositata.
Chi sono le aziende che vendono contenuti? Amazon, Lycos, la CNN nella sua parte interattiva, i motori di ricerca come Excyte. Sono aziende che hanno legato la vendita di contenuti allo sviluppo della rete, e che oggi hanno quotazioni di borsa spaventose.
Amazon in borsa vale 10 volte più della Fiat nonostante non guadagni un singolo dollaro (forse comincerà a guadagnare qualcosa nel corso di quest’anno). Il mercato valuta le potenzialità di crescita, il fatto che Amazon ha ad oggi sei milioni di clienti. La conoscenza di questi clienti, la possibilità di capitalizzare su questi clienti e di creare ricchezza e fatturato è la valutazione di quello che in inglese viene chiamato intangible, l’intangibile, è la valutazione di borsa di queste aziende. (Mi sono riferito alla Fiat ma in verità Amazon capitalizza quando la General Motors).
E vengo agli scenari possibili.
Già dal 1987, lo testimonia un famoso filmato con computer parlanti e scenari avveniristici, la Apple aveva intuito ciò che sarebbe avvenuto nel duemila.
Le bande ad alta velocità che permettono la diffusione di voce e dati in maniera quasi immediata entro un paio d’anni saranno realtà. Il riconoscimento vocale (parlo ad un computer non scrivo sul computer) è ancora molto imperfetto, però anche in questo caso direi che nel giro di due, tre anni arriveremo a più che soddisfacenti capacità di riconoscimento vocale.
Il Personal Digital Assistent, la possibilità di avere un computerino senza tastiera e scriverci sopra è anch’esso dietro l’angolo, anche se prima che muoia la tastiera passerà molto tempo. Sono insomma tutte tecnologie che stanno venendo fuori in questo momento e che avranno una influenza assai positiva sulla nostra qualità della vita. Si lavorerà meno e meglio.
Almeno questo è l’augurio di tutti noi. E questo è un aspetto positivo dell’innovazione tecnologica. E veniamo finalmente all’Italia.
IDC Italia ha appena fatto un indagine sul ritardo italiano nella diffusione di internet: circa il 5% della popolazione italiana è collegata ad internet contro un 30% di paesi come Finlandia, Svezia Norvegia.
Cosa possono suggerire questi dati? Probabilmente che nei paesi nordici fa freddo, fa buio prima, ci si annoia e ci si collega ad Internet mentre nei paesi mediterranei c’è molto più da fare, si va di più al ristorante, si resta fuori fino a tardi (non è assolutamente un modo stupido di interpretare questi dati; in Finlandia c’è anche la più alta diffusione di cellulari di tutta l’Europa e non a caso la Nokia è finlandese. Ci sono dunque caratterizzazioni di clima che implicano caratterizzazioni sociali che alimentano le caratterizzazioni dell’industria, che creano sicuramente fattori sociali). Ma anche che il nostro Paese è in ritardo. Un ritardo che però è destinato ad essere recuperato.
Ci si aspetta che in Italia nel 2002 avremo il 21% della popolazione collegato ad Internet che è più o meno il dato di adesso di Olanda e Danimarca e sicuramente quello tra i paesi più progrediti. I tassi di crescita saranno dunque vertiginosi nei prossimi anni.
Ma perché la gente si collega ancora poco ad Internet? Per tre motivi principali.
Innanzitutto perché in Europa costa molto di più rispetto agli Stati Uniti, dove uno paga 20 dollari ad AOL o ad altri però la telefonata è gratis. Le telefonate locali negli Stati Uniti sono gratis, all’interno dei prefissi non c’è la TUT, lo scatto a tempo.
La stessa cosa non accade in Europa. Il paese più costoso per le chiamate locali è l’Inghilterra, stranissimo a dirsi, il secondo è l’Austria il terzo è l’Italia. Il pese meno caro in Europa dal punto di vista dei collegamenti locali è la Spagna.
Il secondo dato che impedisce lo sviluppo di Internet sta nel fatto che in Europa solo il 12% delle famiglie ha un computer.
Il terzo è dato dal fatto che la gente non si sente ancora del tutto sicura, e pensa che sia molto difficile e complicato utilizzare il computer e internet.
Il concetto di base delle nuove tecnologie, l’iMac ne è l’esempio lampante, è abbattere le barriere di utilizzo. Usare un computer è ancora per molte persone difficile. L’obiettivo delle nuove tecnologie è far si che usare un computer sia facile come usare un telefonino: migliorare le interfaccia utenti, migliorare e semplificare l’uso del computer, abbattere i costi, questa è la continua sfida (l’eccesso di offerta rispetto alla domanda sta portando ad un abbattimento dei costi incredibile, presto si arriverà ad avere i computer a 400 – 500 mila lire).
E vengo al tema Internet e globalizzazione.
La globalizzazione ed Internet hanno creato una nuova lingua franca che è l’inglese. Chi non sa l’inglese è tagliato fuori. La diffusione dell’inglese è un fenomeno culturale che va riconosciuto, (anche se la campagna think different in Francia per legge è dovuta diventare pensée differentment). Quello che si sta sviluppando è tra l’altro un inglese maccheronico come il latino del medio Evo. Io sono italiano e parlo inglese, i miei colleghi sono europei ma non di lingua inglese e parliamo inglese tra di noi, ci capiamo benissimo però la maggior parte di noi parla un inglese maccheronico, e questo sarà un fenomeno di portata sociale e culturale di portata devastante.
L’Inglese diventerà una lingua contaminata da tutte le inflessioni, gli idiomi, le caratterizzazioni locali. Ci saranno un inglese maccheronico ed un inglese puro.
Per quanto riguarda le attività svolte dagli utenti, la ricerca IDC ci dice che l’utilizzo più ovvio è la ricerca di un argomento o di un articolo, l’utilizzo meno ovvio, stiamo parlando dell’Italia, è l’utilizzo delle attività bancarie, perchè ci sono ancora problemi di security.
Il 35% ha visitato siti dedicati agli adulti, e poiché questo 35% ha ammesso di averli visitati il dato reale è sicuramente più alto (purtroppo la diffusione della pornografia verrà assolutamente facilitato da Internet). Tutti gli altri utilizzi portano verso il commercio elettronico.
Stiamo parlando di un mercato che oggi è di 5 – 6 miliardi di dollari, che nel giro di due anni arriverà a circa 223 miliardi di dollari.
In realtà in questo momento l’e-commerce ed internet sono ancora un fenomeno di carattere americano. Se qualcuno di voi va negli USA per turismo non vedrà altro che pubblicità “.com”.
E’ un fenomeno devastante: abbattimento dei costi, crescita di società che creano servizi su web, distruzione di posti di lavoro da una parte e creazione da un’altra, nuove possibilità di acquisto, comunicazione tutto sembra ruotare attorno ad internet.
Anche per quanto riguarda gli acquisti on line tra gli effetti più importanti vanno sottolineati l’abbattimento delle barriere nazionali (posso acquistare in paesi diversi e risparmiare perchè lo stesso prodotto in America o in Inghilterra può costare meno che in Italia), assieme alla facilità dell’intero processo (ho bisogno di qualcosa che non so dove trovare mi collego al web e con un motore di ricerca la trovo), alla velocità, alla disponibilità del prodotto.
Chi non segue questa tendenza rischia di essere tagliato fuori, se non oggi nel più vicino futuro.
Cosa si vende su internet? In primo luogo personal computer, prodotti per pc, libri, cd musicali, viaggi, biglietti aerei, prenotazione negli hotel, prodotti elettronici di consumo.
L’e-commerce porterà cambiamenti notevoli rispetto a tutti questi temi.
Avrei voluto parlare di Internet e delle tecnologie di internet nel campo dell’educazione, dove come Apple siamo molto attivi e lo dimostra tra le altre proprio l’esperienza della scuola elementare di Ponticelli. Ma forse conviene che per ora mi fermi qui, non prima però di aver ribadito che le anche per quanto riguarda l’education le tecnologie già oggi disponibili offrono enormi possibilità. Il punto è trovare il modo di renderle sempre più accessibili, abbattendone i costi oltre che continuare a migliorarle. Vi ringrazio molto per l’attenzione.

Napoli, 21 Gennaio 2000
Chi di voi usa abitualmente internet? Chi la considera un occasione per migliorare la propria vita?
Le vostre mani alzate dimostrano ancora una volta che c’è una aspettativa straordinaria intorno alla rete; e intorno a tutto ciò che essa può determinare in termini di innovazione e di miglioramento economico, sociale, culturale.
I dotti parlano di un nuovo paradigma, di nuova visione del mondo, di nuova visione culturale. E ciò significa che cambiano le cose, la percezione che abbiamo di esse, i significati.
Perché una cosa che ha un determinato significato in un paradigma ne assume un altro in un nuovo paradigma.
Vale per tutte le cose. Se ad esempio l’economia napoletana vive una certa condizione, ha un certo significato, in un paradigma, quella stessa economia assume altro significato nel nuovo paradigma.
Su “Il Sole 24 Ore” Antonio D’Amato commentando un accordo con la Nortel, azienda canadese, ha detto che “l’evoluzione delle nuove tecnologie potrebbe azzerare o almeno ridurre il gap economico tra il Nord e il Sud”.
Su questo punto tornerò più avanti ma l’idea di mettere in relazione in modo nuovo i Nord e i Sud è stata in fondo una delle ipotesi con le quali è partita AustroeAquilone, che oggi è un sito visitato e interessante: cos’è AeA se non il Sud e il Nord che si connettono in modo nuovo grazie al boom delle nuove tecnologie?
Perché in effetti nel nuovo paradigma qualcosa di significativo accade.
Accade ad esempio che le distanze diventano molto meno rilevanti, dato che ciò che viaggia nella rete viaggia immediatamente da un posto all’altro del mondo. E conseguentemente anche dal punto di vista del tempo cambiano abbastanza le cose perchè tutto quello che relativamente al tempo dipende dallo spazio viene infatti annullato.
Accade soprattutto che dal punto di vista economico c’è il crollo del valore delle cose e l’esplosione del valore dell’informazione che sta intorno a quelle stesse cose.
E’ del tutto evidente infatti che oggi una maglietta non “vale” quasi niente in termini di tessuto. Il valore della maglietta, così come di qualunque altra cosa che compriamo in un negozio di abbigliamento, è determinato dall’informazione, dall’immagine, dalla firma che ad essa è connessa. La maglietta diventa insomma essa stessa un mezzo di comunicazione.
In effetti quasi tutto ciò che conta è un mezzo di comunicazione; quasi tutto ciò che vale nelle cose è l’informazione che è connessa ad esse.
E se l’informazione è valore aggiunto, se l’informazione è immateriale, se l’informazione ha un senso solo nel momento in cui viene comunicata è evidente che in un mondo in cui le nuove tecnologie trasformano l’informazione in una cosa che viaggia immediatamente da una parte all’altra del mondo c’è la possibile esplosione di una nuova economia.
In estrema sintesi sono questi a mio avviso i connotati di partenza di quello che potrebbe essere il mondo nel nuovo paradigma.
Con una ulteriore, rilevante, differenza: questa nuova informazione, questo nuovo tipo di tecnologia, non si subisce come quella che era prevalente nel vecchio paradigma.
Nella società di massa, taylorista, quella della televisione, del broadcasting, in buona sostanza questa informazione veniva subita da chi la recepiva. Non c’era molto spazio per “fare”. Al più si cercava di conquistare un posto, di essere una rotella del meccanismo, di essere assunti da una organizzazione – quotidiano, settimanale, TV o radio che fosse- che stesse dentro il meccanismo. E tutto quanto di informazione e di partecipazione si metteva dentro il prodotto che veniva fuori da questo tipo di sistema economico sociale, era una cosa che qualcun altro ci diceva di fare, che qualcun altro – un direttore, un caposervizio o quant’altro – ci diceva di mettere nel prodotto.
Nel nuovo paradigma c’è invece molto da fare. C’è molta informazione personale da aggiungere. Molta informazione personale da chiedere.
Se c’è una caratteristica del tutto evidente di questa nuova economia è che essa spinge i giovani, le persone che hanno un’idea, a realizzarla.
Chi è premiato nel nuovo paradigma? Emerge ogni giorno dai giornali.
Oggi Mediaset ha comperato la GSMBOX, un’azienda fondata da due ragazzi che si sono appena laureati, Federico Bolonti e Giacomo Calafiore, i quali hanno portato a casa qualche miliardo perché Mediaset, il broadcasting, nel nuovo paradigma ha dovuto spendere un pò dei suoi soldi per comprare questo sito.
Cosa ha la GSMBOX di tanto particolare? Di per sé niente. Non è un prodotto. Non è una fabbrica. E’ un’impresa che ruota sostanzialmente attorno ad un computer di “pochi” soldi che però è riuscita, proponendo informazioni, scambi di idee, tra i fanatici del telefonino, a costruire una comunità di un milione di persone.
Persone che si collegano a questo sito e si informano sul telefonino, sulle nuove suonerie, sul come si fa a mandare gli SMS. Con un’ultima trovata, niente male: se registri il tuo numero e sei appassionato di una certa squadra di calcio, durante la partita ti vengono inviati sul telefonino alcuni messaggi che ti dicono in tempo reale se ha segnato la tua squadra, se ha preso un gol, se ha vinto o ha perso.
Questo genere di trovate possono sembrare poco rilevanti ma in realtà si tratta di tecnologia utilizzata per offrire un servizio a chi ha un determinato interesse informativo e quindi va presa con tutto il rispetto.
Cosa è successo dunque? Che alcune proposte informative e un computer connesso ad Internet sono diventati per due ragazzi che si sono appena laureati un modo per guadagnare qualche miliardo e per Mediaset un pezzo di una strategia per entrare nella nuova economia.
E questa secondo me è l’ennesima esemplificazione della nuova mitologia che tendenzialmente prevale nel nuovo paradigma: se non ho soldi, non ho particolari agganci, non ho un posto di lavoro, non ho un aiuto, non so quasi nulla di come si sta nel sistema economico, ma ho un’idea, posso aggiungere la mia idea al sistema economico e ottenerne un risultato economico straordinario.
Che cosa significa tutto questo? Che l’economia in questo nuovo paradigma è fatta di informazione e tecnologia a basso costo, ha meno barriere, e ti spinge a partecipare.
Dal punto di vista dell’informazione ti spinge a partecipare perché ogni sito informativo ti chiede la tua idea in cambio.
Dal punto di vista del sistema economico ti spinge a partecipare perché il sistema economico ti dice che se hai un’idea la realizzi ed è possibile che ne porti a casa un risultato economico molto buono.
Dal punto di vista sociale ti spinge a partecipare perché ti spinge ad interagire (la parola chiave della rete), a creare delle realtà nelle quali partecipi.
Abbiamo fatto partire da qualche mese un sito che si chiama i nonni raccontano, ci sono anche qui diverse persone che vi contribuiscono, dove chiediamo ai nonni d’Italia di raccontare una favola o una storia vera della loro vita, della loro giovinezza, della loro memoria, ai bambini italiani.
Nel vecchio paradigma c’erano i nonni italiani che guardavano la televisione domandandosi che ci stavano a fare, e c’erano i bambini che prendevano le favole dalla televisione.
Per quanto segmentasse in target l’audience, la TV di fatto non spingeva a realizzare nessun tipo di partecipazione.
Invece nel nuovo paradigma una piccolissima iniziativa come la nostra dimostra che si può fare in modo che siano i nonni a raccontare le favole a bambini. Ci sarà più ricchezza in questo! Sarà più interessante il fatto che i bambini, piuttosto che guardare il telefilm giapponese con una densa quantità di pubblicità, sentano, leggano la storia di una persona vera che ha una memoria vera e che invece di disperderla nell’etere o tenerla per sé la racconta a delle persone che probabilmente se la ricorderanno per il resto della loro vita.
Dunque sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale il nuovo paradigma offre delle opportunità molto interessanti.
E la parola chiave in fondo è questa. Tutta la storia dell’informatica è costituita da momenti un cui c’è un innovazione e questa innovazione viene presentata da chi la produce con la frase tipica “Questa è un innovazione che consente di…”.
Internet, la rete, i nuovi media, il cablaggio, la nuova economia non fanno assolutamente niente per noi, salvo che darci un opportunità in più.
E’ evidente che le opportunità non sono niente finché non vengono colte. Così come l’informazione non è niente finché non viene recepita.
Quindi se io dovessi, e non sono la persona più qualificata per farlo, definire la questione meridionale oggi, piuttosto che dire, come fa Antonio D’Amato, che si azzererà la distanza tra Nord e Sud, direi che è importate la risposta meridionale.
Non più la questione meridionale, la domanda meridionale, ma la risposta meridionale. Poi possiamo discutere delle condizioni, delle barriere, dei vincoli. Ma questa è un opportunità, se la cogliamo. E la possiamo cogliere se abbiamo ben chiara la consapevolezza che va colta da noi, da voi, e che nessuno la coglie al posto nostro.
Io sono una persona ottimista. Ma questo non mi impedisce di vedere, assieme al bicchiere mezzo pieno, anche quello mezzo vuoto.
Il bicchiere mezzo vuoto viene dai dati che ci dicono che se prendiamo il totale del consumo di telecomunicazioni in Italia, (telefonate, telefonini, centrali, centralini, investimenti in computer connessi alla rete per Internet, ecc) e tagliamo l’Italia a Firenze, esclusa Roma quello che rimane vale il 10%.
E’ troppo poco. E ha come conseguenza il fatto che ci sono meno investimenti da parte delle imprese private nel cablaggio, nelle infrastrutture, nella connessione con i grandi circuiti di trasferimento delle informazioni.
A Milano ci sono 5 società private che, senza che nessuno gli abbia detto di farlo, stanno mettendo giù le fibre ottiche per le strade. Lo fanno perché la domanda è data per scontata: ci sono le grandi banche, le grandi filiali delle multinazionali, c’è un sistema economico che è considerato vivo.
Il sistema è abituato a pensare che la domanda a Milano ci sia e quindi investe senza problemi, anche se io che ci vado spesso vi posso assicurare che, al di là della depressione degli anni 90, della vitalità culturale, del turbinio di idee che si coglie venendo a Napoli a Milano non c’è traccia.
In ogni caso questo è un punto che va affrontato. Dobbiamo sapere che il cablaggio nel meridione deve avvenire secondo una logica diversa. E poiché è probabile che ci siano degli sforzi in questa direzione bisogna sapere che essi non avranno nessun effetto se non saranno visti e colti dai meridionali come una grande opportunità.
Possono mettere i cavi per le strade ma questo di per sé non determina niente se non il lavoro necessario per metterli giù. Ed è davvero troppo poco.
Più che aspettare l’iniziativa dall’alto occorre partire dal basso. Provare a fare. Certo, quando si parte da una condizione di ritardo bisogna affrontare una serie di fatiche in più. Però nel nuovo paradigma ci sono anche delle opportunità in più.
La situazione è cambiata non nel senso che abbiamo risolto il problema del Sud, o delle altre aree “deboli” (non bisogna dimenticare che il Sud è un posto estremamente fortunato rispetto ai posti dai quali vengono i nostri immigrati oggi) ma se è vero che permane una situazione di “arretratezza” è anche vero che oggi sono possibili soluzioni nuove. Più abbordabili. Che si possono cogliere in maniera precisa individuando il proprio spazio nella nuova economia.
La questione meridionale deve diventare dunque la risposta meridionale. Perché le opportunità non sono niente se non si colgono.
L’informazione è il centro fondamentale nella nuova economia e l’informazione nel Sud c’è. Si può trattare. E’ una materia prima che il Sud è preparato ad usare. Le vere risorse sono oggi il capitale umano, l’intelligenza, i cervelli, e nel Sud ci sono.
Sono stato ad una riunione all’Assolombarda (l’associazione degli imprenditori della Lombardia), che intende lanciare un programma per lo studio di quelle che loro chiamano Skilled – shortage (in Lombardia c’è questo dialetto). In Lombardia mancano infatti le professionalità; uno dei vincoli allo sviluppo di quella regione è la non adeguata presenza di professionalità adatte a lavorare nella nuova economia, in internet.
Nel Sud queste professionalità ci sono. Ed il laureato in Lettere che si preoccupa di non trovare il posto nella scuola non si rende conto di avere, nella nuova economia, un valore enorme, perché sa trattare la cultura, le conoscenze.
Allora il vincolo da superare non è nemmeno quello della formazione di base, non è neanche tanto quello di imparare ad usare il computer perché quello sono certo che diventerà sempre più facile. Quello che è veramente rilevante è la capacità di trasformare quello che noi sappiamo fare, quello che sappiamo, in capacità di trattare l’informazione, dandogli valore aggiunto.
Ho proposto all’Assolombarda: organizziamo una osservatorio sulle professionalità, facciamolo sapere nei posti dove le professionalità ci sono e cerchiamo di far lavorare da lì le persone, senza cambiare la loro localizzazione.
Sì, penso a quello che si chiama telelavoro, a forme organizzate di collaborazione, anche imprenditoriale. Le persone che lavorano da Napoli per una azienda di Brescia come dei dipendenti in telelavoro, potrebbero essere dei partner allo stesso livello anche dal punto di vista imprenditoriale.
Su questo terreno si stanno determinando delle opportunità vere. Il caso della StMicroelectronics a Catania dimostra che si può fare.
Perchè Catania non è una città ricca di persone che costano poco ma è, come sostiene Pasquale Pistorio, originario di Agira (En), presidente della StM, ricca di cervelli. Che certo, avendo meno opportunità di essere impiegati rispetto ai cervelli di altri paesi del nord costano meno, ma non sta lì la differenza. La differenza sta nell’abbondanza di cervelli. E nelle forme nuove di collaborazione possibili tra Università, imprese, Enti Locali. E’ su questo terreno che Pistorio ha potuto vincere la sua sfida. E ha potuto trasformare un’impresa sull’orlo del fallimento in uno dei centri di eccellenza mondiali nella produzione di certi particolari chip.
Il punto ovviamente non è produrre microprocessori ovunque, ma produrre cose che contengono intelligenza.
Nel Sud l’intelligenza c’è. Va messa nel circuito. Si può fare. Anche perché oggi le persone contano assai più che nel passato.
All’università mi hanno insegnato che contano le strutture, la storia che ci portiamo appresso. Sono loro a dare il ritmo, la velocità, il tipo di accelerazione, la leggerezza con la quale andiamo verso il futuro: ebbene oggi, non so come sarà tra dieci anni, contano le persone più di tutto. Ed in questo quadro, non so fino a che punto siete d’accordo, osservo che il soggetto decisivo, l’elemento innovativo, è l’imprenditore, quello che ha l’idea.
Una società come la APPLE, fino a qualche anno fa pressoché allo sfascio, è risorta completamente nel momento in cui è arrivato un nuovo capo, che poi in realtà ne è stato il fondatore, Steve Jobs.
Ebbene oggi questa società ha aumento il valore delle azioni di 10 volte, ha un futuro straordinario, aumenta il fatturato e gli utili, e tutto grazie soprattutto ad una persona.
La risposta del Sud è affidata dunque in primo luogo a uomini e donne che hanno idee. Che intendono spendersi per metterle nel circuito. Per realizzarle. Per creare ricchezza. Lavoro.
Il Sud ce la può fare. Le storie di Pistorio, di Soru, di Crudele, (i guru di Tiscali e Finmatica) stanno lì a dimostrarlo. Sono storie di uomini del Sud. Un Sud che ha cominciato a rispondere nel modo giusto alle sfide della nuova economia.

| Napoli, 18 Febbraio 2000 Noto che, nonostante la presenza gradita ed amichevole di colleghi e di alcuni dei vostri insegnanti, l’età media in questa sala, grazie anche al fatto che i vostri insegnanti sono davvero giovani, è sui vent’anni, e questo mi riporta alla mente il rapporto che avevo alla vostra età con coloro che avevano allora la mia e venivano a parlare nella mia scuola: avevo come l’impressione di sedere sul bordo di un’autostrada e di veder passare un’automobile, un veicolo, un pullman, che andava da una parte all’altra, che veniva da una sua direzione e andava in una sua direzione. Avevo insomma l’impressione di assistere a qualcosa che non mi riguardava direttamente. Io vorrei invece che voi provaste, spero davvero che lo facciate con le domande che mi farete ad un certo punto, ad intercettare il veicolo, ad evitare che vi passi di fianco mentre viene da un punto per voi indifferente e va verso un punto a voi indifferente. Spero insomma in qualche modo che ci sia, nel corso di questa mattinata, qualche istante nel quale le nostre vite, la vostra e la mia, possano avere un’utilità reciproca, possano lasciarsi vicendevolmente un piccolo segno. Nella presentazione che Moretti ha fatto di me e del mio lavoro si è detto di questo libro, La vita imperfetta, al quale farò riferimento, parlando con voi oggi, non tanto o non soltanto perché di solito chi ha scritto un libro ama parlare del suo libro (non è questo il pensiero principale che ho in questo momento rivolgendomi a voi e pensando come trasmettere da me a voi un piccolo frammento di esperienza) quanto perchè vorrei tornare su quel titolo e chiarirlo. E’ infatti perfettamente naturale per ognuno di voi, nel processo di vita familiare, così come in quello scolastico o come quello a cui incominciate a pensare relativo al mondo del lavoro, pensare alla divisione tradizionale, quella che tanto frequentemente ricorre nell’esperienza educativa, fra perfetto, cioè qualcosa che funziona, che va bene, e imperfetto, cioè qualcosa di inadeguato, di inadatto, di non formato. Ebbene, quando ho pensato a questa espressione, la vita imperfetta, ho ripensato ad esperienze della mia vita in particolari momenti storici, alcuni vicini, vicini anche a voi, altri molto lontani e per fortuna fisicamente ignoti alla vostra esperienza. E il modo in cui mi sentirete usare questa espressione, o, per quelli di voi che hanno avuto tra le mani il libro, me la hanno vista usare nelle pagine del libro, sarà per sostenere che la vita imperfetta non è solo la vita che ci aspetta, ma è una vita dignitosa, interessante, avventurosa e che non teme confronti con sogni e progetti che, per l’avere voluto essere perfetti, sono stati anche sogni e progetti di morte. Se c’è un’immagine che mi viene in mente mentre mi trovo con voi qui è l’immagine di un’altra Aula Magna, un mattino di tanti e tanti anni fa, in una scuola elementare e media di Torino, la mia città, in un periodo della mia vita in cui ero bambino e in cui, nonostante l’appartenenza ad una famiglia molto viva, molto presente nella discussione politica e nei fatti quotidiani, in realtà la scuola era il contenitore principale della mia vita, delle mie avventure, della mia esistenza di bambino. Quel giorno siamo stati radunati, siamo stati fatti sedere come voi qui, ma tanto più piccoli, con gli insegnanti tutti seduti in prima fila. E quel giorno è accaduto un fatto che poi ho rivisto in forma comica e giustamente denigratoria ne “La vita è bella” di Benigni: è arrivato a scuola l’Ispettore della razza. E’ salito sulla pedana di fronte a noi bambini, il direttore didattico seduto al centro e tutti gli insegnanti seduti in prima fila, e dopo aver espresso una sua teoria del tutto misteriosa e oscura sul sangue infetto di alcuni e sulla razza pura di altri, l’aurea e perfetta razza italiana, ha preso un elenco e ha cominciato ad indicare i nomi dei bambini che avrebbero dovuto lasciare la scuola, che avrebbero dovuto uscire per sempre dalla scuola. I ricordi che mi sono rimasti di quel giorno sono due. Il primo è questo gesto di follia, che allora vedevo soprattutto come un evento incomprensibile. Tanto più incomprensibile perché gli insegnanti seduti in prima fila non si sono mai voltati a guardare i loro bambini che uscivano, che lasciavano la scuola per sempre. Non si sono mai voltati neppure per salutarli, benché si trattasse di un viaggio che era destinato a continuare molto a lungo e che per quasi tutti loro era destinato a finire nel modo in cui avete appreso da tanti libri e da tanti film. Il fatto è che quegli educatori, che avevano il compito e la responsabilità di educare quei bambini, e questo per me è rimasto il mistero più grande, il punto di impressione più forte, più drammatico, non si sono voltati perché non avevano niente da dire, non avevano una loro vita morale e intellettuale con la quale interferire su ciò che stava accadendo. Per me è difficile dimenticarlo biograficamente, ma è difficile anche non vedere a distanza di tanto tempo il senso vero di quanto era accaduto: a parte la viltà, a parte l’assenza di coraggio, a parte l’incapacità di lasciare un segno nella propria esistenza e nell’esistenza di altri, il fatto è che c’è stato una fase, in questo secolo, in cui qualcuno ha davvero creduto, assurdamente e orrendamente, persino in buona fede, che ci potessero essere definizioni perfette dell’essere umano, della sua provenienza, delle sue caratteristiche Proprio così. Si misuravano persino i crani. Si misurava la distanza del mento dal naso, dal naso dalla fronte e della nuca dalla fronte. Certo, visto a freddo e da lontano appare soltanto un esercizio di follia. Ma è una follia che è potuta passare attraverso l’Europa, attraverso scienziati, attraverso intellettuali, attraverso classi dirigenti, attraverso grandi borghesie italiane ed europee. Che si è nutrita dell’idea che ci potesse essere una definizione perfetta del chi siamo, da dove veniamo, con quale cultura ci siamo nutriti, da quale ambiente siamo stati formati. E che al di là della perfezione c’è un taglio. Ed oltre il taglio la morte. Voi capite che da un’esperienza di questo genere non può che generarsi un senso avventuroso e simpatico dell’espressione “vita imperfetta”, nella quale si può trovare lo spazio dell’avventura, della vita, della realtà, il rapporto profondo che c’è tra noi e la natura con le sue infinite asimmetrie. La realtà è la concatenazione dei fatti reali più perfetti e più imperfetti che ci siano. Fatti che si distruggono, si rigenerano, si ricreano, e non sono mai esattamente ciò che da ciascun frammento della natura ti aspetti. Sono sempre una sorpresa. E proprio l’elemento sorpresa, l’elemento fatto nuovo, l’elemento rivelazione, l’elemento trasalimento, l’elemento imperfezione è il capolavoro, è il patrimonio della vita. Mi sposto di molti anni e vi porto con me mentre varco la soglia del piccolo ufficio nel retro di una piccola chiesa nella città di Atlanta, in Georgia. Siamo tra la fine degli anni 50 e l’inizio degli anni 60, e sta nascendo negli Stati Uniti il movimento dei diritti civili. In quel periodo attraversavo in lungo e in largo gli Stati Uniti scrivendo per giornali italiani e facendo i primi documentari, i primi servizi per la televisione. Avevo letto sui giornali di New York di questo pastore di una chiesa Battista di nome Martin Luter King che aveva un comportamento così anomalo, così irritante per l’ordine pubblico americano: aveva deciso infatti di non tollerare più che i negri fossero esclusi dalla vita pubblica, dalla vita elettorale, persino dalla possibilità di bere alla stessa fontana o di alloggiare allo stesso albergo dei bianchi. Quando sono andato a trovarlo per la prima volta mi sono trovato di fronte ad un uomo giovane: aveva esattamente la mia età, non era una celebrità, non era il premio Nobel per la pace, non era l’uomo che tutto il mondo ha conosciuto, non era l’uomo che sarebbe stato assassinato a Memphis il 4 Aprile del 1968. Era “solo” un giovane uomo ostinato. Che sapeva benissimo che si stava cimentando in una impresa che quasi tutti avrebbero considerato impossibile. Proprio così. La società americana, con tutta la sua ricchezza, con tutta la sua potenza, aveva questo problema terribile, la segregazione razziale, che continuava a portare con sé. Non era infrequente sentir dire “beh, ma in fondo l’importante è convivere; certo ci sono delle diversità; bisogna avere pazienza”. Ma il pastore di questa chiesa del Sud, che avrà avuto una congregazione di fedeli non più grande di quest’aula e che di certo aveva una chiesa più piccola (era la metà, lo ricordo benissimo), aveva deciso di non accettare lo stato di cose esistente. E aveva al contempo capito quale grave errore sarebbe stato quello che era già stato fatto da altri leader neri prima di lui e che sarebbe stato fatto di nuovo da altri leader neri dopo di lui: quello di definire un ordine nel quale la perfezione era data dal movimento nero, dalla nazione nera da opporre alla nazione bianca, magari anche con le armi. Ciò che proponeva M.L.King era invece una affermazione dei diritti che si basava sulla vita di tutti i giorni: si andava in un posto e si diceva “non accettiamo discriminazioni”; si andava in un ristorante e si diceva “noi ci sediamo qui anche se voi avete deciso che qui ai neri i pasti non vengono serviti”; si andava alle fontane e si beveva dicendo “noi beviamo qui anche se c’è scritto che i neri e i cani a questa fontana non possono abbeverarsi”; si andava nei bagni e si usavano anche se c’era scritto for white peoples only; si andava negli autobus e ci si sedeva di fronte anche se la regola allora era che i neri dovessero sedersi nella parte posteriore dell’autobus. Forse qualcuno di voi ricorderà chi era Rosa Park. Rosa Park era una donna di servizio che lavorava nelle case dei bianchi e che per tornare a casa doveva prendere tre autobus per raggiungere la sua periferia nera e segregata. Rosa Park, che io ho conosciuto perché era una delle parrocchiane di M. L. King, è la persona che da sola ha dato inizio all’intero movimento dei diritti civili. Una sera, tornando stanca dal lavoro salendo sull’autobus e trovando un unico posto libero davanti, si è seduta. E quando il manovratore le ha detto “guarda che il tuo posto non è qui, devi andarti a sedere dietro”, lei ha risposto “mi dispiace, dietro non c’è posto, sono stanca, resto seduta qui”. L’autobus si è fermato, i bianchi “inveivano” indignati, è arrivata la polizia, Rosa Park è stata arrestata ed è nato così il movimento dei diritti civili che ha cambiato un paese. E non dimenticherò mai in che termini M. L. King lo narrava già allora, da persona sconosciuta, da persona conosciuta solo da coloro che andavano lì a conoscerlo e a partecipare con lui alle marce dei diritti civili. Lui diceva: “la mia dignità esiste in quanti riconosco la dignità degli altri. La dignità degli altri esiste in quanto riconoscono la mia. Il movimento dei diritti civili non è un movimento per l’affermazione dei diritti dei neri, è un movimento per l’affermazione dei diritti di tutti perché nel momento in cui miei diritti mi vengono negati i bianchi denigrano la propria identità, si mettono in condizione di sminuire il valore delle proprie vite perché sminuiscono il valore delle vite di altri esseri umani. Noi siamo impegnati a restituire la piena dignità a tutti coloro che non riconoscono la nostra piena dignità. Il lavoro è reciproco. Noi per gli altri gli altri per noi. Non esiste nessun altra soluzione che non sia insieme”. Dove sta la grande differenza tra ciò che ha fatto M.L.King è ciò che hanno fatto altri leader (qualcuno di voi ricorderà Malcom X, i mussulmani cosiddetti islamici neri, potere nero, le pantere nere)? La qualità della rivoluzione dei diritti civili è stata nella sua capacità di espandersi infinitamente, di toccare tutti i nervi che contano nella vita della società americana, di conseguire costantemente risultati e di rendere la vita sempre più vivibile benché largamente imperfetta. Una cosa succedeva molto bene qui e maluccio là; un’altra riusciva in pieno in un luogo e non riusciva in un altro. Ma nel momento stesso in cui insieme uomini e donne, uomini bianchi e uomini neri, soprattutto giovani e giovanissimi bianchi e neri insieme affermavano lo stesso impegno, nascevano le cellule di un nuovo corpo, di un nuovo paese, di una nuova cultura, che non sarebbe stata solo americana ma che sarebbe stata del mondo. Ancora oggi, sui giornali italiani se ne parla poco, su quelli USA molto di più, la revisione di tutti quei casi di desaparecidos nell’America Latina, Argentina e Cile in primo luogo, di persone fatte scomparire dalle polizie segrete militari, porta alla luce un fatto: molti di loro erano americani, giovani americani che erano andati in quei paesi per battersi per la libertà di quei paesi. Alcuni di voi ricorderanno un film con Jack Lemmon che aveva un titolo in inglese che credo sia rimasto anche nella versione italiana, Missing – perduto -sparito, ed è la storia di un padre che va alla ricerca del figlio nel Cile di Pinochet. Il padre è un conservatore, e il figlio è un ragazzo dolcemente rivoluzionario e fraternamente deciso a sostenere i ragazzi cileni perseguitati dalla polizia di quel paese. Il padre si trova contro l’ambasciata del suo paese, gli addetti militari del suo paese, e lungo questo processo incontra tutto una rete di laici, di religiosi, di donne e di uomini, di anziani e di giovani che stanno rischiando la vita per la libertà di quel paese e che lo fanno in quel modo imperfetto che è il reclamare ed affermare appassionatamente un dovere e nello stesso tempo sapere che quello che ne nascerà non sarà il paradiso ma soltanto una condizione di dignità e di libertà. Mi sposto ancora nel tempo, non tanto, e vi parlo di un uomo che è diventato due anni fa premio nobel per l’economia. E’ un filosofo – economista indiano, precisamente del Bengala, Amartya Sen. L’ho incontrato per caso, perché per un anno mi sono trovato ad insegnare nella sua stessa università, l’Università di Haward, nella quale Sen ricopriva una posizione singolarissima: aveva la cattedra di filosofia morale e, separatamente, la cattedra di economia. Di lui non avevo ancora letto nulla, ma la “stranezza” non poteva non attrarre, perché gli economisti, specialmente nella tradizione americana, sono persone legate al fattibile, al realistico, al ciò che si può davvero fare e misurare. E come se non bastasse Amartya Sen in quel periodo era il Presidente dell’associazione degli economisti americani che, lo ripeto, sono persone senza grilli per la testa, abituate ad andare al sodo, persone del tipo “i numeri sono numeri, una cosa o tiene o non tiene, si può fare o non si può fare, i numeri ci danno torto e i numeri ci danno ragione”. Eppure era anche titolare della cattedra di filosofia morale ed era considerato in tutte e due le posizioni un guru, un vero maestro, in uno dei campus universitari più straordinari di quel paese. E Amartya Sen, prima ancora di raccontarlo, molto più tardi, quando diventa premio Nobel e deve fare il suo discorso all’Accademia Svedese di fronte ai grandi della cultura del mondo, mi ha raccontato come è diventato economista e filosofo. E’ il 1945, prima di quella famosa mezzanotte raccontata da Salman Rushdie, che ha portato la libertà in India, in un villaggio del Bengala in cui egli è bambino e sta studiando in una scuola che è tipicamente una scuola dell’india coloniale di quel tempo: una tettoia di bambù, dei pali che la sostengono, i prati intorno e i bambini che studiano con i loro maestri. Di quella situazione Amartya Sen ricorda il relativo benessere: un’economia basata sui raccolti, che vanno abbastanza bene, una piccola famiglia, la sua come quella degli altri bambini coltivatori diretti, una quantità di terra adeguata, e la bontà della natura che fa si che per quanto lui ricordasse, aveva nove anni al momento dell’evento, aveva sempre dato dei buoni raccolti. Egli ricorda insomma di avere vissuto bene, come si può nella vita contadina. Mentre sta a scuola quel giorno vede arrivare da lontano un uomo. Ha l’aria disperata. E’ emaciato, magrissimo. Sembra un fantasma che, camminando male, cadendo, rialzandosi viene verso la scuola perché è l’unico posto popolato che ha visto venendo chissà da dove. Entrato in quello stesso momento nella vista e nell’immaginazione del bambino Sen, l’uomo riesce ad arrivare fino alla tettoia della scuola. Quando l’ha raggiunta cade, stramazza per terra. Il maestro gli va vicino, lo tocca, gli chiude gli occhi, dice ai bambini: morto di fame. E avverte il villaggio perché lo portino via. Per il bambino Amartya Sen il problema è, e qui nasce l’economista: come può morire di fame in questo punto del mondo se io qui ho da mangiare. Come è possibile che lui non c’è l’abbia? Cosa è successo? Dove è avvenuta l’interruzione fra me e lui? Quest’uomo è qui fisicamente. Io sono qui fisicamente e so che oggi andrò a casa e ci sarà da mangiare. Perché lui non ha trovato da mangiare? Per Amartya Sen affrontare il problema in questi termini vuol dire affrontare il problema di una vita contadina dove si coltivano i campi, si semina, si lavora duro e ad un certo punto la natura provvede a restituire il raccolto e con il raccolto la gente vive. Questo almeno era il mondo e il ciclo economico che lui conosceva. Certo che c’erano dei ricchi ma lui non li aveva mai visti. Certo che c’erano le grandi città ma lui non le conosceva. Come poteva dunque una persona che apparteneva al suo mondo morire di fame accanto a lui che si sentiva circondato dal conforto? E la seconda domanda, quella che ha fatto nascere il filosofo, è: come è possibile che la dignità di qualcuno possa essere violata fino ad ignorarla e lasciarla morire, fino a permettere che qualcuno sia abbandonato ai bordi della vita come un oggetto che non serve più? Ne è nata molti anni dopo la più straordinaria e la più imperfetta delle teorie economiche. Quella che gli ha meritato il premio Nobel. Se esaminate i percorsi dei grandi economisti che hanno meritato il premio Nobel, trovate quasi sempre delle teorie matematicamente dimostrabili e tecnicamente perfette. O sono delle formule matematiche, o sono delle equazioni, o sono delle intuizioni di tipo politico trasformate però in formule, perchè questa è la vita dell’economista. L’intuizione di Amartya Sen è invece il punto di congiunzione tra un filosofo e un economista ed è “al mondo non mancano mai i mezzi per sostentare gli esseri umani, non esiste la penuria, (e badate che detta da un indiano questa frase è molto ardita) esiste la mancanza di ciò che ci serve per sopravvivere in questo luogo e una disponibilità eccessiva in un altro luogo. Secondo Sen si tratta in realtà, notate la semplicità della parola che ha scelto di usare, di un problema logistico: spostare ciò che c’è dove non c’è. E’ proprio vero che le cose più sono geniali e più sono semplici. Per lui la questione è prima: “non manca nel mondo, manca in un luogo”; e poi “in una democrazia, per quanto imperfetta, nessuno muore di fame”. E tutto questo Sen lo dimostra con i fatti. Nell’India immensamente imperfetta, (tutti i giorni i commentatori indiani, i giornalisti indiani, i politici indiani, i teorici politici di quell’immensa democrazia ci raccontano le tanti imperfezioni della democrazia indiana) un fatto è incontestabile: da quando non è più governata da ufficiali inglesi (ai quali poco poteva interessare se in un villaggio il raccolto era scarso ed in un altro abbondante) da quando esiste la democrazia non ci sono più carestie. Il morire di fame che era tipico della vita indiano non c’è mai più stato. Ci sono mille problemi, infiniti contrasti, tensioni che ogni volta sfociano nel conflitto e anche quando il conflitto viene evitato il tutto avviene nei modi più ardui, estremi, all’ultimo istante. E però non si muore più di fame. E dice Amartya Sen il filosofo, e l’economista, primo non morire di fame. E poi si costruisce gradatamente un sistema politico meno imperfetto. Questo percorso che in parte è della storia e in parte è frammento di memoria o di biografia, che io oggi offro alla vostra riflessione, il percorso degli ultimi 50 anni, quelli che vi hanno formato e vi stanno formando di più, a voi meno che ventenni che state arrivando adesso alla ribalta della vita, si incontra in più punti con il cambiamento della scienza, con il cambiamento del pensiero scientifico. Il pensiero scientifico è proceduto per gli ultimi due secoli, che sono stati secoli di intenso avanzamento e di continue scoperte e verifiche, grazie al rigore di premesse o di ipotesi che vengono svolte o provate attraverso le ricerche e si confermano in una tesi o teoria la quale a sua volta determina le basi per un successivo procedere. Come sapete il mondo ha continuato a procedere lungo linee rette di ipotesi e verifica fino a quando personaggi della grandezza di Einstein hanno fatto irruzione sulla scena dicendo in sostanza “guardate che la fantasia ha ruolo immenso in questo discorso, l’immaginazione ha un ruolo grandissimo, persino la poesia ha un’importanza enorme nell’elaborazione di teorie e nei tentativi di provarle”. Einstein ha insomma sconvoltto quel procedere in linea retta che oltre un determinato punto non riusciva ad andare. Oggi in tanti campi si riesce invece ad andare avanti perché si è rotto lo schema causa effetto, causa, dimostrazione, effetto, grazie all’ingresso nella scienza dell’intuizione, dell’immaginazione, della ricerca disinteressata, di quell’enorme bagaglio che gli scienziati, i ricercatori chiamano “Fasi Ideas”: anche se ho idee ancora imprecise, nebbiose, non ancora chiaramente definibili, le uso come base per una possibile ricerca e vediamo dove mi portano. A me è capitato di assistere ad un esempio di questo tipo, di deviazione dalla linea rigorosa, in un ospedale americano, un luogo dove domina ancora, molto forte, la cultura del rifiuto dell’incerto, dell’uso della certezza, del limite all’intervento soggettivo, persino da parte del medico. Il caso è questo. Negli ospedali americani ai medici viene data come istruzione quella di considerare di primaria importanza l’eventuale indicazione di qualcuno di volere o non volere proseguire la vita. In pratica chiunque può mettere nel proprio portafoglio l’indicazione “sono il tale e in caso di incidente non voglio essere oggetto di quello che si chiama accanimento terapeutico. Non voglio insomma che tentiate ad ogni costo di salvarmi”. La frase che si usa negli ospedali americani si esprime con la sigla DNR, Do Not Resuscited. Il caso che ho visto è quello di un medico giovanissimo, donna, che si trova di notte da sola ad accogliere uno di questi corpi. Arriva la barella con una persona inanimata, che sta respirando esclusivamente in modo artificiale, e sul quale c’è il cartello verde DNR. La giovane dottoressa donna fa i suoi gesti anamnestici, ciò che deve fare, ciò che è richiesto. Ma il suo istinto di persona e di medico le dice qualcosa di diverso da ciò che dice quel cartello. Le dice che questa persona vuole vivere. E’ pura intuizione. Non ha nessuna ragione per dubitare di quel cartello, do not resuscited. E quel cartello vuol dire che c’è un incontro tra il regolamento dell’ospedale e la volontà della persona. Vuole anche dire non sprechiamo risorse. Nella cosa c’è infatti anche una componente economica: è morto, vuole morire, lasciamolo morire. La giovane dottoressa tocca, sente, decide che questa persona vuole vivere. E così viola la regola che le è stata assegnata, viola quella che è apparentemente la volontà della persona. E la mattina dopo si trova a sedere sul bordo del letto con una persona che le tiene la mano e le dice grazie. Perché il suo desiderio era di continuare a vivere. L’istinto ha giocato dunque un ruolo determinante in una parabola certamente imperfetta di percorso scientifico, dove entra il cuore, la fantasia, l’immaginazione, l’istinto. E’ una sequenza che mi ha molto colpito. Mi occupavo allora di pronto soccorso americano e non ho dimenticato quella sequenza. Non l’ho dimenticata perché era una variazione che ci dice “d’ora in poi la nostra vita è fatta di variazioni, di impulsi, di istinti, di scoperte, di decisioni personali, di responsabilità nelle nostre mani. Della scelta di non accettare ciò che ci sembra inaccettabile o impossibile dopo che sono venute generazione di zombie che hanno accettato di obbedire ad ordini che erano oltraggiosi, che hanno accettato di partecipare seppure in silenzio a dei fatti mostruosi che avrebbero dovuto e potuto non accadere mai”. E’ in questo senso che viene incontro a voi un mondo imperfetto ma infinitamente più interessante di quello che è venuto prima di voi. Un mondo dove voi avrete un ruolo che è decisamente più di rilievo di quello della maggior parte delle persone, salvo coloro che hanno lasciato un impronta nella storia, che sono pochissimi, che vi hanno preceduto. Voi non sarete mai quegli insegnanti che seduti in prima fila non si voltano a guardare i loro bambini che se ne vanno per sempre, non sarete mai delle persone che non devono decidere perché è già stato deciso, voi non sarete mai lavoratori massa. Sarete i protagonisti di un mondo in cui ognuno conta e nel quale ognuno di voi lascia, da solo o da sola o insieme con altri o con dei piccoli gruppi, un segno. Viene avanti per voi e verso di voi una tecnologia che si può discutere e anche temere ma che è infinitamente flessibile e che si presta ad essere alla portata delle vostra mani, della vostra intelligenza, della vostra immaginazione, della vostra capacità creativa. Invece della fabbrica sterminata con dentro delle persone che fanno gli stessi gesti per sempre viene avanti il mondo della tecnologia informatica che non è affatto la terra promessa ma è una tecnologia che si presta ad essere usata da ciascuno e vi spinge ad essere voi stessi, con tutta la vostra imperfezione e con tutta la qualità, il talento che ognuno di voi è capace di dare. Sto parlando adesso di rete, di computer, di nuovo tipo di comunicazione che sta dando ormai luogo ad un nuovo tipo di lavoro. Con tutte le cose positive di cui ho appena detto e con tante imperfezioni. Proprio così. Ci sono degli aspetti curiosi in questa nuova tecnologia ed è lì che vi aspetta una sfida di intelligenza, di creatività, di intenzioni. Facciamo qualche esempio? La guerra del Kossovo è stata la prima guerra vissuta con la rete, la prima guerra vissuta nell’era dei computer che comunicano tra loro attraverso internet che, come sapete, è stato pensato dalle forze armate americane pensando di creare una rete di sostegno alla eventuale sostituzione di contatti telefonici o radiofonici o televisivi e che è diventata patrimonio del mondo. E durante la guerra nel Kossovo ho notato che la gran parte dei messaggi che passavano in rete non erano messaggi di pace ma di rivendicazione di ciascuno delle proprie posizioni: i serbi rabbiosamente serbi, i kossovari, finché sono riusciti ad esprimersi, appassionatamente e inflessibilmente kossovari, i macedoni strenuamente macedoni, gli italiani con le varie posizioni: a favore della Nato, contro la Nato, contro l’America. I messaggi erano dunque una costellazione di posizioni nelle quali ciascuno era vicino a sé stesso e lontano dal destinatario. Pensate che cosa curiosa: c’è stata una sorte di uso rovesciato della rete. I serbi non solo reclamavano con fermezza la loro posizione, ma non facevano nulla per persuadere, anzi lanciavano insulti e a un certo punto hanno smesso di comunicare in inglese e hanno cominciato a farlo in serbo, troncando in questo modo ogni capacità di comunicazione. Eppure avevano degli argomenti, eccome se li avevano, se non altro perché erano sottoposti a bombardamenti violentissimi, eppure facevano circolare soltanto messaggi del proprio punto di vista ideologico. Su questo tema ho scritto “Fine del villaggio globale”, che è un analisi di tutti i messaggi apparsi durante il periodo della guerra. L”ho fatto non per dire questo è il destino della rete ma, attenzione, per dire che di per sé le tecnologie, per quanto promettenti, per quanto ricche di cose nuove, per quanto affascinanti e diverse, non vanno da nessuna parte. Dio sa se ce n’è stata un’altra con le stesse potenzialità, con la stessa coincidenza con l’età giovane di chi viene a contatto con questa tecnologia. Di solito le tecnologie arrivano troppo tardi o troppo presto. Internet invece arriva dritta nella vostra generazione. Eppure da sola non basta. Neanche questa straordinaria del computer. Facciamo un altro esempio? Ogni volta che scrivo un articolo controverso, e controversi per molti sono anche quegli articoli che a tanti altri di noi paiono assolutamente necessari, come quelli sul problema della tolleranza e dell’intolleranza, ricevo molta posta. Meno di un terzo è di solito appassionatamente di sostegno (ovviamente so bene che ci sono tantissime persone che non scrivono perché sono d’accordo e quindi non ne faccio una questione statistica) due terzi è di solito scettica, ostile, oppure duramente ostile. Ora se le lettere duramente ostili arrivano con la posta “tradizionale” di solito l’ostilità e la cattiveria delle lettere è contenuta entro certi limiti espressivi, come se le persone stessero parlando in pubblico, come se uno di voi si alzasse in quest’aula per contraddire alcune cose che ho detto e certamente lo farebbe, per quanto sia convinto delle sue idee, con la buona educazione, le buone maniere con cui si parla in pubblico. Quando invece arrivano via e-mail sono incredibilmente più violente, più aggressive e più irresponsabili, nel senso che tradiscono l’idea di chi l’ha scritta di non essere responsabile di ciò che sta scrivendo. Questa separazione tra corpo e anima, per cui il corpo rimane con la propria identità a casa e lancia un messaggio che è del tutto libero da quel tanto di remore che ci sono quando ci guardiamo in faccia o quando ci si scrive con i metodi tradizionali, quelli che per abitudine abbiamo imparato ad equiparare a guardarsi in faccia, è un curioso fenomeno psicologico che accade nella rete. Aprire una busta, a meno che non si tratti di una lettera anonima (chi scrive delle cose che alcuni giudicano controverse riceve una buona dose di lettere anonime ma io quelle non le calcolo; la lettera anonima è vile di per se, cattiva di per sé) è insomma di solito assai meno violento che leggere e-mail, il sistema che tra poco diventerà l’unico modo di comunicare che abbiamo, ma nel quale c’è un drammatico sdoppiamento tra identità e messaggio. Tutto questo per dire cosa? Semplicemente che la tecnologia più importante siete voi, le vostre teste, la vostra voglia di comunicare con gli altri. Durante la II guerra mondiale c’era quello strumento imperfetto che era la radio. Non potete immaginare che cosa significava, tenendola bassissima, con le luci spente, ascoltando di notte, riuscire a captare qualche messaggio dalla resistenza, riuscire a trovare una parola che ci dicesse che qualcuno stava ancora pensando a noi, che da qualche parte c’era qualcuno che ci parlava, ci incoraggiava, ci diceva arriviamo, ci sarà la libertà, ci sarà un momento di luce. Chi sta usando oggi le nuove tecnologie deve sapere che c’è sempre un momento in cui bisogna unire la testa alla tecnologia, la propria passione di esistere con le potenzialità dello strumento che si ha in mano. Che peraltro oggi sono davvero enormi. Io credo sia questa la vostra sfida, sia questa la ragione per cui è così bello e straordinariamente significativo che una nuova tecnologia diventi disponibile per voi mentre siete giovani. Un’ultima considerazione. Insieme ad Elie Wiesel, che voi probabilmente conoscete, è il premio Nobel per la pace, il filosofo sopravvissuto ad Auschwitz, l’amico compagno di Primo Levi, e che ancora adesso è in piena attività (insegna negli Stati Uniti, è Presidente della “Accademie Universelle des Cultures” di cui fanno parte alcuni italiani, tra cui Umberto Eco ed io, insieme allo storico francese Jaques Le Goff) stiamo conducendo su Internet (ve lo dico perché vi invito a farne parte) un forum continuo sulla tolleranza, che naturalmente parte dai problemi fondamentali che sono alla base della storia contemporanea, cioè la Shoà, ma si estende in realtà a tutti i problemi contemporanei, dalla convivenza tra israeliani e palestinesi a quella fra noi e i nostri immigrati, dalla tolleranza per aspetti culturali che prima non avevamo conosciuto alla domanda ma si può essere tolleranti dell’intolleranza di altri?; posso essere intollerante di qualcosa che mi pare intollerabile? Per esempio vi posso portare la mia esperienza di deputato eletto in un quartiere estremamente conflittuale di una città come Torino, che è ricchissima di immigrati. Si può tollerare, nel mentre si difende l’apertura delle moschee, si difende il fatto che i bambini possano esprimersi a scuola secondo le loro tradizioni e la loro cultura, che esista la pratica della infibulazione, la mutilazione femminile, che non è pratica religiosa ma viene spacciata come pratica religiosa, attraverso vasti strati della popolazione islamica, compresi i gruppi che si sono trasferiti in Europa? Come vedete i nuovi problemi che sono di fronte a noi, il nuovo modo di esistere insieme, le nuove tecnologie che ci permettono di comunicare insieme, sono una bella sfida che richiede più e non meno attenzione verso tutto ciò che è accaduto nel passato. E’ anche per questo, per esempio, che sono il primo firmatario della proposta di legge per l’istituzione in Italia di un giorno della memoria e spero proprio, prima della fine della legislatura, di vedere questa legge approvata. Sono solo due articoli, e non richiedono che sia istituito un giorno di festa ma un giorno di riflessione. Una volta all’anno in cui tutti ci si ritrovi con i più giovani a ricordare quello che è accaduto, a rivedere ciò che è stato e fare in modo che nella sua parte negativa, oscura, di morte, non possa accadere mai più. Voi avete di fronte tutto il meglio ma anche tutti i rischi. Per questo esistono iniziative come il forum sulla tolleranza di cui vi ho parlato, per questo esiste la possibilità che voi partecipiate, per questo esiste per voi una sfida di essere persone pienamente decise ad occupare il proprio spazio nella storia. Questo vale per tutti e vale un po’ di più per voi ragazze, che state diventando le protagoniste di un mondo che fino a poco fa vi ha conosciuto molto poco, che fino a poco fa voleva soltanto che foste degli ornamenti meglio se senza parola. Basta guardare i mezzi di comunicazione di massa che non vi stanno dando nessun esempio di come potreste essere perché non fanno altro che produrre modellini graziosi di veline che al massimo cantano e ballano (in una quantità di trasmissioni compaiono soltanto, sono lì per essere viste ma non hanno il dono della parola). Voi state invece diventando, lo si vede di elezione in elezione, lo si sta discutendo in questi giorni in riferimento alle elezioni iraniane, le protagoniste delle cose che cambiano. Il presidente Clinton ha potuto sfidare la forza delle compagnie di assicurazione e delle compagnie del tabacco del suo Paese perché la gran parte delle donne americane, quelle repubblicane e quelle democratiche, hanno votato per lui. Quello che forse sta per avvenire in Iran in questi giorni avverrà perchè le donne Iraniane, nonostante il loro chador, la loro apparente sottomissione a delle leggi islamiche imposte dagli uomini, stanno per riprendere la loro posizione nella vita. Voi avete dunque di fronte questo compito in più: occupare uno spazio che vi spetta e questa sfida rende molto più bello il vostro ruolo. Voi siete la sfida per affermare tutto questo. Voi siete il nuovo e il diverso. Voi siete quella parte di civiltà che ancora non si era sentita, se non implicitamente, attraverso l’immensa influenza dall’interno delle famiglie. E’ un mondo interessante quello nel quale state facendo il vostro passo in avanti e per questo non posso che lasciarvi con un augurio immensamente affettuoso. |





















Cara Cinzia, queste sono solo le foto, se vuoi sapere la storia devi leggere qui.

Su quel lato di Corso Secondigliano il sole arrivava più tardi. Lo sapevo bene, ci passavo ogni giorno, andata e ritorno, da ottobre a giugno, diretto alla Scuola Media Statale Giuseppe Moscati, proprio lui, il medico dei poveri, che un giorno lo avrebbero fatto beato e poi, e per forza, santo, ma a quel tempo chi ci andava a pensare. E sapevo bene che era un giorno diverso dagli altri, nonostante il rumore dei passi, le facce, le voci, fossero quelle di sempre.
First at all, non avevo la cartella, perciò non stavo andando a scuola. La colpa era di mio zio Salvatore, il marito di zia Nunziatina, la sorella più grande di papà, che la notte precedente era passato a miglior vita. Era stata mamma a dirmi del cambio di programma: “Gennaro, io non mi posso muovere perché devo badare al nonno e ai tuoi fratelli, tuo padre ti raggiunge più tardi, si prende due ore di permesso per partecipare al funerale, tocca a te che sei il più grande rappresentare la famiglia fino a quando non arriva papà”. “E la scuola?” “A scola se ne parla dimane, Gennà, e pò che sò tutte sti chiacchiere?”.
Tutte queste chiacchiere? Io una parola e un poco avevo detto, più che altro perché fosse chiaro che ero stato “costretto” a non andare a scuola. La verità è che allora non era come adesso, non c’era bisogno di dire tante cose, il libro dei perché non era stato ancora inventato e i sensi di colpa non si sapeva neanche cosa fossero. Vogliamo dire che era tutto più semplice? E diciamolo, che così almeno ci facciamo fessi con il pensiero. Detto maccheronicamente, come amava fare papà, a quei tempi chi doveva comandare, i genitori, comandava, e chi doveva ubbidire, i figli, ubbidiva. E i miei tredici anni, anche quando avevi la fortuna di avere genitori che non ti condannavano, per ignoranza o per necessità, a un futuro job in black in qualche piccola fabbrica di scarpe o di detersivi, erano più che sufficienti per assumere, fino all’arrivo del leader maximo, il ruolo di legale rappresentante della famiglia.
Ecco, detto questo, posso finalmente confessare che quella mattina ero decisamente contento. Fare festa a scuola, se non avevi la febbre a 40, era davvero un evento raro se avevi un padre come il mio, fissato per lo studio, quaderni e libri nuovi ogni anno perché i figli degli operai non devono sfigurare di fronte ai figli dei professionisti, insomma il classico padre della serie “tu studia a papà che quando ti farai grande farai il concorso alla compagnia del gas, lo vincerai e ti dovranno chiamare signor Pellecchia e non come chiamano a me, don Ferdinando, compresi chilli muccusielli di tecnici che io, con la mia esperienza e le mie capacità, non me li vedo proprio”.
Ma cos’è questo mormorio? Dite che da un ragazzo per bene di tredici anni questo non ve lo aspettavate proprio? Che essere contento della morte dello zio non sta bene?
Just a moment, please! Io non ero contento della morte dello zio, ero contento di non andare a scuola. Mio zio era morto prima. Poi, dopo, io avevo saputo che non sarei andato a scuola ed ero stato contento. Mica era successo all’incontrario. E come facevo io a sapere che sarebbe morto. Fosse ’o Ddio. Sapete quante vite umane avrei potuto salvare? Sarei diventato una celebrità. Di più. Avrei avuto la possibilità, che Nostro Signore neanche a se stesso se l’è data, di decidere “a te ti avviso, perché sei una brava persona, a te no, perché sei un farabutto”. Ecco, adesso sì che sto peccando di superbia, che è peccato grave, bisogna che mi ricordi di fare mea culpa.
Torniamo a noi, anzi a zio Salvatore, che era vissuto più di ottanta anni ed era stato una persona assai particolare. Cosa vuol dire particolare? Ad esempio che la domenica mangiava prima la carne e poi i maccheroni per paura, – si, diceva proprio così –, che se veniva qualcuno a trovarlo doveva offrirgli un poco della carne che spettava a lui. E poi vuol dire che era manesco e che non so quante volte – negli anni in cui papà, mamma, io, mio fratello Armando e la zia Giovannina, la sorella zitella della nonna, la mamma di papà, siamo stati di casa sotto a zia Nunziatina, in una camera di scarsi 4 metri per 5, cucina e gabinetto compreso -, ho visto la zia correre giù per invocare l’aiuto di papà: “Ferdinà, curre, saglie ’ncoppa, Salvatore sta vattenne ’e guaglione e ha dato dduje paccheri pure ’a mme”. E papà ogni volta correva, anche se stava in pigiama, e allora scendeva quando aveva messo a posto la situazione. Non saprei dirvi né come e né perché, ma era l’unico che riusciva a calmare quel mezzo alcolizzato nulla facente di mio zio, scusate, pace all’anema soja, ma quando ci vuole, ci vuole.
Ero arrivato ormai a poche centinaia di metri dalla casa di zia Nunziatina quando scorgo i primi manifesti listati a lutto. Leggo: “dopo una vita dedicata al lavoro e alla famiglia, serenamente come visse si è spento Salvatore Scippacercola”. Azz. Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia. Ma si mò mò aggio furnute ’e dicere che era uno scansafatiche che beveva e picchiava moglie e figlie? Ma per favore. Questi fanno come nella canzone, mamma mia come la odio, “chi ha avuto, avuto, avuto, chi ha dato, ha dato, ha dato, scurdammoce ‘o passato, scurdammoce ‘o passato, simmo ‘e Napule, paisá”.
Per carità, da un certo punto di vista, se parliamo di ricchi e di poveri, di fortunati e di sfortunati, di belli e di brutti, va bene, diciamolo pure, è giusto. Ma da un altro punto di vista, quello dei fetenti e delle persone per bene, degli uomini e dei caporali, come diceva Totò, no, non va bene affatto. E allora che scriviamo sopra il manifesto quando, da qui a cento anni, salute a noi, muoiono la zia e le figlie? Io da quando me le ricordo hanno lavorato sempre dieci, dodici e anche quattordici ore al giorno a tagliare e a cucire, con le loro vecchie Singer, giacche e giubbotti per quel loro conoscente che aveva una piccola fabbrica a Melito. Lavoravano così tanto che, pur essendo delle belle ragazze, non hanno mai avuto il tempo di innamorarsi, di fidanzarsi, di sposarsi. E che gli scriviamo a loro, sul manifesto, “dopo una vita passata a s’accidere ’e fatica per mantenere se stesse e quell’essere inutile del padre che si mangiava prima la carne e poi i maccheroni sono morte come due cretine senza aver conosciuto l’amore?” Ma fatemi il piacere. Secondo me ha fatto bene zia Nunziatina. Anche a tanti anni di distanza, quando ci penso, me la vedo ancora davanti agli occhi mentre ogni domenica, domenica dopo domenica, gamba claudicante, passo inesorabilmente alternato, la sua brava sediolina pieghevole appesa al braccio, va al cimitero per allietare il deceduto consorte con ingiurie, sberleffi e anatemi di ogni tipo: “Salvatò, tu m’è dato ’a morte pé ’na vita sana, ma mò tu sì muorte e invece io sto fresca e tosta. Te ricuorde quante sofferenze ce fatte patì a mmè e a è figlie toje? Mò, a te, te stanna mangianno ’e diavoli e nuje stamm ngrazie ’e Dio. Sei stato un fetente, Salvatò, sei stato fetente assai, e mò Nostro Signore te la deve far pagare. Uè, mi raccomando a Te, che sei l’Essere perfettissimo Signore e Creatore del cielo e della terra. Nun fa sconti, è stato troppo fetente. E adesso deve pagare fino all’ultimo. Ci vediamo domenica prossima, Salvatore. Io ccà vengo. E a te ccà te trovo”.
Dite che pure zia Nunziatina era un personaggio particolare? E chi lo nega. A un certo punto l’avevamo soprannominata Highlander perché è stata l’ultima dei Pellecchia della sua generazione a trapassare nel mondo dei giusti, quando ormai i 90 anni se li era lasciati alle spalle da un pezzo, ma il suo vero nome d’arte era un altro: “Ciuccio ’e fuoco”. Si, confermo. Zia Nunziatina è stata un personaggio unico.
Con papà, il più piccolo dei fratelli, unico maschio sopravvissuto, amato e coccolato dalle quattro sorelle, c’era stato una volta un siparietto tragicomico di quelli che sembrano usciti dalle commedie di Eduardo.
La scena: il letto di morte di zia Assunta, la seconda sorella di papà. I personaggi: papà e Zia Nunziatina. L’azione: papà che piange inconsolabile la sorella; zia Nunziatina che arriva claudicante, ansimante, piangente a metà, abbraccia papà, prende a piangere a dirotto, lo abbraccia più forte, si stacca, lo guarda e gli dice “Ferdinà, simme rimasti io e te, mò devi morire sulo tu”. L’epilogo: papà che dapprima rimane esterefatto, poi la guarda, la tocca come a spingerla via, si tocca come a cercare conforto là dove non batte il sole, prende aria e poi finalmente sbotta: “Nunziatì, ma pecché, nun può murì primme tu, ca tieni pure vintanne cchiù ’e me?”. Se avesse potuto, credo che anche zia Assunta sarebbe scoppiata a ridere, di certo non se la prese per il sorriso che illuminò per qualche istante i volti di tutti i presenti.
Zia Nunziatina era fatta così. Da un lato era la bontà fatta persona. Il giorno di San Gennaro si faceva più di due chilometri a piedi per portarmi in regalo una scatola di biscotti e festeggiare il mio onomastico. E che dire dell’uovo di papera sbattuto che mi preparava una mattina sì e una no quando passavo da lei prima di andare a scuola? Già di per sé, l’uovo era il doppio di quello di gallina, poi ci metteva due cucchiai di zucchero e un goccio, così almeno diceva lei, di marsala, roba che se a scuola mi avessero fatto il controllo antidoping mi avrebbero sbattuto fuori almeno per un trimestre. Me lo ricordo come se fosse adesso: “Bevi a zia, bevi, che tu devi crescere e l’ovetto ti fa bene”.
Azz., lo chiamava ovetto. Ancora oggi quando mi chiedono da chi “ho preso” i miei 2 metri, non so se dare la colpa al papà di mamma, 1 metro e 83, un’altezza esagerata per i suoi tempi, o alle uova sbattute di zia Nunziatina. Allo stesso tempo, adesso voi non ci crederete, aveva una capacità unica di creare il quarto d’ora di scomodo, di dire la parola sbagliata al momento giusto, quello buono per creare scompiglio, provocare un equivoco, insomma di far scoppiare un casino. Le veniva come naturale far litigare tra loro le persone, persino quando l’intenzione era quella di mettere una buona parola. Faceva una sola eccezione, ed era per la famiglia Pellecchia. Le Scippacercola, le sue figlie, da adulte erano diventate, come diceva lei, “parenti laschi”. I Pellecchia no.
Ho ancora davanti agli occhi il giorno della morte di mio padre. Matteo, il terzo, che ci raggiunge nella sala mortuaria e ci dice che sta arrivando Highlander. Le vado incontro assieme a Daniele e Michele, i figli gemelli di Armando, il secondo, due ragazzi formato marcantonio anche se al tempo non avevano ancora 13 anni. Zia Nunziatina ci vede. Si ferma. Mi abbraccia. Piange. Si volta verso uno dei ragazzi e gli chiede “tu sei un Pellecchia”. “Sì – risponde lui, timido -, sono il figlio di Armando, lui è mio fratello Michele”. Lei guarda un po’ qua, un po’ là, si soffia forte il naso, e poi fa: “siete due Pellecchia, bravi, crescete e moltiplicatevi”. Poi mi infila il braccio sotto al braccio, fa un cenno con la testa e ce ne andiamo da papà.

Cara Cinzia, come diceva Quelo “c’è grossa crisi, qua non sappiamo più quando stiamo andando su questa terra”. Purtroppo funziona proprio così, l’età dell’incertezza è diventata l’età dell’inquietudine, e questo non ci fa bene, né come individui, come persone, né come comunità. La soluzione a questo gran casino naturalmente non ce l’ho, né dentro e né fuori di me, però penso di avere una possibilità, magari piccola e però vera, la possibilità di partire da quello che posso fare io e farlo bene.
Per me il lavoro ben fatto è prima di tutto questo, partire da quello che possiamo fare noi, sì, noi, perché tiene ragione John Donne, nessun uomo è un’isola, completo in se stesso, siamo tutti parte di questo straordinario mondo fatto di umanità e di miserie, di bellezza e di diseguaglianze, di possibilità e di diritti negati.
Come ho scritto su Nòva, per me fare o non fare, non c’è provare, nel senso che se ce ne stiamo ad aspettare che passi la nottata siamo fritti. La forza dirompente del lavoro ben fatto sta proprio qui, nella semplicità dei suoi cinque passi, negli articoli del suo manifesto, nella necessità che nessuno si senta esluso, nella consapevolezza antica che faceva dire a mio padre che, quando durante il giorno fai bene quello che devi fare, la sera, quando metti la testa sopra al cuscino, sei contento.
Il libro che ho scritto con Luca nasce da qui, è questo che voglio dire quando dico o scrivo che è un libro per le persone, per le famiglie, per le scuole, per le imprese, un libro che fa bene alle persone, alle famiglie, alle scuole, alle imprese, un libro che non è solo un’idea e un racconto, è anche, direi soprattutto, una pratica e una possibilità.
Per me, se il mondo lo vogliamo cambiare davvero, di più, se finalmente ci decidiamo a capire che il mondo lo dobbiamo cambiare davvero, dobbiamo cambiare il nostro approccio con le cose del mondo.
Cominciando da quello che possiamo fare noi, e intessendo la rete del cambiamento, puntino dopo puntino, nodo dopo nodo.
Conto di tornare presto, intanto ti mando un bacio.

Dopo molti tentativi forse ci siamo. Una struttura molto semplice, con le pagine in alto che raccontano di me, delle cose che ho fatto e che faccio, una home che presenta alcuni contenuti in primo piano e un blog dove ogni tanto raccontare una storia. È tutto, spero vi piaccia.
AustroeAquilone: Proviamo a cominciare dai bambini. Quegli stessi che in un tuo libro, La compagnia dei celestini, sfidano il “Potere” organizzando un campionato di calcio di strada con delle regole molto particolari.
Stefano Benni: Non ho il mito del bambino buono e creativo a tutti i costi. E credo che l’immaginazione sia un dono che appartiene a tutti. Ma credo anche che nei bambini in particolare tale dono debba essere rispettato, non debba essere spento.
Ci sono tanti modi di spegnerlo, di far sì che l’immensa varietà immaginativa che si ha quando si è ragazzi venga incanalata, con il risultato di farne delle macchine banali che rispondono non secondo la loro immaginazione ma per essere approvate, per aver riconosciuto un ruolo.
Dico sempre che l’immaginazione non è il giardino di rose dove si rifugia il pensiero, ma un’arma concreta per avere più possibilità. Il pensiero, la fantasia, non sono staccate dalle cose: tutti i grandi inventori sono degli immaginatori pazzi.
L’immaginario può essere una ricchezza reale, un dono che, se coltivato, ti serve per le battaglie di tutti i giorni. La sua importanza è questa.
E l’immaginazione è minacciata da più parti. Ancora oggi quando vado nelle scuole vedo quanta differenza c’è tra gli insegnanti che hanno determinate caratteristiche e quelli che non le hanno, anche se una volta la scuola minacciava l’immaginazione molto più di adesso.
Mi piace fare l’esempio del “fuori tema”.
Tutti i bambini hanno una unicità di scrittura che però con questo fatto che i temi spiegano già che cosa vi deve avvenire dentro non viene incoraggiata. Da qui i miei esempi abbastanza scherzosi, quei temi con titoli di sette pagine. Poi ci sono la famiglia, il conformismo delle mode, e negli ultimi anni questa grande macchina fabbricatrice di consenso che è la televisione. Il ragazzo riceve giorno dopo giorno una serie di messaggi che vanno tutti in una sola direzione.
E’ compito di chi l’immaginazione l’ha salvata, magari per miracolo, riproporre quella che è la varietà della cultura, spiegare che la cultura non è fatta di sole poche cose ripetitive ma di tante cose: ci sono i libri, c’è il teatro, c’è il gioco.
Nei Celestini c’è una cosa molto semplice: la differenza fra il gioco che ha delle regole imposte da altri, e la libertà di inventare delle regole.
Io trovo che il modo di giocare dei bambini, il darsi dei ruoli, l’inventare delle regole, sia qualcosa che deve essere assolutamente mantenuto perchè corrisponderà, nell’età adulta, al fatto di poter scegliere i modi di stare nel mondo, alla capacità di convivere con le regole ma mantenendo allo stesso tempo una propria unicità.
In questo senso, come è ovvio, non è la televisione ma il modo in cui è ed è stata usata in Italia che è fetente. Il libro è stato scritto prima che Berlusconi andasse al governo e dunque non si può dire che descriva qualcosa di già avvenuto. Ciò che è successo dopo ha dimostrato però che quella di cui si parlava era una paura reale, che in qualche modo il libro anticipava.
La televisione, che poteva essere una grande macchina di moltiplicazione delle conoscenze, è diventata uno strumento di immiserimento dell’immaginazione, una specie di piccola fabbrica di depressi, una sorta di baby sitter casalinga che spegne l’immaginazione. E’ una televisione che in qualche modo celebra delle ossessioni, spaventa e poi rassicura falsamente. Che è qualche cosa che non fa parte nè del pensiero razionale nè di quello immaginativo: è una caricatura misera di tutti e due i pensieri. A mio figlio, che ha nove anni, non ho proibito la televisione, ho soltanto cercato di dirgli che c’erano anche altre cose. Lui guarda la televisione, e si interessa anche ad altre cose. Credo che in questo modo quando sarà grande avrà più strade davanti.
AeA: Ma perché in questo nostro Paese sembra così forte la voglia di conformismo? Al punto che in molte aziende c’è ancora il culto dell’eleganza fatta di giacca, camicia e cravatta, quando invece da altre parti c’è molta più attenzione verso i contenuti, la sostanza, le effettive capacità delle persone? E perché piacciano così tanto quelli portati a dire sempre di si?
S.B.: Detto che non penso che sia la camicia slacciata a definire il creativo, non è facile fare una riflessione sul perchè l’Italia abbia maturato questa attrazione verso il conformismo, che tra l’altro l’ha portata ad un esperienza purtroppo disastrosa come una guerra mondiale. Ad un certo punto sembrava di essere vaccinati, perlomeno nei confronti di un tipo di conformismo indubbiamente pericoloso come quello fascista, ed invece, lo vedo nei miei seminari, parecchi giovani sentono la loro diversità: lamentano che i loro coetanei sono molto conformisti e fanno tutti le stesse cose, ma allo stesso tempo esprimono un forte disagio, si sentono un po’ soli. (Bisogna dire anche che ci sono fasi nelle quali, all’opposto, ci sono movimenti, idee, per le quali una persona sente che i suoi pensieri sono condivisi da altri ma avverte che c’è un rischio di conformismo nell’anticonformismo).
L’immaginazione produce spesso una posizione di netta contrapposizione, ed è difficile per un giovane avere una sua precisa unicità.
Bisogna pensare che la cultura è anche questo. La cultura è molto spesso una strada di minoranza. Certe battaglie culturali s’intraprendono in minoranza cercando poi di contagiare la maggioranza.
Quello che forse in Italia è completamente scomparso è il valore del termine, della parola minoranza, che viene infatti confusa con emarginazione, minoritarismo. Invece, e specialmente la sinistra dovrebbe ricordarlo, va rivalutato il senso di questo termine non come separatezza ma come momento iniziale, come la valorizzazione di qualcosa che ancora non c’è.
Nell’invenzione scientifica si è da soli contro un accademia; un artista è solo quando scrive in un modo in un mondo di scrittori che scrive in un altro.
Adesso gran parte delle persone fanno una battaglia culturale solo se ha il consenso del 51%. Alcuni miei colleghi cominciano a scrivere un libro pensando già che dovrà avere comici che lo portano in televisione. Si buttano in un meccanismo che assicura loro il massimo di consenso salvo poi tornare indietro delusi perchè non hanno creato niente. Il fatto è che in questo momento la politica vuole una cultura conformista. La sinistra è andata al potere e ha stranamente ingoiato il veleno dell’avversario, nel senso che apprezza molto un presentatore televisivo o un suo simile che gli può portare consenso, mentre vede non dico con fastidio, ma con certa sufficienza, chiunque dica che la sua storia è una storia di grida non ascoltate.
In realtà non si sta certo incoraggiando l’anticonformismo bensì tutto ciò che è massificato, standardizzato come il cinema americano e la televisione. Del resto, anche i politici di sinistra vivono nei salotti televisivi e poi sostengono che ciò che lì succede è molto importante.
Non so a Napoli, ma a Bologna sono considerati eventi solo i grandi concerti, le grandi adunate mentre tutto ciò che è fatto da poche persone, ed è prezioso, viene vagamente stimato. Questo è il modo di uccidere l’immaginazione della cultura, perchè chiunque sarà portato a pensare che dato che gli esempi della grande politica vanno in questa direzione è meglio seguire il flusso.
AeA: Nel 68 si è sostenuto che bisognava portare l’immaginazione al potere. A trenta anni di distanza, ti pare ancora un tema attuale?
S.B.: Mi verrebbe da dire che l’immaginazione al potere è arrivata con il processo Sofri. E’ Marino che l’ha portata al potere immaginando tutte quelle bugie che ha detto.
Se immaginazione al potere vuole dire immaginare di prendere il potere, e magari rifare le stesse cose, gli stessi errori, con le stesse retoriche, le stesse architetture che hanno fatto quelli di prima, non mi pare abbia molto senso.
Il verbo dell’immaginazione non è nè devo nè voglio, ma posso. Se posso, posso immaginare che esistono anche altre soluzioni, che esistono cose migliori. Solo dopo mi scontrerò con la realtà, sapendo che dovrò assolutamente accettarne il peso, l’inerzia. Non si tratta dunque di continuare a sognare ma di combattere dentro la realtà. Immaginazione al potere non vuol dire pensare che preso il potere l’immaginazione diventi una specie di bacchetta magica ma piuttosto riuscire ad avere più potere senza far sì che esso ti tolga l’immaginazione, riuscire cioè ad andare al potere rimanendo immaginativi e continuando ad ascoltare tutto ciò che al potere si oppone.
Il punto è in qualche modo la capacità di riuscire a mantenere insieme le due parole: avere un potere culturale, cioè la capacità di parlare, di discutere, di avere strumenti forti come la televisione ma senza mai fare calare una parola ultima, mantenendo questa specie di verità penultima, questa immaginazione.
In questo senso il 68, con la sua grande critica al principio di autorità, è servito a tutti, a noi che ci abbiamo creduto e anche ai nostri avversari, anche se è stato descritto come una cosa completamente diversa, come una sorta di età dello sballo.
In realtà non è mai stato questo: era qualcosa che stava dentro la pratica politica anche se ha avuto il torto di non immaginare, di non pensare abbastanza all’Italia, alla Francia, alla Germania, e di cercarsi nel mondo degli esempi come la Cina ed altri paesi piuttosto fetenti.
Io credo comunque che l’immaginazione stia ancora lottando e che rispetto alla politica, che è il mondo della miseria dell’immaginazione, e all’informazione, che è la morte dell’immaginazione, permanga, in modo molto trasversale, per dirla con una parola che a me non piace molto, in ambiti e mestieri molto diversi.
Nei nostri seminari ci sono psichiatri, antropologi, insegnanti, e tutti stanno un po’ riprendendo questo discorso: è proprio vero che la politica è così misera come ce la propone la televisione? è proprio vero che nelle città si può vivere solo sparandosi addosso? è proprio vero che la televisione è ciò che divora la cultura? è proprio vero che la scrittura non esiste più? è proprio vero che Internet è l’unica possibilità di comunicazione del futuro?
In qualche modo l’idea è che forse esista qualcosa di meglio. E che soprattutto esista qualcosa di diverso dall’economia come solo metro di valutazione del benessere.
In realtà laddove si sposa pensiero ed immaginazione non esiste un pensiero puramente immaginativo. Credo che si potrebbe fare una lunga analisi su che cosa è la metafora, su che cosa è il raccontarsi, su che cosa è la bugia. E penso che parecchie persone che si illudono di essere razionali dovrebbero ammettere di essere in realtà dei sognatori in viaggio in uno strano mondo.
Così come mi sembra che qualcosa che negli ultimi anni è stato oppresso dalla miseria della politica stia riprendendo piede. E’ un’inquietudine presente in molti settori, non soltanto tra gli scrittori, ma tra gli insegnanti, che sono molto attivi, tra gli studenti, nel mondo scientifico (nei nostri seminari abbiamo moltissimi scienziati).
C’è molta più immaginazione in una teoria scientifica astronomica che nella politica e quindi gli scienziati sentono molto questo bisogno di definire nuove possibilità rispetto a quello che è il nostro rapporto con la vita e con il mondo in cui viviamo. Sono alcune delle cose che stanno venendo fuori. Che a volte vengono anche banalizzate. E che potrebbero rappresentare, io lo spero, la battaglia dei prossimi anni.
AeA: Torniamo alla comunicazione. Ci sarà secondo te prima o poi una lingua senza frontiere? Una lingua fatta magari di immagini più che di parole? Una lingua in grado di abbattere le barriere linguistiche tra i diversi paesi?
S.B.: Il sogno di una lingua universale personalmente non ce l’ho. La differenza linguistica può essere una ricchezza perchè fa parte della varietà. Io parlo tre dialetti e questo mi ha aiutato molto nel mio lavoro. Il dialetto può diventare una trincea contro gli altri o può essere un simbolo della varietà della propria lingua, della volontà di non rinunciare alla propria lingua.
Il problema non è una lingua universale, ma il mettere molta immaginazione nella comunicazione. Quando parliamo con un bambino, che ha un codice diverso dal nostro, e ci sentiamo fare una domanda di quelle che fanno loro, cosmiche, su Dio, o sulla Morte, possiamo dare una risposta razionale, codificata, o dirgli non te lo dico perchè tu non capisci (è una risposta spietata, la peggiore che si possa dare), o ancora dargli una risposta debole del tipo Dio è sulla nuvoletta. In tutti questi casi dimostriamo di non avere fiducia né nella nostra immaginazione nè in quella del bambino.
Ma c’è un’altra possibilità. Possiamo, con il massimo del nostro linguaggio metaforico, sfruttare le nostre risorse e andare a fondo di quello che noi pensiamo sia Dio, comunicando con assoluta varietà le nostre idee o i nostri dubbi al bambino, che a sua volta ci risponderà.
Probabilmente, quando avremo trasferito questo metadialogo dal registratore non avrà i caratteri di logicità di una conversazione, però alla fine verrà fuori molta più verità di quanto un no razionale avrebbe comportato.
Lo stesso avviene se parliamo con una persona di un’altra cultura. Io sono riuscito a parlare con i Lapponi. Ho parlato con gesti, intonazioni, segni.
E’ quanto desiderio abbiamo di comunicare che fa la differenza.
Se si parte dal fatto che il proprio codice è l’unica lingua possibile si finisce come Cortes e non ci si accorge di avere di fronte una grande cultura.
Non ho simpatia per le lingue dell’accademia, specialistiche, per iniziati: la lingua dell’economa, della magistratura, della medicina, dei tormentoni della politica, l’inglese tecnico, per certi versi la stessa lingua di internet. Usare termini troppo specialistici mi pare risponda ad una specie di logica di setta. Non è un caso che questi linguaggi si attorciglino su sé stessi, diventino sempre più ostici: essi non sono funzionali alla discussione ma all’imposizione.
Mi pare che proprio a Napoli siate maestri nella comunicazione universale: riuscite a parlare con tutto il mondo perchè avete tutta una serie di modi espressivi, vari tipi di desiderio di comunicare. Se ci si chiude dietro la differenza linguistica non si parlano neanche un bolognese ed un modenese.
L’immaginazione ti fa pensare che con i bambini non si comunica solo attraverso le parole ma anche con i disegni, con il gioco, l’invenzione, i ruoli. Quando i bambini giocano inventano parole per definire le cose ma molto spesso, crescendo, questa capacità la perdono. Mio figlio inventa di continuo delle parole, è creativo: se troverà sulla sua strada un insegnante che si limiterà a dirgli “ma questo non è italiano”, avrà trovato chi credendo di avergli insegnato l’italiano gli avrà in realtà spento l’immaginazione (ovviamente dovrà spiegargli che quello non è italiano, ma dovrà farlo in maniera tale da rispettare ed incoraggiare la sua capacità immaginativa).
Più che immaginare una lingua universale mi piacerebbe che le lingue non dividessero. Credo sia una buona cosa che una persona sappia quattro o cinque lingue. Ma se non c’è una effettiva volontà di comunicare se ne possono conoscere anche dodici: non ci si farà capire da nessuno.
AeA: Perché i pescatori sono bugiardi?
S.B.: L’informazione spettacolo non l’ha inventata Berlusconi. Da ragazzo la mia immaginazione si è nutrita di tante cose, di una varietà infinita di libri, di racconti. < Sono nato in campagna, ho avuto questa fortuna, ed andavo ad ascoltare i racconti di pesca: lì ho capito come è bello raccontare, narrare, anche se era evidente che i racconti che ascoltavo erano pieni di bugie. Ma ai pescatori piaceva raccontare e intanto comunicavano tante informazioni sulla pesca, sulla natura, ed in questo modo insegnavano delle cose.
I pescatori sono dei bugiardi architettonici, hanno tutta una struttura della bugia.
Ho coniato apposta per loro questa famosa legge del coefficiente di retrodilatazione del pesce narrato: quando un racconto comincia il pesce è due metri, ogni minuto che passa il pesce si restringe di qualche centimetro ed alla fine si ottiene un pesce di un metro. A questo punto si divide per due e quella è la reale lunghezza del pesce.
E’ una metafora dell’immaginazione.
D.S.T.: A Napoli c’è un detto che dice “Accorcia l’anguilla”
S.B.: Esatto. E’ una metafora dell’immaginazione nel senso che non esiste il grande ed il piccolo: quello che tu vedi da piccolo è grande e quello che vedi da grande è piccolo. L’immaginazione non è gerarchica, io non ho fatto altro che ribaltare questa cosa qui.
AeA: Napoli è una città di mare. E i pescatori sono un pezzo importante della sua storia e della sua cultura. Possiamo dedurne che i napoletani sono dei gran bugiardi?
S.B.: Nei miei libri parlo dei pescatori di fiume. Ma per la verità anche quelli di mare lo sono abbastanza. Ho degli amici sardi che sono dei professionisti. E sono anch’essi vittime del vapore che viene fuori, che si combina, con le branchie del pesce. E’ l’orgoglio della pesca. Se gli chiedi che cosa hanno preso ti rispondono 30 chili di aragoste, ma quando vai a vedere sono 15.
In realtà i pescatori sono dei bugiardi abbastanza innocui, quelli pericolosi sono altri. Sulla bugia mi piace ricordare un’altra cosa, che a me fa assai riflettere: gli unici che sembra non debbano dire bugie sono i bambini, e ciò la dice lunga sul fatto che la bugia è un fatto di autorità.
I bambini non possono dire bugie, devono dire la verità! Proprio nei confronti dei bambini che sono gli unici che hanno un idea così fluttuante dell’autorità ed avrebbero tutto il diritto di raccontare qualche balla, la bugia è sanzionata.
Poi quando sei grande… Previti, o Clinton. Da grande più che bugiardo sei definito un po’ furbo, un po’ astuto.
Quando la bugia è produttiva in qualche modo funziona: quello che ci spaventa nella bugia del bambino è l’idea che non ci dica la verità, che non riconosca la nostra autorità. E poi ci disturba perché smaschera la nostra ipocrisia, perché è un ritratto in piccolo delle nostre bugie.
E’ una cosa che da una parte è ipocrita e dall’altra rappresenta una precisa invenzione del pensiero razionale.
AeA: Ti sei riferito spesso ai seminari che tieni a Bologna. Ci puoi spiegare un po’ meglio di cosa si tratta?
S.B.: I seminari sono nati da alcuni discorsi di persone, psichiatri, antropologi, filosofi, che non hanno voluto arrendersi alla miseria del dibattito, alla poca libertà di discutere, agli scenari già dati, all’idea che bisogna necessariamente seguire gli orientamenti maggioritari, che tutto ciò che nasce e si sviluppa nell’ambito della psichiatria, dell’antropologia, o della filosofia, sia non produttivo, utopico.
In realtà ci proponiamo di capire se ci sono delle possibilità, se è possibile avere una reazione positiva nei confronti della complessità, che quasi tutti vivono in modo depresso: ciò che è complesso per forza deve essere complicato, depressivo e si può affrontarlo solo tagliandolo, riducendolo, immiserendolo.
Nei nostri seminari abbiamo pensato di affrontarla questa complessità, di chiamarla varietà, di vedere cosa c’è di nuovo in giro e partendo da qui abbiamo cominciato a fare questi confronti sulla scrittura, sulla malattia mentale, sulla scienza e, quest’anno, sulla libertà. Il prossimo anno ne facciamo uno sul gioco. Affrontiamo insomma tutto ciò che è in relazione con la parola immaginario.
AeA: Il tuo elogio dell’immaginazione non è un po’ anche un elogio delle identità?
S.B.: Più che dell’identità, dell’unicità.
Nell’immaginazione ci sono due mostri. Uno è l’Aleph. Ognuno partecipa all’immaginazione di tutti, legge libri che altri hanno scritto, ed è bellissimo poter partecipare a dei racconti, a dei sogni, che appartengono a tutti.
Questa è la socievolezza dell’immaginazione.
Poi c’è l’unicità, che non è separatezza e che vuole dire che se io ti chiedo qual’è il tuo Pinocchio, qual’è la tua Alice nel Paese delle meraviglie, qual’è il tuo Don Chisciotte, so che questo è diverso dal mio e che in quanto tale va rispettato.
Non abbiamo, nè dobbiamo avere tutti, come fa credere la televisione, le stesse tre o quattro figure in testa. L’unicità della propria immaginazione è assolutamente un diritto dovere perchè è qualcosa che ha che fare con la personalità, la capacità di scegliere, con l’autonomia come scelta culturale, che è come dire ciascuno di noi sceglie quali libri prendere, non se li fa raccontare da altri. E questo non coincide, tranne che in casi rari di dandismo, di snobismo, con una separatezza dagli altri. Anche perchè l’immaginazione o è nutrita dall’Aleph di tutti gli altri o si immiserisce.
Follonica, 14 – 15 Gennaio 2020
Scuola Elementare Gianni Rodari, Istituto Comprensivo Follonica 1
Ludoteca Il paese sottosopra
Altrimondi, Libreria, Bistrot e Oltre
Scuola Elementare don Lorenzo Milani, Istituto Comprensivo Leopoldo II di Lorena





































































Zia Carolina ci sarebbe stata proprio bene in un romanzo di Cesare Pavese, che le vite delle donne contadine del suo tempo scorrevano tutte più o meno alla stessa maniera, nella valle del Belbo come nei paesi interni tra il Volturno e il Garigliano.
Alta, essenziale nel viso, nei gesti e nelle parole e poi le rughe che le donne della sua generazione se le sono davvero guadagnate tutte, una a una.
Me la ricordo con gli occhi belli, la voce che con il passare degli anni è diventata sempre più un sussurro, e il carattere mite, gentile, elegante come sanno essere le contadine, anche quando la scorgevi in piedi in un angolo, furtiva, con il collo di una gallina tra le mani, che a lei di mangiarla a tavola seduta proprio non gliene teneva (non ne aveva voglia).
Non ricordo di aver sentito da lei un lamento, al massimo un sospiro; certo, magari per quello ci sono state sempre le sue meravigliose figlie, Flora e Silvana, però io mi sono fatto l’idea che non è stata solo questione di opportunità e di confidenza, è che le donne come lei dalla vita prendono quello che la vita dà, senza fare troppe storie, senza fare troppi commenti.
Ricordo che nei giorni buoni mia madre, di qualche anno più piccola, andava quasi ogni pomeriggio a trovare la sorella, “vado un poco a casa di zì Carolina”, diceva, e a volte più tardi pure io la raggiungevo e non lo so se funzionava così anche prima del mio arrivo, ma loro se ne stavano lì più a bisbiglare che a parlare, e molto di più in silenzio, che erano di quelle più portate ad ascoltare che a parlare.
Anche nei giorni cattivi è stato così, per esempio quando mamma è stata ostaggio della interminabile malattia che l’ha portata alla morte, e zia Carolina veniva, si sedeva, ascoltava, raramente commentava, ma c’era, perché sapeva quanto fosse importante per la sorella.
Ecco, in questo tempo troppo spesso assordante e invadente l’insegnamento che porterò sempre con me di zia Carolina è che si può essere affettuosi, accoglienti – la casa di zio Teobaldo, di zia Carolina, di Flora e Silvana per noi Moretti è stata sempre aperta, di più, spalancata – senza fare ammuina, senza frastuono, semplicemente, perché è così che si fa, rispettando il proprio daimon, mantenendo la propria autenticità.
Ciao zia Carolina, se, come certe volte persino io spero, avete ragione voi e ho torto io, salutami mamma. Ti voglio bene.
vincenzo

Le bimbe e i bimbi del i.C. Follonica 1 di Follonica in visita al caseificio con la loro maestra Irene Costantini. Per saperne di più leggete qui.
INDICE STORIE SINGOLE SU INTERTWINE
Nino Anacleria

PROGETTO DI RIFERIMENTO
A scuola di lavoro ben fatto, di tecnologia e di consapevolezza
STAZIONE PICCOLO PRINCIPE
Lavoro ben fatto, tecnologia, consapevolezza: stazione Piccolo Principe
SCUOLA
I. C. Samuele Falco di Scafati
Dirigente Scolastico: Prof. Domenico Coppola
CLASSE
Seconda Media Sezione G
BOARD
Loredana Ricchiari, Elvira de Marco, Vincenzo Moretti
DIARIO
@23 Settembre 2017;
23 SETTEMBRE 2017 Torna al Diario
Caro Diario, il prossimo Mercoledì 27 Settembre ritorno a Scafati, dove, come di certo ricorderai e in ogni caso puoi rivedere qui, l’anno scorso le ragazze e i ragazzi della Prima G insieme alla prof. Loredana Ricchiari hanno fatto un ottimo lavoro.
Ti voglio dire che sono molto contento di tornare a lavorare e a inventarci cose con le/i ragazze/i della 2 G e con le mie amiche e i miei amici prof., e che sono molto contento anche di conoscere il nuovo Dirigente Scolastico, il prof. Domenico Coppola, che ti devo dire la verità quando ho saputo che Anna Pumpo si era spostata a Milano un po’ mi ero preoccupato, perché sai in questo Paese non è mai facile trovare persone che hanno l’intelligenza, la passione e la disponibilità per ricominciare da tre e non da zero, e invece questa volta è accaduto, e ne sono felice assai.
Che ti devo dire amico mio, sarà che quest’anno la prof. Loredana e io speriamo di coinvolgere di più anche la prof. Elvira de Marco e il prof. Giorgio Simeoli, sarà che le/i ragazze/i continuano a chiedere quando incominciamo, sarà che con noi ci sarà Il Piccolo Principe, ma mi sto facendo l’idea che ne vedremo delle belle, e se riusciamo a organizzare tutto come si deve la Secondo G un giorno la portiamo anche all’università. Vediamo, come mi ha detto la prof. Maria D’Ambrosio quando gliene ho parlato, se le cose le possiamo pensare le possiamo anche fare. A mercoledì.

CASI DI STUDIO
2017 – 2018
Il Piccolo Principe all’Università
Il Piccolo Principe al 33° Circolo Didattico Risorgimento
Il Piccolo Principe al I. C. Samuele Falco Scafati
Un tuffo nel passato
Stazione Follonica: I.C. Follonica 1
Stazione Modugno: 3° Circolo Didattico Don Lorenzo Milani
Stazione Porchiano: I. C. Bordiga Porchiano
Stazione Scafati: I. C. Samuele Falco
Stazione Università: Comunicazione e Cultura Digitale 2016 – 2017
Stazione Scampia: ITI Galileo Ferraris
Stazione Roma: Istituto Comprensivo Pablo Neruda
Stazione Torre Annunziata: Liceo Artistico Giorgio de Chirico
Stazione Soccavo: 33° Circolo Didattico Risorgimento
Stazione Ponticelli: I. C. Marino Santa Rosa
Stazione Marcianise: Istituto Novelli
Stazione Nola: Liceo Carducci
LIBRI E BLOG
L’uomo che aggiustava le cose
Il coltello e la rete
#Lavorobenfatto
#LavoroBenFatto. Industria culturale 3.0 e …
Testa, Mani e Cuore
Questo lo avete scritto voi
BOOKTRAILER
AUDIOBOOK
Pagine lette da me
L’intervista a Run Radio
ARTICOLI, RECENSIONI, COMMENTI
Se parliamo di libri con Vincenzo Moretti l’uomo che crede nel lavoro ben fatto, Napoli.Repubblica.it
Se parliamo di libri e di lavoro ben fatto, Repubblica TV
Se parliamo di libri con Vincenzo Moretti, Napoli.Repubblica.it
Se Parliamo di Libri Repubblica Napoli (Video completo)
L’uomo che aggiustava le cose: l’ebook di vincenzo moretti, Popfilosofia.it
Le recensioni su Amazon
STORIA SERIALE
22 Febbraio 2017; 1 Marzo 2017; 2 Marzo 2017; 7 Marzo 2017; 12 Marzo 2017; 16 Marzo 2017; 20 Marzo 2017; 24 Marzo 2017; 27 Marzo 2017; 2 Aprile 2017; 16 Aprile 2017; 27 Aprile 2017; 5 Maggio 2017; 11 Maggio 2017;
22 Febbraio 2017 Torna al Diario
«Pà, allora sei pronto?»
«Direi di sì, Riccardo. Tuo fratello sta finendo gli ultimi controlli, il Primo di Marzo dovrebbe essere su Amazon, speriamo che qualcuno lo compri e lo legga.»
«Il tuo problema è che la maggior parte delle persone che ti segue sono come te, imbranate quando devono fare un acquisto online, poi c’è la faccenda di Kindle che si deve scaricare l’app per leggerlo, insomma non la vedo facile.»
«Riccà, mi sembri Attilio, il suggeritore di Uomo e Galantuomo, quello di “nun se leva, nun se leva”, e dimmela una parola di speranza.»
«Allora ti debbo illudere?»
«Vabbè ja, ne parliamo un’altra volta, quando fai così mi fai innervosire.»
[RISATE]
1 Marzo 2017 Torna al Diario
Il racconto esce su Amazon.
[SCONGIURI]
2 Marzo 2017 Torna al Diario
«Pà, una mia amica mi ha chiesto chi può leggere il tuo racconto.»
«Riccardo, dagli 8 anni fino all’infinito e oltre lo può leggere chiunque, se è un papà o una mamma che lo legge anche 6 anni vanno bene. Però non è una favola per ragazzi, è il lavoro raccontato a un ragazzo, che è diverso, perché dice tante cose anche agli adulti, e lo fa in modo commovente, magico, fantascientifico, nel senso che …»
«Pà, fermati, vedi che non lo devo comprare io il tuo racconto.»
[SOGGHIGNO]
7 Marzo 2017 Torna al Diario
«Pà, sei contento di come sta andando il tuo racconto su Amazon?»
«Abbastanza.»
«Pà, ma mò fai il diplomatico con me? Che risposta è abbastanza?»
«Riccardo, certe volte non tanto ti sopporto. Allora, sono contento perché a chi lo ha letto è piaciuto assai, si capisce anche dai commenti. Non sono contento perché vorrei che a leggerlo fossero molte/i ma molte/i di più.»
«Beh, certo, su questo hai ragione, se fosse uscito mercoledì scorso le persone che lo hanno comprato sarebbero anche tante, ma essendo uscito sei mesi fa la cosa è preoccupante.»
«Riccà, lo sai dove devi andare?»
«Ah, non si dice …»
[ELOQUENTE GESTO DELLA MANO]
12 Marzo 2017 Torna al Diario
«Pà, ieri sera ho letto le recensioni al tuo racconto su Amazon.»
«Sono contento Riccardo, grazie.»
«E di che. Sono molto belle. Ma sono tutte di persone che conosci?»
«Quelle firmate si, quelle anonime alcune si, altre non lo so.»
«Però che amici belli che hai, leggono, lasciano i commenti, e poi si capisce che sono veri, non è roba appezzottata.»
«Ahahahah, è vero, niente pezzotti, solo cose originali. Il fatto è che gli amici non bastano, bisogna che il racconto raggiunga un pubblico più vasto, ci vorrebbe un’idea per …»
«Pà, questo già me l’hai detto, vedi che il racconto è bello, secondo me con il tempo i lettori arrivano, però tu stai sciolto, non ti fissare. Come dice il papà di Luigino? Quali sono i due verbi più importanti nella vita?»
«Ascoltare e aspettare.»
«Appunto!»
[SORRISI]
16 Marzo 2017 Torna al Diario
«Pà, questo fatto che si può leggere qualche pagina del libro prima di comprarlo mi sembra una cosa buona.»
«Pure a me, Riccardo.»
«Una mia amica ti ha anche postato in un gruppo di lettori su Facebook.»
«Anche questa è una buona cosa, buona assai, però ce ne vorrebbero centinaia, migliaia.»
«Sì, ‘nu milione. Azz pà, ma tu stai sempre di una maniera.»
«Non sto sempre di una maniera, sto sul punto, che è diverso. Se non fossi stato sempre sul punto più della metà delle cose belle che ho fatto nella mia vita non le avrei potute fare. Funziona come diceva Edison figlio mio, 1% ispirazione e 99% fatica.»
«Ecco, arrivati alla citazione me ne posso tornare a casa.»
«E no, io da qui non ti faccio uscire se prima non ammetti che questa volta tengo ragione.»
[RISATE]
20 Marzo 2017 Torna al Diario
«Pà, questo fatto che da grande vuoi fare lo scrittore mi piace.»
«Sono contento Riccardo.»
«No, perché sai, non dico che sei vecchio, però a 62 anni non è che è facile che uno dica che da grande vuole fare qualcosa.»
«Azz. Riccà, non vuoi dire che sono vecchio, e se lo volevi dire che dicevi, che mi devo togliere la targa e andarmene allo scasso?»
«Pà, ti ho detto che mi piace e tu pure fai polemica?»
«Non faccio polemica, sono preciso. Tu hai detto che ti piace, ma hai pensato che sono vecchio.»
«No, nun c’a pozz fa, addesso leggi pure nel pensiero.»
«E le soprese non finiscono qui.»
«No no, le sorprese finiscono, finiscono, perché io me ne torno a studiare.»
[CIABATTE DI PEZZA CHE VOLANO]
24 Marzo 2017 Torna al Diario
«Ciao pà che fai, ridi da solo?»
«Ciao Riccardo, si, sono contento. La mia amica Concetta ha recensito il racconto su Amazon, e naturalmente io nella chat l’ho ringraziata, e allora lei mi ha inviato una mail.»
«Fammi leggere.»
«Eccola: Ciao Vincenzo, bello davvero il racconto, complimenti. Non occorrono ringraziamenti. Solo un piccolo appunto: i ragazzini di 11 anni non parlano così bene e in modo così articolato. Baci.»
«E tu?»
«Io le ho scritto questo: Ciao Concetta, un bacione a te. È vero quello che dici, è un problema che ci siamo posti anche io e Luca, mio figlio, che mi sta aiutando in questa avventura, tanto è vero che fino a un certo punto Luigino aveva 10 anni e poi lo abbiamo passato a 11. Però ci stanno delle eccezioni, io per esempio qualche settimana fa ho conosciuta una bambina, Valentina, figlia di un amico, che ha 8 anni ed è quasi come Luigino eheheheh. Insomma il ragazzo è un po’ particolare, come si vedrà nel secondo e ancor più nel terzo episodio. Comunque grazie assai per avermi segnalato questa cosa, per me è molto importante, perché lo so bene che le recensioni delle amiche amiche come te un po’ sono condizionate dal rapporto personale, che magari gli avresti dato 4 stelle e non 5, uno dei motivi per cui non pubblicizzo molto amiche e amici è questo. Il fatto che tu ti sia presa cura di segnalarmi comunque quello che secondo te non andava dice molto sulla bellissima personea che sei. Grazie ancora.»
«Bello questo scambio di mail.»
«Aspetta che non è finito, guarda lei cosa mi ha risposto a sua volta: So con chi ho a che fare, sapevo che non ti saresti offeso. Un abbraccio grande, aspetto il prossimo. Ah, dimenticavo. 5 stelle sempre!»
«Pà, che belle amiche che tieni.»
«Già.»
[SORRISI MOLTO LUMINOSI]
27 Marzo 2017 Torna al Diario
«Pà, come va il nostro uomo che aggiusta le cose?»
«Riccardo, nun va.»
«In che senso non va?»
«In che senso, nel senso che da un paio di giorni si è fermato, nessuno lo compra e lo legge.»
«Ma come, ho visto che stai già a 30 recensioni.»
«Da quel punto di vista funziona, ce n’è anche una 31esima di una ragazza di 8 anni, Valentina, che non sta su Amazon ma è bellissima.»
«Si, ieri ho letto il post.»
«È che non riesco a farlo uscire dal giro degli amici, che pure loro non è che posso stressarli troppo, bisogna dargli il tempo, alla fine su 100 che si dicono entusiasti poi una ventina prendono il libro e lo leggono, e di questi più o meno 6 lo commentano.»
«Azz. pà, si vede che sei sociologo, tieni tutto sotto controllo. Comunque dai, non ti abbattere.»
«E chi si abbatte Riccà, tu mi hai fatto una domanda e io ti ho dato una risposta.»
«Questo è vero. Vedrai che prima o poi trovi anche la risposta a come farlo uscire, come dici tu, dal giro degli amici.»
«Lo penso pure io, ‘o ssaje, io song comme ‘o pappice, un poco di tempo ci metto, ma ‘a noce ‘a spertosa.»
[RISATE SAPORITE ASSAI]
2 Aprile 2017 Torna al Diario
«Pà, come va? Oggi quando ti ho sentito al telefono tenevi ‘o core int’o zucchero.»
«Si Riccardo, il racconto sta piacendo, stanno arrivando recensioni bellissime, adesso bisogna solo …»
«… Allargare il giro.»
«È inutile che sfotti, Riccà. Si, bisogna allargare il giro.»
«E allora allarghiamolo.»
«Se non la finisci ti caccio. Io sto facendo l’impossibile per allargarlo, tu invece?»
«Pà, ma non essere assurdo, che io tra università, studio e un poco di vita sto sempre impicciato. E poi sono tuo figlio, che faccio, scrivo su Facebook Accattateve il racconto di papà?»
«A parte che anche quella potrebbe essere un’idea carina, lo sai cosa ha fatto una mia amica dopo aver letto e recensito il libro su Amazon?»
«Che ha fatto?»
«Ha scritto una mail per le amiche e gli amici che non usano i social, ci ha messo la sua recensione, il numero complessivo di recensioni con le stelletelle, un po’ di link compresa l’anteprima e la pagina dove si compra il libro, un chiaro invito a leggere il racconto e l’ha inviata.»
«Azz.»
«Ecco. Mò tu immagina se fossero in 100 a fare la stessa cosa.»
«E se fossero in 1000?»
«Vattenne altrimenti ti suono una scarpa in testa.»
[ABBRACCIO E FUGA]
16 Aprile 2017 Torna al Diario
«Senti pà, prima di salutarti, che tanto poi domani pomeriggio ci vediamo, volevo chiederti ma com’è che l’hai chiusa la nostra web serie?»
«Riccardo, non è che l’ho chiusa, ma se non posso taggare neanche te che l’ultima volta mi hai fatto un cazziatone – in senso metaforico si intende – mi dici che la tengo aperta a fare?»
«Innanzitutto non fare la vittima che io non ti ho fatto nessun cazziatone, né metaforico né letterale.»
«E ci mancava pure questa!»
«Appunto. Io ti ho detto soltanto che sulla mia bacheca ci stanno solo i post tuoi. Comunque non voglio fare polemica, volevo sapere se ci sono novità con il racconto.»
«Azz, non vuoi fare polemica, e se la volevi fare. Vedi che dato che io racconto delle nostre chiacchiere intorno al racconto ogni 2-3 giorni, se sulla tua bacheca ci stanno solo i miei post significa che tu Facebook non lo usi, dunque il problema è tuo non mio.»
«E ti pareva!»
«Si, mi pareva. Ciò detto, il racconto va. Piano, ma va. Continuo ad avere riscontri molto positivi e tra un po’ dovrebbe cominciare ad arrivare qualche recensione anche su qualche rivista. Lo sai com’è in queste cose, ci vuole tempo.»
«Pà, io lo so che ci vuole tempo, non sono del tutto convinto che lo sai tu.»
«Riccà, lo sai dove devi andare?»
«Certo, a mangiare una fetta di pastiera.»
«Ecco, rimaniamo così. Ci vediamo domani.»
«A domani pà, mi vengono a trovare un po’ di amici, comunque a un certo punto passo a salutarti.»
«Si, vieneme ‘a truvà, sto a Bellavista.»
[BOFONCHIAMENTI VIA GSM]
27 Aprile 2017 Torna al Diario
«Pà, ho visto il Video di Repubblica, mi è piaciuto un sacco.»
«Sì Riccardo, è stato bello e anche divertente; Cristina, Pier Luigi e Paolo sono molto bravi, secondo me ha funzionato.»
«Pure secondo me, ho visto che anche le due persone che stavano lì nella sala sono stati al gioco.»
«Sì, molto carini pure loro, poi ho scoperto che sono di Padova, alla fine lui si è preso anche la copertina del libro che Cristina aveva stampato, mi sono sembrati interessati, del resto questa storia del lavoro ben fatto prende molto.»
«E invece il racconto?»
«Il racconto va, va piano ma va, adesso con questa cosa dell’intervista magari il passa parola diventa più facile.»
«Pà, te l’ho detto, tu ti sei ingrippato con questa storia dell’ebook, il tuo pubblico ama la carta, tu stesso quando devi comprare qualcosa in rete ci metti una vita, e lo fai solo se non sei riuscito a passare l’impiccio a me o a Luca.»
«Riccà, tu sei più tosto di tuo nonno Pasquale, e io già ho dovuto combattere una vita con lui da figlio non ho la forza fi ricominciare daccapo con te da padre. Allora: uno, io non mi sono ingrippato, ho deciso di sperimentare una nuova possibilità, il cambiamento all’inizio creare più problemi di quelli che risolve, ma con il tempo le cose cambiano; due, come ti ho detto già 100 volte, ma tu non ascolti, come del resto tuo nonno, verrà anche il tempo della carta, quando tutti e tre i racconti che compongono questa mini serie saranno stati pubblicati; tre, certe volte sembra che tu lo faccia apposta a inquitarmi, e questo non si fa, perché papà tuo si sta facendo vecchio, e con la vecchiaia si fa più fatica a controllarsi, non so se mi spiego.»
«Ti spieghi, ti spieghi. Posso dire liberamente quello che penso o il vecchietto si disturba?»
«Certo che puoi.»
«Perfetto, però poi ricordatelo che te l’ho chiesto. Uno: tu ti fai vecchio e ti fai giovane quando vuoi tu, perciò con me non la fare questa parte, perché ti conosco; due, quando dici che io e nonno Pasquale non ascoltiamo mi sembri ‘O ciuccio che chiamma recchia longa ‘o cavallo; tre …
«… tre Riccardo mo’ se non la finisce ti do’ una capata.»
«Va bene, cedo alle minacce, mi arrendo.»
[GRANDI RISATE E DAMMI IL CINQUE A ZUFFUNNE]
5 Maggio 2017 Torna al Diario
«Pà, mi è piaciuto il commento che hai scritto rilanciando la recensione del lettore che è rimasto un po’ deluso dal racconto e ti ha dato solo tre stellette, che poi solo si fa per dire, che anche quella non è male come valutazione.»
«Si, c’è sempre una prima volta, naturalmente avere commenti più positivi fa più piacere, ma ci sta anche la delusione e vedrai che prima o poi arriveranno anche quelle/i che non gli piace per niente, fa parte delle possibilità, e poi lo sai come la penso, si migliora con le critiche non con i complimenti.»
«Ah, così la pensi? Allora sai mo’ che faccio, scrivo una bella recensione che dice che il tuo racconto è ‘nu purpo eheheheh»
«Riccà, ma è possibile che ce la devi mettere sempre tutta per farmi innervosire?»
«Uà pà, e come ti innervosisci presto, con te non si può scherzare.»
«Va bene, questa volta ho torto io, puoi scherzare, però insomma quello che volevo aggiungere è che a volte una cosa ti piace di più o di meno a seconda delle aspettative che hai e del momento in cui leggi quel racconto, guardi quel film, ascolti quella canzone.»
«Si, capita anche a me, bisogna anche essere predisposti per godersi una determinata cosa. Ma non è che tu mo’ dici questo perché te la sei presa per il commento del lettore?»
«No Riccardo, non dire sciocchezze, non me la sono presa, ciascuno ha il diritto di dire quello che pensa, ci mancherebbe altro. Cerco semplicemente di capire, di cogliere il più più possibile il senso di quello che le lettrici e i lettori dicono o scrivono.»
«Pà, adesso me ne devo andare, tra 5 minuti parte il pulmino e …»
«Ciao Riccardo, non perdere il pulmino ‘e chi te viecchio. Ma possibile che ogni volta che passi di qua tieni sempre ‘a neve int’a sacca?»
«’O sapevo. Ma delle volte che vengo, mi siedo, ti chiedo come va e tu continui a scrivere e a chatatre come se niente fosse non dici niente?»
«Riccardo, vai, altrimenti perdi il pulmino.»
«Si, mo’ lo voglio perdere, resto qui un’altra mezzora, però tu chiudi il Mac per tutto il tempo.»
«Riccà vattenne!»
«Obbedisco!»
[GIVE ME FIVE ‘A VOLO ‘A VOLO]
11 Maggio 2017 Torna al Diario
«Uè pà, allora come va?»
«Bene Riccà. La notte scorsa ho sognato l’uomo che aggiustava le cose.»
«Papà, te lo posso dire?, tu ti devi far vedere, non è possibile che ti sogni il libro anche di notte.»
«Riccardo, innanzitutto se dici “te lo posso dire?” aspetta che io ti risponda prima di proseguire.»
«Pà, poi dici che sono io e invece sei tu che ogni volta fai polemica; lo sai bene che è un modo di dire.»
«In secondo luogo io non ho sognato il libro, ho sognato proprio lui, Mastro Giuseppe, l’uomo che aggiustava le cose.»
«Azz. E com’era?»
«Aveva la faccia di mio padre, però io nel sogno non lo sapevo che era lui.»
«Ecco, questo mi piace. Del resto, da quello che racconti, il nonno ci stava bene nella parte.»
«È vero, papà sapeva aggiustare tutto, e sulle cose importanti era pure lui un filosofo, magari non sapeva usare le parole con la stessa appropriatezza di mastro Giuseppe, ma la sostanza c’era tutta.»
«E allora dai, racconta, cosa avete fatto nel sogno, cosa vi siete detti?»
«Riccardo, mi ricordo solo che è stato bellissimo, che ero felice, per il resto non mi ricordo niente.»
«Come non ti ricordi niente.»
«Niente Riccà, né una parola, né un gesto, nulla, zero assoluto.»
«Pà, tu stai ‘a piezz, ti devi far vedere assolutamente, ma come è possibile una cosa così.»
«È possibile, capita a tanta gente, ti rimane il sapore di quello che hai sognato e niente più, e a me è rimasto il sapore di felicità, va bene accussì.»
«Pà sei unico, ti voglio un sacco di bene.»
«Pur’io.»
[ABBRACCIONE]
RACCONTO
È il mio nuovo racconto. È uscito oggi su Amazon. Lo potete comprare sul sito di Amazon o anche cliccando sull’immagine sotto.
Spero che siate in tante/i a leggerlo. E se dopo che lo avete letto scrivete un commento sincero su Amazon quando venite a Napoli vi offro il caffè. A prescindere. Anche se scrivete che non vi è piaciuto. La sincerità questo è, che ciascuna/o scrive quello che veramente pensa.
Solo due altre cose prima di augurarvi buona lettura: la prima è un grazie pieno di affetto a Luca Moretti, Geremia Pepicelli, Cinzia Massa e Irene Gonzalez, un grazie che va molto al di là delle ragioni che trovate scritte nel libro; la seconda è che anche se l’ebook è in formato kindle lo potete leggere su qualsiasi dispositivo, basta scaricare la app gratuita in bella evidenza anche sulla pagina di Amazon. Buona lettura.

 Vado subito al punto, dunque sarò necessariamente schematico, anche perché su questo punto con i pochi amici con i quali ancora parlo di queste cose insisto da almeno due anni: da tempo il Partito Democratico come progetto politico ha esaurito la sua spinta propulsiva, si è dimostrato incapace di interpretare e fare sintesi della domanda e dei bisogni di quel pezzo composito di società che intendeva rappresentare, per intenderci una buona parte di coloro che – come me – si riconoscevano nel progetto e nel programma politico del PCI e una parte – di fatto non altrettanto significativa – di coloro che invece si riconoscevano nella DC, nel PSI e in altri partiti minori.
Vado subito al punto, dunque sarò necessariamente schematico, anche perché su questo punto con i pochi amici con i quali ancora parlo di queste cose insisto da almeno due anni: da tempo il Partito Democratico come progetto politico ha esaurito la sua spinta propulsiva, si è dimostrato incapace di interpretare e fare sintesi della domanda e dei bisogni di quel pezzo composito di società che intendeva rappresentare, per intenderci una buona parte di coloro che – come me – si riconoscevano nel progetto e nel programma politico del PCI e una parte – di fatto non altrettanto significativa – di coloro che invece si riconoscevano nella DC, nel PSI e in altri partiti minori.
Come si può scrivere in un post come questo (che non è un saggio) direi che nel corso degli anni, non solo questi ultimi, la difficoltà a «dire qualcosa di sinistra» si è fatta sempre più evidente, complici la perdita di egemonia culturale, i vincoli di bilancio posti dalla Germania e subiti dagli altri paesi, la scarsità di elite e classi dirigenti all’altezza delle sfide sociali, politiche ed economiche poste dalla contemporaneità.
Non è certo un caso che le difficoltà accomunino la sinistra in tutta Europa e più in generale il fronte democratico e progressista nel mondo. Ripetiamolo: nella contemporanietà la sinistra ha da molto tempo una diffusa difficoltà a intercettare le domande che vengono dal «popolo», dalla «gente», sempre meno dai «cittadini» dato che il concetto di cittadinanza presuppone un rapporto con le libertà, i diritti e i doveri sempre meno presupposta negli americani che si riconoscono in Trump o negli europei che si riconoscono in Le Pen, in Grillo e Casaleggio, in Erdogan, in Salvini e compagnia cantante. Non c’è più soltanto, forse neppure prevalentemente, una questione di programmi, c’è una questione di riconoscimento, di identità, di velocità, di delega, di ricerca di donne e uomini forti a prescindere dalla loro capacità di risolvere problemi, insomma di governare. Da questo punto di vista, Roma mi pare un esempio paradigmatico di questo stato di fatto – ma di questo magari ragionamo in un’altra occasione.
Ritornando al punto: dopo la sentenza della Corte Costituzionale e con il nuovo sistema elettorale che da essa è scaturito (e del quale comunque bisognerà tener conto nell’eventuale approvazione di una nuova legge elettorale da parte del Parlamento), conviene presentarsi al voto con due liste, una del PD di Renzi, e un’altra – la chiamo per comodità il PD di Bersani, D’Alema e Altri – che dopo le elezioni, se ci sono le condizioni in termini di voti e di seggi parlamentari, si siede e stipula un patto di alleanza basato su un programma di governo.
Si, quello che penso io è che la somma dei voti che vanno al PD di Renzi con quelli che vanno al PD di Bersani e D’Alema sarà maggiore dei voti che prende il PD se continua la coabitazione forzata di Renzi, Bersani, D’Alema.
A sostegno di questa mia affermazione ricordo innanzitutto che tenere assieme cose diverse non ha mai portato bene alla sinistra dal punto di vista dei voti elettorali.
È stato così dal 1948 con il Fronte Democratico Popolare fino al «i Progressisti» (PDS, PRC, Verdi, Partito Socialista Italiano, Alleanza Democratica, La Rete ed altri) del 1994, dall’apparentamento con Di Pietro del 2008 fino alla recente esperienza con Vendola nel 2013.
In secondo luogo, penso che il PD di Renzi abbia dei suoi elettori, dei suoi tifosi e anche dei suoi ultras, che naturalmetne sono assai lontani dal 40 percento di cui parla l’ex leader ma hanno comunque una loro forte consistenza, come lo stesso risultato del recente referendum dimostra. Lontani dalla demagogia, e fermo restando la sonora e meritata sconfitta dell’ex Presidente del Consiglio, i voti presi dal Si con i problemi che ha il Paese e avendo contro praticamente tutti compresa una parte significativa del suo partito – in particolar modo al Sud – non sono affatto pochi. Penso che sarebbe interessante ragionare seriamente del perché Renzi ha questo seguito, ma non si può fare adesso e soprattutto non si può fare qui.
In terzo luogo, considero molto realistica la possibilità che il PD di Bersani D’Alema e Altri raccolga un risultato elettorale a due cifre. Anche in questo caso le ragioni di questo mio convincimento sono tante, ne cito una sola perché riguarda quelli come me, quelli che che ritroverebbero per questa via le ragioni e le motivazioni per ritornare a votare, cosa che personalmente non faccio da un po’ perché non mi riconosco in questo PD né in piccole formazioni di sinistra – sinistra che almeno un tempo avevano il pregio di proporre cultura, idee, progetti, ma oggi fanno fatica – al di del valore dei singoli – a venir fuori dal triangolo potere, demagogia, burocrazia.
Perché lo voterei? Anche qui mi le risposte sono tante e richiedono un saggio perciò mi limito a una sola: perché penso che nel nuovo scenario – ammesso e non concesso che ci saranno i numeri per governare – la parte di Renzi la farà già lui – credo sia non solo necessariamente ma anche oggettivamente il più bravo in quella parte lì – e dunque il PD che voto io per dare senso alla sua esistenza dovrebbe necessariamente tornare a dare valore e rappresentanza politica al lavoro, alle questioni sociali, alle condizioni di vita delle persone normali, alla domanda di inclusione di chi non per propria colpa e in molteplici contesti si trova in difficoltà. Tempo fa l’ho definito il partito che non c’è. Ecco, io sarei contento se ci fosse, penso di non essere il solo ad avvertirne il bisogno, e quando leggo dichiarazioni come «dopo le elezioni cercheremo di condizionarlo da sinistra» immagino cose così, anche se non le dò per scontate, ma insomma ci spero e nel mio piccolo faccio qualcosa per contrbuire a fare in modo che si vada in questa direzione.
Cio detto, aggiungo – da persona che va verso i 62 anni e a cui non piace la parola rottamazione applicata alle persone e alla politica – che se Bersani e D’Alema se ne stanno non uno, ma due passi indietro è meglio. Non solo e non tanto perché poi a un certo punto il «popolo», la «gente» e anche i «cittadini» se lo ricordano che la riforma delle pensioni non l’ha fatta Renzi ma Fornero, Governo Monti, anche con i voti di Bersani; o che il Presidente della Bicamerale che poteva fare una riforma molto migliore di quella giustamente bocciata di Renzi era D’Alema; o dei problemi che ci sono stati quando quest’ultimo è stato presidente del Consiglio e Cofferati segretario della Cgil. Anche e soprattutto perché penso che da troppo tempo a sinistra manchi un po’ di generosità, una disponibilità a fare politica senza stare necessariamente in prima fila, senza mettere ogni volta la propria prorompente personalità al primo posto, soprattutto quando al primo posto si è già stati più volte.
Cio detto, finisco davvero ricordando mio padre che mi diceva che «quando già i tempi sono difficili non è che ti puoi mettere pure tu a fare il difficile», perciò se nascesse il partito che per comodità ho chiamato qui «PD di Bersani, D’Alema e Altri» io lo voterei, che naturalmente per il futuro dell’umanità non vuol dire niente, ma per me si. Naturalmente non a prescindere, solo fine a prova contraria.
Questi i nuovi disegni della Prima C di Modugno inviati dalla maestra Francesca Di Ciaula. Se volete saperne di più sul lavoro che stanno facendo cliccate qui.






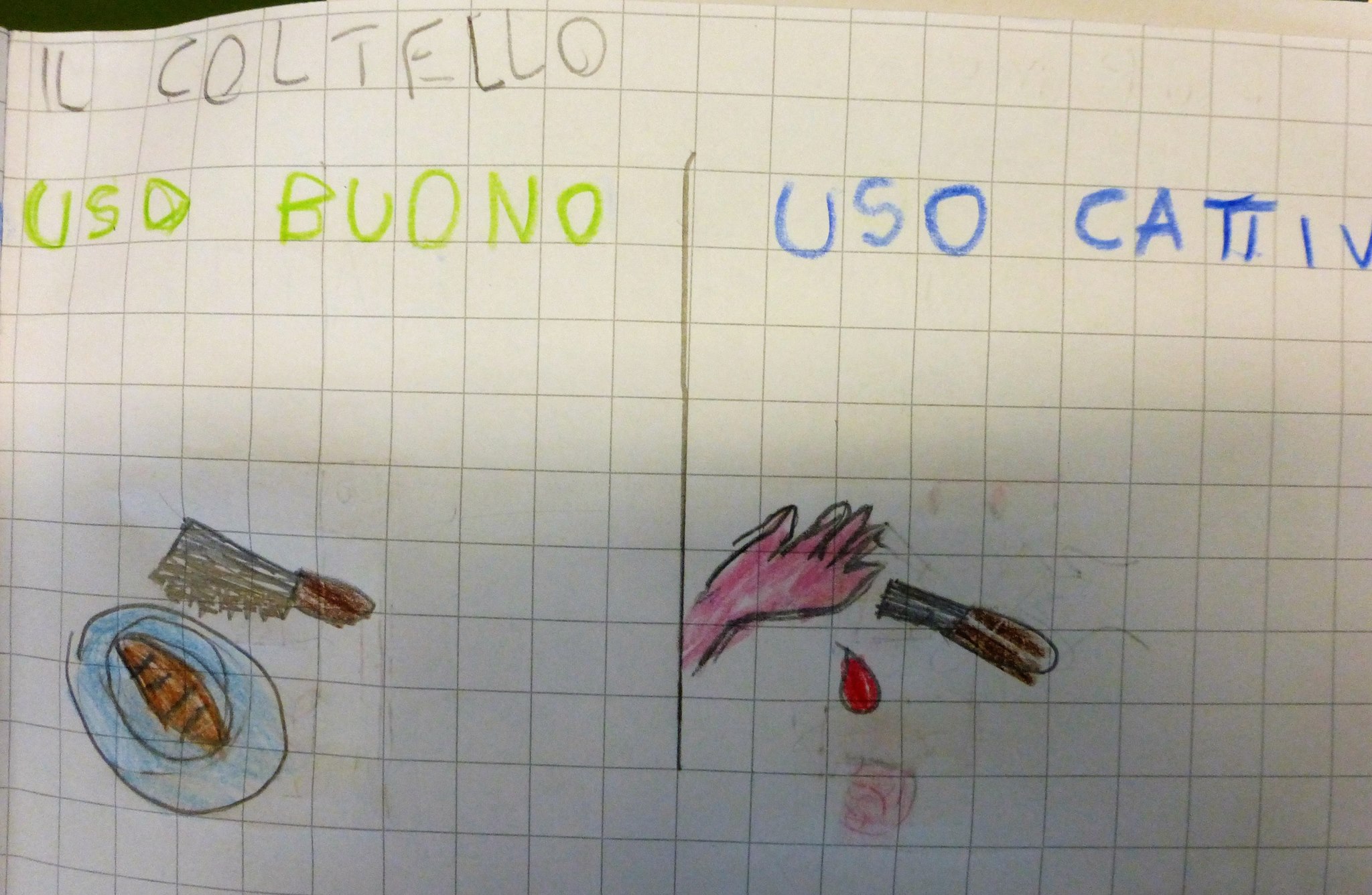






Ecco i disegni e le foto della Prima C di Modugno inviati dalla maestra Francesca Di Ciaula. Se volete saperne di più sul lavoro che stanno facendo cliccate qui.

Le foto relative ai disegni delle bimbe e delle bimbe della Prima E dell’Istituto Comprensivo 83 Porchiano Bordiga di Napoli. Per saperne di più cliccate qui, per leggere l’intera storia il link giusto è invece questo qui.
















Caro Blog, la mia amica Isa Maggi mi ha fatto un regalo. Mi ha invitato agli Stati Generali delle Donne, a Roma, per raccontare di #lavorobenfatto e di #lavoronarrato.
Accade domani Venerdì 18 Novembre a Roma. Dalle 9:00 alle 19.00. Alla Associazione della Stampa Estera in Italia, in Via dell’Umiltà 83c, e se vuoi saperne di più puoi visitare la pagina social dell’iniziativa che trovi qui.
Gli Stati Generali delle Donne saranno presenti alla quarta edizione de La notte del lavoro narrato, il 28 Aprile 2017, e insomma l’occasione è di quelle giuste per conoscersi e scambiare un po’ di idee.
Naturalmente ci sto pensando un po’ su, senza preparare cose da leggere che quando posso mi piace di più guardare negli occhi le persone mentre racconto le mie storie, ma anche senza trascurare niente, che per improvvisare bisogna essere preparati, perché altrimenti la parola giusta non è improvvisazione ma approssimazione, e l’approssimazione non ha nulla a che fare con il lavoro ben fatto.
Come dici? No, non ti preoccupare, non ti voglio anticipare la mia breve talk, sto solo facendo mente locale insieme a te, vorrei mettere in fila 3- 4 immagini, che poi le guardo e dico quello che devo dire. Si, dai, facciamo così, solo 4 immagini e 4 link, senza ulteriori commenti, che tanto se ti va di sentire puoi venire anche tu domani agli Stati Generali.
La prima immagine è questa:

Ecco la seconda:
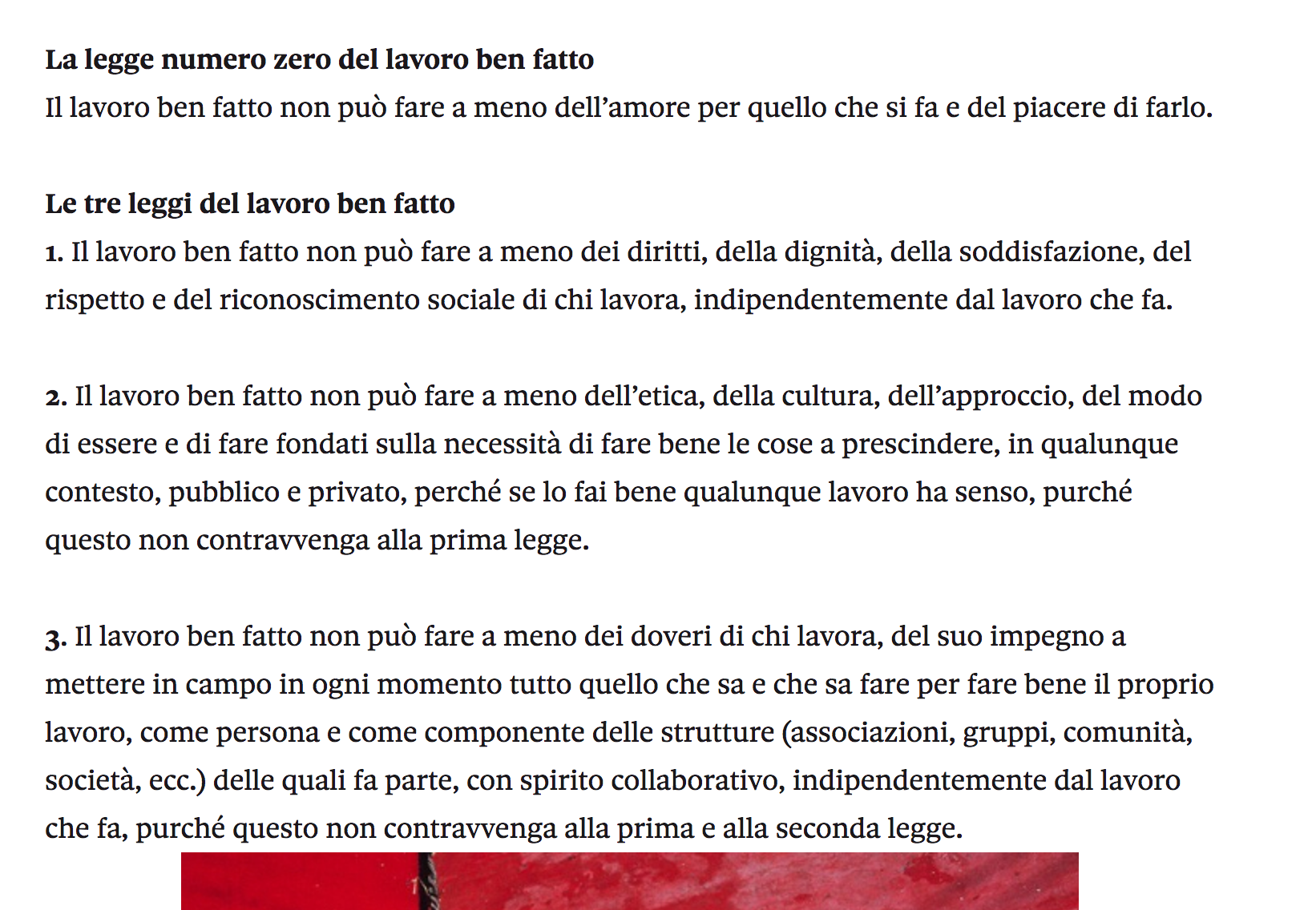
Questa è la terza:

E infine la quarta:

I 4 link sono questi:
Lavorobenfatto
La Notte del Lavoro Narrato
#lavoronarrato2017
Il Manifesto del Lavoro Narrato
Grazie. È tutto. Alla prossima.
vincenzo moretti
moretti55@gmail.com
@moretti Twitter
vmoretti Facebook
Ho ritrovato la fotocopia di questo compito di Riccardo qualche sera fa mettendo a posto un po’ di carte. Non serve che io aggiunga altro, se non che tengo due figli stupendi.
Venerdì 19 Marzo 2004
Descrivi il tuo papà
Il mio papà si chiama Enzo ed è molto alto, ha quarantotto anni ed è un po’ chiattoncello e infatti un po’ di atletica gli farebbe bene. Papà ha la testa un po’ ovale e i capelli grigi e un po’ elettrizzati come se avesse preso da poco la scossa. Ha gli occhi marrone scuro come i miei e la bocca larga come una porta e in genere mangia soltanto frutta o vegetali perché sta a dieta. Egli ha le mani morbide come un cuscino e, infatti, quando le tocco le vorrei toccare sempre. Quando ha tempo libero, in genere solo il sabato e la domenica, mi compra delle cose e io lo ringrazio tantissimo. Egli ha scritto molti libri e lavora molto, intanto io penso: sono fiero di te e ti voglio bene.
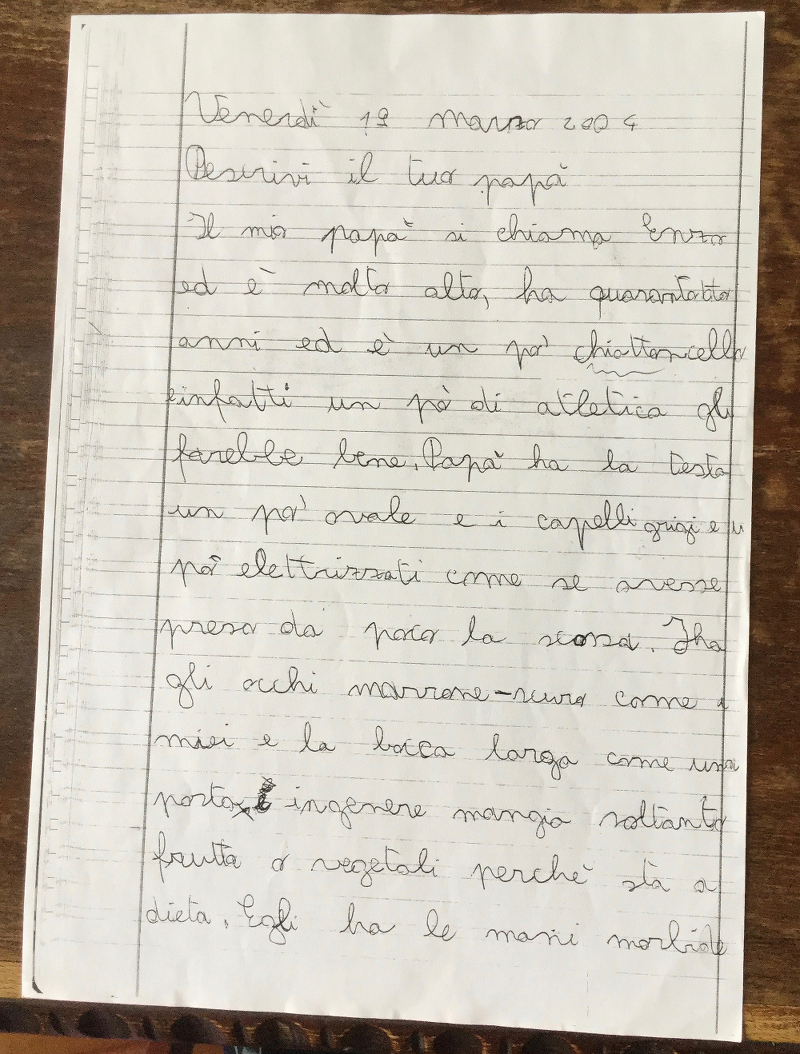
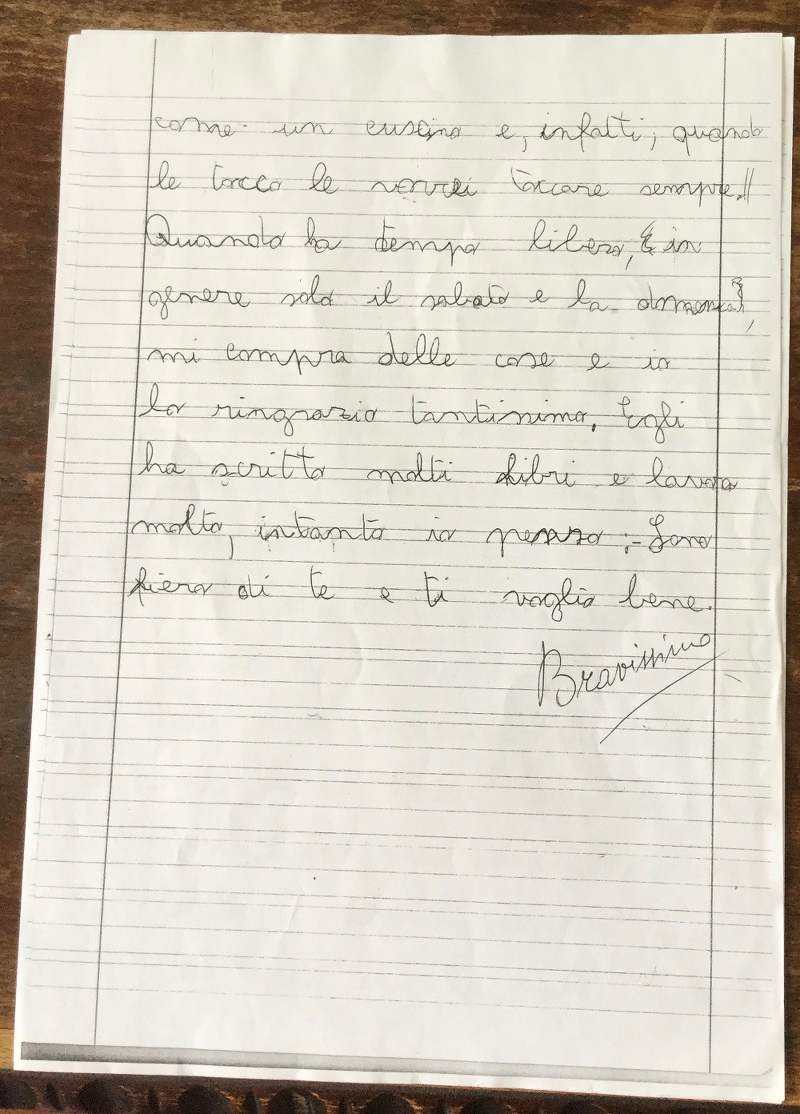
Domenica si vota da tante parti d’Italia, e mi fa piacere spendere qualche parola per tre miei amici che vorrei tanto poterli votare tutti e tre e però ne posso votare uno solo.
Prima di dirvi chi sono e perché li voterei devo dire però – non sarei io se non lo facessi – che in generale a me questa cosa di votare le persone invece che i partiti non piace, preferivo la situazione precedente, quella nella quale mi riconoscevo in un partito comunità – nel mio caso il Partito Comunista Italiano – e non avrei votato neanche mio padre, mio fratello o mio figlio se si candidavano in un partito diverso dal mio. Ciò detto, vengo al punto.
I miei tre amici sono Osvaldo Cammarota, Francesco Escalona e Tarcisio Tarquini e sono candidati rispettivamente alla Presidenza della X Mucipalità (Bagnoli Fuorigrotta) di Napoli, al Consiglio Comunale di Napoli e a Sindaco di Alatri, in provincia di Frosinone.
Non vi preoccupate, non vi racconto da quando e come ci siamo conosciuti, tutte le cose che abbiamo condiviso, le battaglie, le gioie, le amarezze, anche perché ci vorrebbe un libro e non un post, a pensarci bene un libro per ciascuno di loro. Vi dico solo alcune delle cose che secondo me li accomunano, insomma le ragioni e le motivazioni per le quali li voterei con tutto il cuore tutti e tre e invece posso votare soltanto Francesco, dato che vivo a Chiaia e non a Fuorigrotta, a Bagnoli o ad Alatri.
La prima cosa che accomuna Osvaldo, Francesco e Tarcisio è l’onestà. Lo so, dovrebbe essere una pre-condizione, soprattutto per un amministratore pubblico, ma «dovrebbe essere» non «è» e dunque io lo scrivo. Mio padre usava dire, quando mi parlava di queste cose, «pezzente era e pezzente è rimasto», laddove il concetto di pezzente andava inteso in maniera molto larga, poteva trattarsi anche di una persona agiata che però non aveva mai approfittato dei suoi incarichi per così dire moltiplicare i suoi agi. Ecco, i miei tre amici «pezzenti erano e pezzenti sono rimasti» e a me questa cosa qui «mi» piace assai.
La seconda cosa è che tutti e tre non hanno solo le loro idee – che quello è indispensabile non solo per amministrare la vita pubblica ma proprio per vivere una vita più degna di essere vissuta – ma ascoltano anche le idee degli altri, ma veramente. E se l’idea degli altri sembra loro una buona idea la adottano, la fanno loro, la sostengono, nei limiti delle loro possibilità la portano avanti.
La terza cosa è che Osvaldo, Francesco e Tarcisio le cose che dicono le fanno. Non tutte naturalmente, che quello non ci riusciamo neanche nelle nostre singole vite figurarsi quando amministri una municipalità o una città, però una parte si. E per la parte che non fanno non ti dicono che l’hanno fatta ma ti spiegano perché non l’hanno fatta, e secondo me anche questa non è una cosa da poco.
La quarta è che se proprio devono scegliere tra il più forte e il più debole – che non sempre puoi risolvere con il bene comune – loro scelgono di stare dalla parte del più debole. Non serve disturbare John Rawls e la teoria della giustizia, è che sono fatti così, per cultura, per formazione, per daimon, per codice dell’anima, per streppegna.
La quinta e ultima cosa – che non è che possiamo stare qui fino a Domenica – è che magari tanti queste cose qui le dicono, mentre loro le fanno già da una vita, e non è lo stesso.
Spero tanto che lunedì sia un giorno buono per le cittadine e i cittadini di Bagnoli Fuorigrotta, di Napoli e di Alatri. Buona partecipazione.
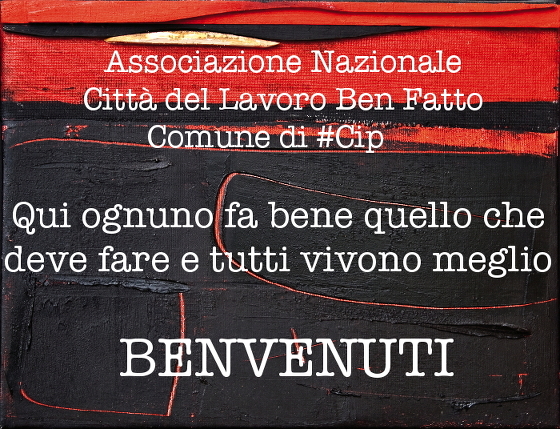
maria d’ambrosio vincenzo moretti rosaria peluso
tag keywords idee-guida
#sensemaking
#lavorobenfatto again and again
#bellezza again and again
#connettivismo again
#culturaorganizzativa
#tecnologie
#consapevolezza
#competizionecollaborazione
#intelligenzeplurali
#fareèpensare
#mitirazionali
#protesipotenziamento
#ambiente
#contesto
#spaziofisico
#scuolafamiglia
#territoriomondo
caso di studio
diario della prima A
osservazioni e valutazioni della maestra rosaria peluso
output
1. costruisci il tuo albero della conoscenza attraverso l’analisi del diario della IA.
2. indica quali sono le competenze generate e strutturate nella classe della I A e più in generale quali sono i risultati prodotti dal processo in corso.
3. presenta una proposta di tuo intervento didattico per le attività del prossimo anno della II A.
4. Proponi una tua biblioteca multimediale (dalle metodologie alle esperienze) di supporto alle attività del prossimo anno.
per saperne di più
web
#lavorobenfatto
mda enterprise
il coltello e la rete
sociologia dell’organizzazione
talento in cerca di organizzazione
libri
Electric Extended Embodied. Ambienti cognitivi (in corso di stampa)
Il coltello e la rete
#LavoroBenFatto. Industria culturale 3.0 e …
Testa, Mani e Cuore
Dizionario del Pensiero Organizzativo
Media corpi saperi. Per un’estetica della formazione
Caro Diario, il nostro treno carico carico di lavorobenfatto, di tecnologie e di consapevolezza si è fermato all’Istituto Comprensivo Bordiga – Porchiano di Ponticelli. A te non posso nascondere che sono felice assai. Con la preside Colomba Punzo, che poi fino all’anno scorso è stata maestra, ho una rapporto di lavoro e di amicizia che dura da oltre 30 anni e se tu potessi leggere quello che ha scritto ne Il coltello e la rete ti renderesti conto subito di come funziona e di come lavora. Ad ogni modo, nonostante le mille cose che si è trovata ad affrontare in questo suo primo anno da dirigente in una scuola e in quartiere di frontiera – ma perché a quelli come noi capita sempre così? – ha voluto esserci comunque, e così qualche mese mi ha messo in contatto con il professor Vito Russoniello con il quale abbiamo avviato un percorso di sperimentazione in una seconda media, la sezione C, in attesa di partire poi all’inizio del prossimo anno in maniera più strutturata.
Quello che abbiamo fatto lo puoi immaginare da te: ci siamo incontrati, abbiamo parlato di metodologia, di obiettivi, di possibili risultati e abbiamo stabilito un breve percorso pilota che preparasse noi e i ragazzi al prossimo anno. Vito ne cominciato a parlare con le/i ragazzi e così come ci eravamo detti li ha prima introdotti al concetto – significato di tecnologia, poi ha chiesto loro di fare un elenco di tutte le tecnologie di loro conscenza, poi ancora di dare una loro risposta alla domanda «che cosa sono le tecnologie?» e poi infine di intervistare i loro genitori su questi stessi temi, con una particolare attenzione all’impatto delle tecnologie sui modi di essere e di fare dei loro ragazzi. A proposito, infine è solo un modo di dire perché contemporaneamente il mitico prof. Russoniello – prendendo spunto dal lavoro portato avanti dalla prof. Antonella Tomo, dai suoi colleghi e dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Pablo Neruda di Roma, e complice un imput della preside Colomba – ha ideato un questionario con 12 domande alle quali hanno risposto 100 ragazze/i.
Le domande sono le seguenti: 1. Possiedi un cellulare?; 2. Che uso ne fai?; 3. Possiedi a casa una connessione internet? Se sì come la usi?; 4. Sul cellulare hai internet? Se sì come lo usi? I tuoi genitori lo sanno?; 5. Sei iscritto su un social Network? Se sì, quale? I tuoi genitori sanno che hai un profilo social?; 6. Ritieni importante possedere un cellulare? Se sì, perché?; 7. Lo hai acquistato di persona o è stato un regalo? Se sì, da parte di chi? A che età?; 8. Ritieni di poter “sopravvivere” senza cellulare? E perché?; 9. Il cellulare secondo te è dannoso quando navighi su internet? Se sì, perché?; 10. Il cellulare lo spegni di notte?; 11. Il cellulare lo spegni durante i compiti scolastici?; 12. Secondo te a che età bisogna iniziare ad usare il cellulare? E perché?.
Le risposte sono state elaborate dal prof. che ha sintetizzato così i principali risultati emersi:
«Dati generali: Il 100% degli studenti possiede un cellulare; Il 46% lo usa per telefonare; Il 33% lo usa anche per giocare; Il 71% lo usa per restare in contatto con gli amici e parenti con sms e chat; L’ 84% lo usa per fare foto e video, ascoltare musica o cercare informazioni in rete. L’82% delle famiglie possiede una connessione wifi a casa.
Internet sul cellulare: Il 92 % degli studenti naviga in Internet e usufruisce dei servizi on line, con i genitori consapevoli che essi lo fanno.
Social Network: Il 76% degli studenti ha già un profilo Facebook e/o usa Instagram; Il 51 % dei genitori sa che il proprio figlio ha un profilo sui social, ma solo il 6% di essifa controlli specifici. Il 91% dei genitori ha almeno un profilo sui social.
Importanza del cellulare nella vita quotidiana: Per il 84% il cellulare è stato un regalo e il 16% lo ha acquistato da solo; nel 78% dei casi ciò è avvenuto tra i 10 e i 13 anni mentre per il 21% è avvenuto tra i 7 e 9 anni. Il 37% degli studenti dichiara di non pensare di poter vivere senza cellulare.
Comportamenti rischiosi o dannosi: L’uso del cellulare è considerato dannoso dal 59% degli studenti: Il 45% di loro per la frequentazione di siti non adatti o pericolosi o conoscenze con persone pericolose; Il 22% per la propria salute. Ciò nonostante, viene spento durante la notte solo dal 42% dei ragazzi e solo il 44% lo spegne durante lo svolgimento dei compiti scolastici. Il 26% degli studenti si dichiara infine favorevole a proibire l’uso del cellulare ai minori di 14 anni.»
Stamattina sono tornato a scuola e sono contento assai perché insieme a Vito ho parlato con i ragazzi delle cose che avevano fatto, del contesto nel quale sono inserite, delle cose che vorremmo continuare a fare assieme a loro.
Naturalmente avendo dovuto parlare molto io – però non sempre io, perché comunque mi sono fatto raccontare un po’ di cose da loro, che come sai non è mica facile – ti faccio qui solo una super sintesi delle tre cose che ho detto: 1. quando fai una cosa, qualunque cosa fai, quella cosa ha senso solo se la fai bene; 2. le tecnologie, tutte le tecnologie, non sono nè buone e nè cattive, possono essere usate in maniera giusta o sbagliata ed è questo che fa la differenza; 3. per usare bene le tecnologie, tutte le tecnologie, bisogna farlo in maniera consapevole, non bisogna accontentarsi di sapere «come» fare le cose ma chiedersi anche il «perché» farle.
Come dici? Sono stato in classe quasi due ore per dire solo queste tre cose? Si, perché ho fatto mille esempi – il martello, la leva, la bomba atomica, l’ago, il telofono, skype, il pane, Maradona, Michael Jordan, la pasta e patate, i lacci delle scarpe e tanto altro ancora – perché ci vogliono mille esempi se vuoi dire ai ragazzi che non solo si può imparare a fare bene le cose e a utilizzare in maniera consapevole le tecnologie, ma ci si può abituare a farle così, proprio come ci siamo abituati ad allacciare le scarpe o ad abbottonare la camicia nel modo giusto.
Adesso non mi chiedere dei risultati perché io non sono Batman e il prof. Russoniello non è Superman, per i risultati ci vuole tempo, però un’impressione te la posso dire, che poi magari te la confermo tra una settimana quando ci ritorno, e insomma la mia impressione è che le/i ragazze/i si sono incuriositi, ma sì, almeno un po’ gli siamo piaciuti. Perché poi io come sai sono anche fortunato, e così tra tutte le possibilità che c’erano ho scelto di commentare proprio la frase della mamma di Francesca, che ha scritto: «da quando c’è la tecnologia non si dialoga più».
Come dici? Ho spiegato che non è vero? Niente affatto. Ho fatto l’esempio di un ragazzo e di una ragazza seduti su un muretto che aspettavano l’autobus e ognuno di loro scriveva con il suo smartphone. Ho aggiunto che ho detto al ragazzo «Antonio, ma c’è questa bella ragazza seduta accanto a te e tu ti metti a chattare?» e che lui mi ha risposto «prof., ma io sto chattando con lei». E poi ho fatto l’esempio di quando sono andato a Tokyo la prima volta, nel 1989, e parlavo con la famiglia a casa un paio di minuti, solo via voce, pagando. E di quando ci sono tornato nel 2007 e parlavo mezzora, in video, via Skype, senza spendere un centesimo.
Vuoi sapere come è andata a finire, mio caro Diario? Che quando ho detto a Francesca che deve dire alla mamma che la prossima volta che vuole esprimere quel pensiero lì, proprio quello che ha espresso – che poi possiamo discutere se ci piace o meno ma questo è un altro discorso – non deve scrivere «da quando c’è la tecnologia non si dialoga più», ma deve scrivere «da quando usiamo in questo modo le tecnologie digitali non si dialoga più». Si, questo non ho paura di dirlo, hanno capito tutte/i, anche perché prima quando avevo chiesto che alzasse la mano chi pensava che se con un coltello faccio male a una persona la colpa è del coltello la mano non l’ha alzata nessuno, perché si, era evidente a tutte/i che la colpa era mia che l’avevo usato in quella maniera orribile.
Ecco, potrei anche fermarmi qui, però mentre tornavamo a casa in auto il prof. Russoniello mi ha raccontato una cosa che mi ha fatto così tanto piacere che la voglio raccontare anche a te. Mi ha detto che ieri ha fatto l’esame per l’immissione in ruolo – e noi naturalmente speriamo che se la cava – e che una delle domande a risposta libera chiedeva di simulare un’azione formativa che coinvolgesse i ragazzi e in qualche modo facesse da contrasto all’abbandono scolastico. «Sai Vincenzo cosa ho proposto? – mi ha detto -.» «No!» «Un progetto intitolato Per un uso civico delle tecnologie. Ho spiegato le varie fasi, prendendo spunto dal lavoro che abbiamo fatto in classe, ho motivato le ragioni del coinvolgimento dei ragazzi, ho scritto che questo approccio consapevole alle tecnologie, questa cultura del lavoro ben fatto li avrebbe sicuramente aiutati a dare più senso anche allo studio e alla nostra comunità scolastica. Che dici Vincenzo, ti sembra una buona proposta?». «Buona? A me sembra bellissima. Facciamo così, appena puoi fermati al bar che ti voglio offrire un caffè e una sfogliatella.»
In un certo senso è un ossimoro, nel senso che non si può dire «vado per la prima volta nel paese in cui sono nato», se sei nato lì ci sei stato, è per definizione il primo posto in cui sei stato, però la verità resta che a Cotronei, sulla Sila – al tempo provincia di Catanzaro oggi provincia di Crotone – io ci sono nato eppure ci vado per la prima volta tra due giorni, il primo aprile, a 60, 6 mesi e 20 giorni compiuti.
Non so quante persone abbiano avuto un’esperienza come questa, soprattutto non so come l’hanno vissuta, provo a raccontare come l’ho vissuta io, sperando che vi piaccia.
Per prima cosa voglio dire che tra gli ultimi anni cinquanta e i primissimi anni 60 nelle famiglie come la mia alcune cose c’erano e altre invece no.
Tra le cose che c’erano alcune non sono state importanti, sono state decisive, scrivo solo le parole che per ciascuna di loro si potrebbe scrivere un libro: amore, famiglia, onestà, educazione, lavoro, scuola, rispetto, solidarietà, amicizia.
Tra le cose che non c’erano – naturalmente non proprio del tutto, ma quasi – alcune sarebbe state meglio averne di più ma anche senza poi non è che chissà quanto ci abbiamo sofferto – soprattutto io e Antonio, i due più grandi, che quando sono arrivati Gaetano e soprattutto Nunzia le cose almeno in parte erano già un poco migliorate -, e comunque sia chiaro che i nostri meravigliosi genitori hanno sempre dato tutto per noi ed è anche giusto che alcune delle cose che mancavano in casa poi ce le portassimo noi. Per darvi un’idea tra i miei ricordi c’è la casa di via Savatore Girardi n°1 , una traversa di corso Secondigliano, una stanza di meno di 20 metri quadri gabinetto compreso dove oltre a papà, a mamma a me e ad Antonio è vissuta per qualche anno, fino alla sua morte, zia Giovannina, che immagino fosse zia di mio padre ma non ne sono sicuro. Poi ci sono stati gli anni della casa di via Cupa dell’Arco 41, di fronte al campo di calcio, sempre una sola stanza però più grande con n bagnetto dove è nato Gaetano, dicembre 1962, e dove credo siamo restati fino al 64-65, prima di trasferirci nel nostro primo quartino (appartamento con più stanze) prima nel palazzo Limone, di fianco al cinema Arcobaleno, e poi al corso d’Italia, sempre a Secondigliano. Ricordo i cappottini che passavano dai miei cugini più grandi a me e poi ad Antonio, ricordo che non c’erano libri in casa, o dischi, per i primi anni neanche la televisione, e che c’erano poche foto e persino pochi ricordi, nel senso che non si riusciva mai a sapere con precisione quando era accaduta una cosa, tipo a che ora precisa sono nato, perché zio Peppino era andato a fare il soldato in Africa e dove precisamente aveva prestato servizio, in che giorno era nata mia madre (si, lo giuro), in che giorno si erano sposati papà e mamma (mai saputo), insomma i nostri ricordi di famiglia sono stati sempre avvolti nella nebbia, come se ci fosse poco o nulla da ricordare.
Detto con la mano sul cuore, perché è la verità, che non ricordo mai che mi sia mancato nulla, che sono cresciuto felice con i miei cugini, mio fratello e miei amici senza avvertire complessi, difficoltà, problemi di alcun tipo, nemmeno di essere così lungo e secco perché tanto tutti avevamo un soprannome o un difetto, aggiungo che da grande – nel senso di adulto – mi sono fatto l’idea che questa scarsità – mancanza di ricordi fosse dovuta a due fattori, in parte l’ignoranza che ti faceva dare scarso valore alla memoria, in parte alla voglia di lasciarsi il passato alle spalle, di migliorarsi, di guardare al futuro.
E’ in questo contesto che è nato e cresciuto il mio rapporto con Cotronei. Perché si, è inutile che la fate troppo facile, da un lato io sono napoletanto, di più, Napoli la tengo nel sangue, “mi sono” coltivato la mia lingua nativa molti decenni prima che fosse riconosciuta dall’Unesco, mi sono curato i ricordi, i modi di dire, le espressioni, e ancora oggi anche nelle occasioni più impegnative una parola in napoletano ce la devo mettere per forza; dall’altro il fatto di essere nato a Cotronei non è uno di quei fatti che puoi considerare ininfluenti, almeno per me non lo è stato. Non è questione di anagrafe, di documenti, di stare lì a spiegare che la «R» di Cotronei sta dopo la «T» mentre quella di Crotone sta dopo la «C», che ci voleva pure il cambio di provincia a complicare le cose. E’ questione che il fatto di essere nato in un posto ti lega per sempre a quel posto, almeno per me è stato così, e anche se tu te ne volessi scordare ci pensano le cose della vita a ricordatelo. Come dite? Faccio degli esempi? Come no, posso scegliere fra tanti.
Il tifo calcistico per il Catanzaro quando ero ragazzino insieme a quello per lo squadrone di Serie A, la felicità quando il Catanzaro è salito nella massima serie, le imprese di Palanca.
L’orgoglio quando nel 1980 mi arriva a casa – pochi giorni dopo la mai richiesta – l’estratto di nascita necessario per sposarmi che ancora più della gentilezza e del biglietto di auguri mi aveva colpito l’efficienza del «mio» comune.
La soddisfazione di leggere sull’Unità, un paio di anni dopo, mentre il «mio» PCI, quello di Berlinguer, stava cominciando a cedere pesantemente terreno al PSI di Craxi, che nella «mia» Cotronei avevamo vinto con oltre il 50 percento dei voti. Ricordo che inviai anche un telegramma di felicitazioni al Sindaco di allora.
La gioia che ho provato ogni volta in cui ho potuto dire a un amica o a un amico «sono nato in Calabria, a Cotronei» e la complicità che questa cosa determinava, due esempi per tutti quello di Santina – vecchia amica – e di Rita – amica nuova.
L’iscrizione a un gruppo locale su Facebook, uno dei tantissimi di questo tipo, Sei di Cotronei se, perché volevo cercare una storia di #lavorobenfatto «mio» paese, che mi faceva brutto che tra le tante che avevo raccontato non ce ne fosse una di Cotronei, e infatti l’ho trovata, è quella di Adolfo Grassi, che è solo la prima, e se volete potete leggerla qui. Insomma io, napoletano nel daimon, nell’anima, nella streppegna, Cotronei l’ho tenuta sempre con me, ma «overo», non tanto per dire.
Vengo alla storia recente, che questo post sta diventando un romanzo. Dovete sapere che prima mio fratello Gaetano e poi mia sorella Nunzia avevano avviato un prezioso recupero delle poche e sgangherate foto di famiglia. Va bene, non è stato un processo di digitalizzazione vero e proprio – e quanto siete impicciosi, mamma mia – le avevano fotografate, però questo aveva fatto sì che le potessimo condividere, tenere con noi, farle girare. In particolare Nunzia me ne aveva mandate un bel po’ e tra queste ce n’era una in cui nostra madre giovanissima teneva un bimbo piccolo in braccio su un balconcino.
Ora come vi ho detto in queste materie, cose di famiglia precise precise non ce ne sono, dunque sulla foto niente data, niente luogo, niente. Era evidente che in braccio a mamma potevamo essere o io o mio fratello Antonio, più io che lui, e che era molto probabile che quella fosse Cotronei, ma come è evidente probabile non vuol dire sicuro, potevamo stare anche da qualche altra parte. Così una sera posto la foto che Nunzia mi aveva mandato nel gruppo di Cotronei chiedo se per caso qualcuno riconosce il posto, se insomma la foto è stata scattata a Cotronei, spiegando che sono nato lì eccetera eccetera. Tra i primi a rispondere e a confermarmi il tutto c’è Nicola Fabiano, che non contento della risposta comincia a chiedere in giro e mi scrive che ci sono persone che si ricordano ancora dei nostri genitori, che se vado ci possiamo parlare, che insomma adesso è davvero il tempo che io e Cotronei ci incontriamo.
Nei mesi successivi accadono un sacco di altre belle cose, scopro che il cantante degli Aerosmith ha i nonni di Cotronei, che è stato lì e forse ci ritorna per un concerto, ma questo forse l’avete già letto nel racconto di Adolfo. E poi Nicola mi fa chiamare dal Sindaco di Cotronei a Natale e ci scambiamo gli auguri. E poi un venerdì di un paio di mesi fa lo incontro con Cinzia a Napoli insieme al suo figliolo e finalmente possiamo abbracciarci e stringerci la mano, ma adesso mi fermo qui, tanto in questi giorni avrò modo di ritornarci su. Perché si, ve l’ho detto, io domani vado, se volete venire con me non vi perdete i prossimi racconti.

di Dunia Pepe
Ciao Vincenzo, continuo a seguire i temi trattati nelle tue rubriche e, tra gli altri, quello interessantissimo “Tutto il FabLab Napoli minuto per minuto”. Mi sembra particolarmente significativo seguire la narrazione di questo corso per giovani artigiani digitali con le testimonianze dei partecipanti, di coloro che hanno voluto ed ideato il corso, del tuo sguardo attento, delle persone esterne come la signora Veronica Testa che, nei giorni scorsi, ti ha scritto per raccontarti del suo perspicace figliolo il quale, come regalo per il suo settimo compleanno, ha chiesto proprio una stampante 3D.
Per ciò che riguarda le tematiche legate ai giovani, alle loro possibilità di occupazione, alla rinascita dell’artigianato in formato digitale come nuova possibilità di lavoro mi viene in mente un tema per molti aspetti parallelo e fortemente significativo. Da un lato, come tu stesso racconti nel tuo blog, si incoraggia la promozione del mestiere artigiano presso i giovani con la straordinaria innovazione legata all’utilizzo del digitale, delle stampanti 3D, della robotica. D’altra parte, qualcuno si sta occupando di recuperare degli spazi inutilizzati per la crescita del lavoro giovanile ed anche per la promozione di questi nuovi lavori.
Questo mi sembra, come ti ho detto, un tema significativo e mi viene in mente, in particolare, la figura ed il lavoro di Giovanni Campagnoli. Giovanni Campagnoli, che ho la fortuna di conoscere, si occupa dello sviluppo di politiche giovanili. Grazie ai suoi studi, alle sue ricerche ed al sito http://www.riusiamolitalia.it che cura insieme a Roberto Tognetti, Giovanni si interroga su come i tanti spazi inutilizzati e spesso dimenticati, sparsi nei nostri territori, potrebbero essere riportati a nuova vita soprattutto grazie alla creazione di start up giovanili di portata innovativa.
“Per la prima volta, scrive Giovanni Campagnoli nella Premessa del suo libro pubblicato nel 2014, Riusiamo l’Italia, i territori vivono un fenomeno nuovo, quello di trovarsi ‘pieni di vuoti’: significa cioè che sono diventati molti i luoghi abbandonati quali ex scuole, caserme, fabbriche e capannoni industriali dismessi, cinema chiusi, stazioni, negozi, abitazioni, uffici vuoti, così come gli spazi finiti e mai aperti… Tutti questi luoghi non abitati dalle persone pongono la questione di individuare nuove funzioni d’uso e nuove progettazioni. La sfida è ricercare le condizioni affinché questi spazi tornino ad essere luoghi significativi per la comunità locale, per farne occasioni di sviluppo a partire dai giovani. L’ipotesi è che questi spazi possano essere riempiti di talento, competenze, intelligenze, passioni e che, con anche un po’ di coraggio, questi luoghi diventino dei laboratori di innovazione sociale”. Possono nascere così nuovi spazi aperti non solo ai nuovi lavori, alle nuove sfide, ma anche ad un rinnovato rapporto con i territori che essi stessi contribuiscono a rivitalizzare.
Ispirandosi alla teoria della ‘Coda lunga’, formulata da Chris Anderson nel 2004, Campagnoli spiega come i nuovi lavori legati soprattutto alle dimensione del web segnino il passaggio ‘da un mercato di massa ad una massa di mercati’. Ne consegue che i nuovi lavori di contenuto innovativo finiscano per occupare molte nicchie di mercato anche se a numerosità ridotta, mentre i lavori tradizionali tendono sempre più a concentrarsi in un numero ridotto. Secondo le parole usate dallo stesso Campagnoli, in una situazione difficile come quella attuale “ripartire dalla cultura e dalle nuove generazioni può essere una potente misura ‘anticiclica’, capace di invertire il trend negativo della fase recessiva caratterizzato dalla diffusione di una forte sfiducia proprio nel futuro”. Il riutilizzo dei luoghi abbandonati, l’apertura di nuovi spazi, la creazione di lavori innovativi non solo aprono tante possibilità di lavoro anche se all’interno di piccole nicchie di mercato, ma segnano una rinnovata fiducia per i giovani di rientrare nel mercato del lavoro così come nel ciclo di vita dell’economia e della realtà storico-sociale.
I protagonisti di questa nuova economia dunque sono proprio i giovani. Giovani che promuovono l’economia della conoscenza, collaborano nei co-working e nei FabLab, “creano start up innovative – ci suggerisce lo stesso Campagnoli – di valore sociale e/o culturale, educativo, artistico, o relativo agli ambiti dei servizi al turismo e valorizzazione ambientale, sport, comunicazione e informazione, green economy”.
Nel sito www.riusiamolitalia.it Giovanni Campagnoli raccoglie e racconta diverse buone pratiche già presenti nel territorio italiano. Così, egli racconta, in Puglia, il trinomio giovani, start up e spazi è alla base del successo dell’azione Laboratori Urbani, nell’ambito del Programma Regionale ‘Bollenti Spiriti’. “Si tratta del recupero di 151 ‘vecchi edifici per giovani idee’: immobili dismessi di proprietà dei Comuni pugliesi recuperati per diventare nuovi spazi pubblici per i giovani, spazi dedicati all’arte e allo spettacolo; luoghi di uso sociale e sperimentazione delle nuove tecnologie; servizi per il lavoro, la formazione e l’imprenditorialità giovanile; spazi espositivi, di socializzazione e di ospitalità”.
Infine Vincenzo, ci tengo a farti notare che tra le diverse best practices, presentate nel sito http://www.riusiamolitalia.it/ita/best_practices.asp, compare anche l’esperienza ‘Il Cantiere’ nata a Frattamaggiore nel 2003. In un contesto interessato per lunghi anni da un notevole degrado, ‘Il Cantiere’ offre diversi servizi di grande utilità rivolti soprattutto ai giovani e riguardanti sia le informazioni, l’orientamento per il lavoro e la formazione; sia corsi e laboratori anche di natura innovativa.
di Veronica Testa
Buongiorno Prof! Finalmente sono riuscita a leggere con calma tutto il post del FabLab Napoli! Interessantissimo, anche se di progettazione non è che ho capito granché, ma quello è un problema mio, quando si parla di cose troppo tecniche e ci si aggiungono i numeri, il mio cervello reagisce chiudendosi! Prof. ma mica me lo possono realizzare un timbro con la scritta “la cantina 1959”? A mie spese, ovvio! Comunque se si fa un nuovo corso mi prenoto! Ah, volevo anche dirle che mio figlio, che si chiama Riccardo come il suo, da qualche mese insiste che per il suo settimo compleanno vuole a tutti costi una stampante 3D. Quando me l’ha detto io mica sapevo nel dettaglio cos’era questa stampante 3D, certo, per sommi capi si, ma poi me l’ha spiegato lui nei minimi particolari e francamente non so dove l’abbia imparato!
La stampante non gliela comprerò, almeno per ora, ma a questo punto gli farò seguire la storia del fablab, minuto per minuto!
Buona domenica.
di Dunia Pepe, Ricercatrice Isfol
ciao Vincenzo, il tema su cui state lavorando è di estremo interesse per poter comprendere le nuove possibilità di accesso al mondo del lavoro, da parte della popolazione giovanile, ed i modi in cui tale accesso può avvenire. Ti invio alcune riflessioni, su questo tema, che nascono sia dalla ricerca Isfol su “Innovazione e transizioni verso il lavoro” che dagli attuali dibattiti sul tema dell’occupabilità giovanile e sulla formazione ai nuovi lavori.
L’emergenza del fenomeno dei FabLab o Laboratori di Artigianato Digitale rappresenta un esempio estremamente significativo ed originale di crescita dell’occupazione soprattutto giovanile.
Il primo FabLab nasce nel 2001, all’MIT, come un normale corso universitario. A seguito del suo successo, Neil Gershenfeld apre il laboratorio al di fuori degli orari di università ed al pubblico esterno. La specificità di un FabLab sta nel fatto che alla produzione artigianale tradizionale si aggiunge la portata innovativa legata all’utilizzo delle nuove tecnologie ed al patrimonio di saperi e di competenze della knowledge society. I macchinari a disposizione di un FabLab sono stampanti 3D, frese a controllo numerico (CNC), laser cutter, materie prime di ogni tipo, strumenti di falegnameria, di meccanica e per la lavorazione dei metalli, schede elettroniche e microprocessori come Arduino.
I makers costruiscono oggetti attraverso la manualità, la tecnologia, la collaborazione, il design, la sostenibilità, lo scambio di conoscenze e strumenti con il territorio. Sono organizzati in comunità virtuali e fisiche e, nonostante la crisi degli ultimi anni, sono cresciuti ed hanno creato impresa. I FabLab sono luoghi dove è possibile costruire (quasi) qualsiasi cosa: da un disegno CAD è possibile fabbricare un oggetto, mentre per il passaggio inverso occorre uno scanner 3D che converta forme tridimensionali in dati esportabili anche attraverso Internet.
Nonostante siano laboratori ad alto contenuto tecnologico, i FabLab si basano prima di tutto sulle persone: condividere idee, progetti, prototipi e know-how è il fulcro dei centri di manifattura digitale. La costituzione di un FabLab è regolata da quattro caratteristiche fondamentali: accesso pubblico; sottoscrizione della FabLab Charter; condivisione di software e hardware open source; partecipazione ad un network globale e collaborazione senza confini. Proprio grazie a questi principi i makers mettono in rete i progressi delle loro conoscenze e delle loro pratiche al fine di migliorarle sempre di più in una logica adattiva e evolutiva.
La rete Isfol su “Innovazione, inclusione e transizioni verso il lavoro” presenta in particolare due Laboratori operanti a Roma, Roma Makers e Fab Lab SPQwoRk, volti a favorire e stimolare la cultura della fabbricazione digitale, a diffondere nel tessuto artigianale e imprenditoriale del Lazio i principi dell’innovazione tecnologica.
Il primo FabLab di Roma è stato Roma Makers ed è nato, nel 2013, in un quartiere simbolo della rinascita urbanistica della capitale: La Garbatella. In collaborazione con scuole, università ed istituzioni pubbliche, come il Comune di Roma, l’Associazione è impegnata in numerosi progetti di formazione e supporto indirizzati ai bambini, studenti universitari, tirocinanti, disoccupati in cerca di lavoro e di nuove qualifiche, professionisti, artigiani, imprenditori, comuni cittadini. Grazie ad una tessera annuale qualsiasi persona può partecipare alle attività di Roma Makers utilizzando le macchine su appuntamento, prendendo parte a seminari sulle attrezzature, sui progetti e sui prototipi del FabLab. Nel Marzo 2015, l’Istituto olandese Waag Society ha inaugurato un corso di biologia molecolare presso Roma Makers oltre che nei laboratori di altri paesi europei, del Brasile e degli Stati Uniti. In questo corso, gli studenti utilizzano organismi naturali e non patogeni – cellulosa, alga spirulina, penicillina, fermenti lattici e acido citrico – per costruire macchine che consentano la produzione artigianale di materiali quali carburante, materiali compositi, filamenti per tessile e molte altre molecole bio-attive per profumi, farmaci, inchiostri e pigmenti.
SPQwoRk Factory sorge in un complesso di archeologia industriale del secondo dopo guerra, ex sede del Pastificio Scanzani. Nato nel 2011, a quattro anni dall’apertura, SPQwoRk Factory rappresenta il centro delle attività culturali, innovative, tecnologiche e del design di Roma Tiburtina, sviluppandosi su circa 1.200 mq ed ospitando aree coworking, fablab e wetlab, ed una community di quasi 100 persone tra freelancer e società. SPQwoRk Factory è una realtà dove nascono sinergie, è possibile trovare nuovi stimoli, essere aggiornati sulle tendenze di mercato e sulle nuove tecnologie grazie ai numerosi corsi, eventi a tema, workshop che si organizzano durante tutto l’anno.
SPQwoRk Factory si impone sullo scenario romano come nuova tipologia di centro di lavoro, luogo dove si ha la possibilità di sviluppare progetti, realizzare prototipi avvalendosi di moderne tecnologie quali stampe 3D, taglio laser, solo per citarne alcune, avviare imprese, fondare start up, trovare competenze complementari alla propria. La condivisione degli spazi consente ai giovani imprenditori di ridurre i costi ed incrementare il proprio lavoro grazie alla contaminazione ed alla molteplicità delle risorse disponibili. Il coworking prevede anche un servizio di incubazione delle start up e di aiuto al finanziamento attraverso il crowdfunding.
Una questione cruciale riguarda quali modelli di formazione e di professionalizzazione possono essere adeguati a questi modelli e contesti di lavoro così innovativi come lo sono FabLab, co-working, incubatori ed acceleratori di idee e di imprese, start-up, occupazioni legate alla prototipizzazione ed alla digitalizzazione. Sicuramente, in questi contesti, il percorso della formazione non è lineare ma è al tempo stesso risultato di conoscenze teoriche e di apprendimenti hands-on, di esperienze e di competenze digitali. Nei sistemi caratterizzati da innovazione distribuita e cultura open hanno valore le competenze teoriche ed operative, il connubio tra sapere e manualità, le competenze informali e non-formali, la crescita dell’intelligenza collettiva, le capacità di programmazione e di gestione.
Queste realtà lavorative caratteristiche dell’universo giovanile che prendiamo in considerazione non solo danno vita a nuova conoscenza e formazione, ma stimolano anche la nascita di un nuovo spirito imprenditoriale, forniscono stimoli per la crescita dei territori offrendo spesso la possibilità di riusare spazi inutilizzati creando nuovo valore produttivo ed economico. Molto spesso questi luoghi mettono insieme non solo simbolicamente passato e futuro, sogni e realtà, giovani ed adulti.
Così l’incubatore di start up giovanili Luiss EnLabs situato non casualmente dentro la Stazione Termini. La grande Stazione della Capitale, luogo di incontri, di partenze, di nascita di nuove speranze, è diventata con Luiss EnLabs anche un luogo dove fare ripartire le idee, le speranze ed il lavoro dei giovani. Si pensi ancora a Human Farm che sulla laguna veneta mette insieme il passato contadino con il futuro digitale per lo sviluppo delle start up giovanili.
E’ altresì significativo citare “Le palestre dell’innovazione” attraverso le quali Fondazione Mondo Digitale, in collaborazione con Google, sta formando a Roma diverse migliaia di giovani alle competenze ed all’artigianato digitale. L’obiettivo è dare la possibilità ai ragazzi di acquisire non solo competenze adeguate ai lavori del futuro, ma anche competenze di flessibilità, apertura, responsabilità, competenze adeguate ai rapidi e difficili cambiamenti del vivere sociale nella nostra epoca. Qui, come sostiene il Direttore di FMD Alfonso Molina, i giovani imparano grazie ai rapporti con i docenti, gli altri giovani, gli adulti, la scuola, gli antichi mestieri, il futuro digitale, il territorio.
Bibliografia e sitografia
M. Bezzi (2015), “8 esempi per spiegare come i FabLab reinventano i paradigmi di lavoro e formazione”, Il Sole 24ore, 13 luglio
G. Campagnoli (2015), Riusiamo l’Italia: da spazi vuoti a start up culturali e sociali, Il Sole 24ore, Milano
A. Molina (2015), “Presentazione dei primi sei mesi di attività dell’Officina dei nuovi lavori”, Roma, 6 ottobre
D. Pepe e Casentini P. “Innovazione, inclusione e transizioni verso il lavoro”, Portlet Isfol accessibile al sito
R. Pistagni (2015), “Partire dalla domanda per migliorare l’offerta: la parola ai Makers” in Osservatorio Isfol, n. 1-2/2015, pp. 143-162.